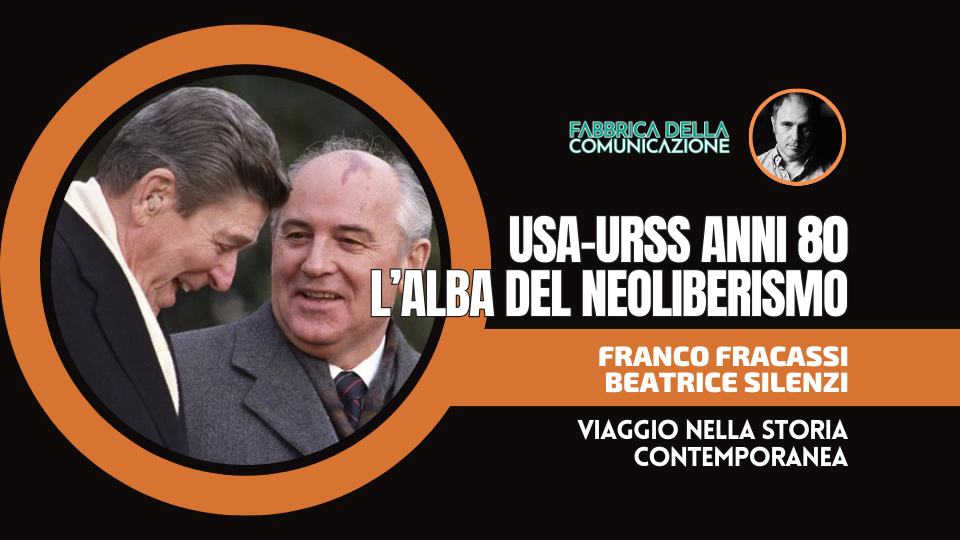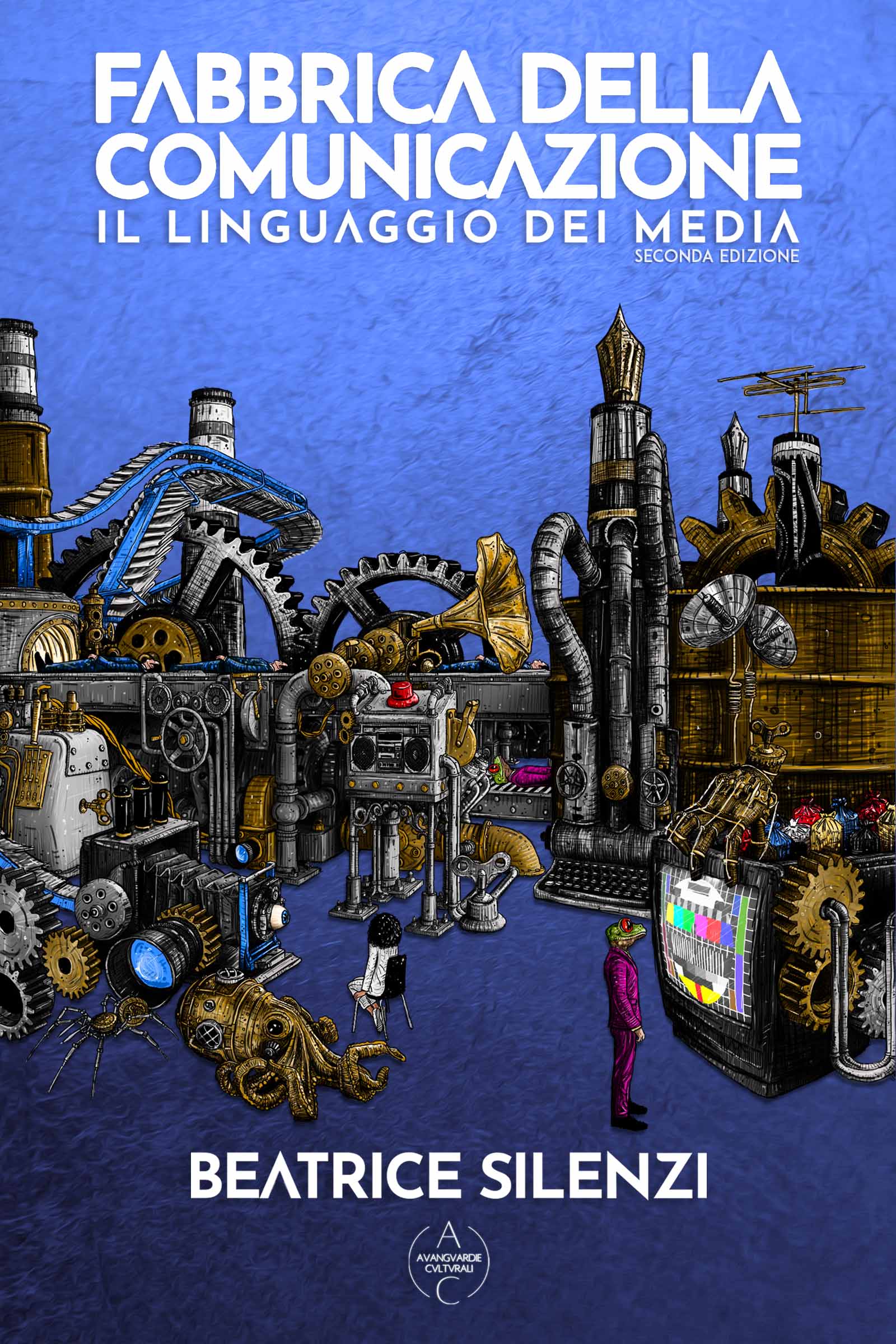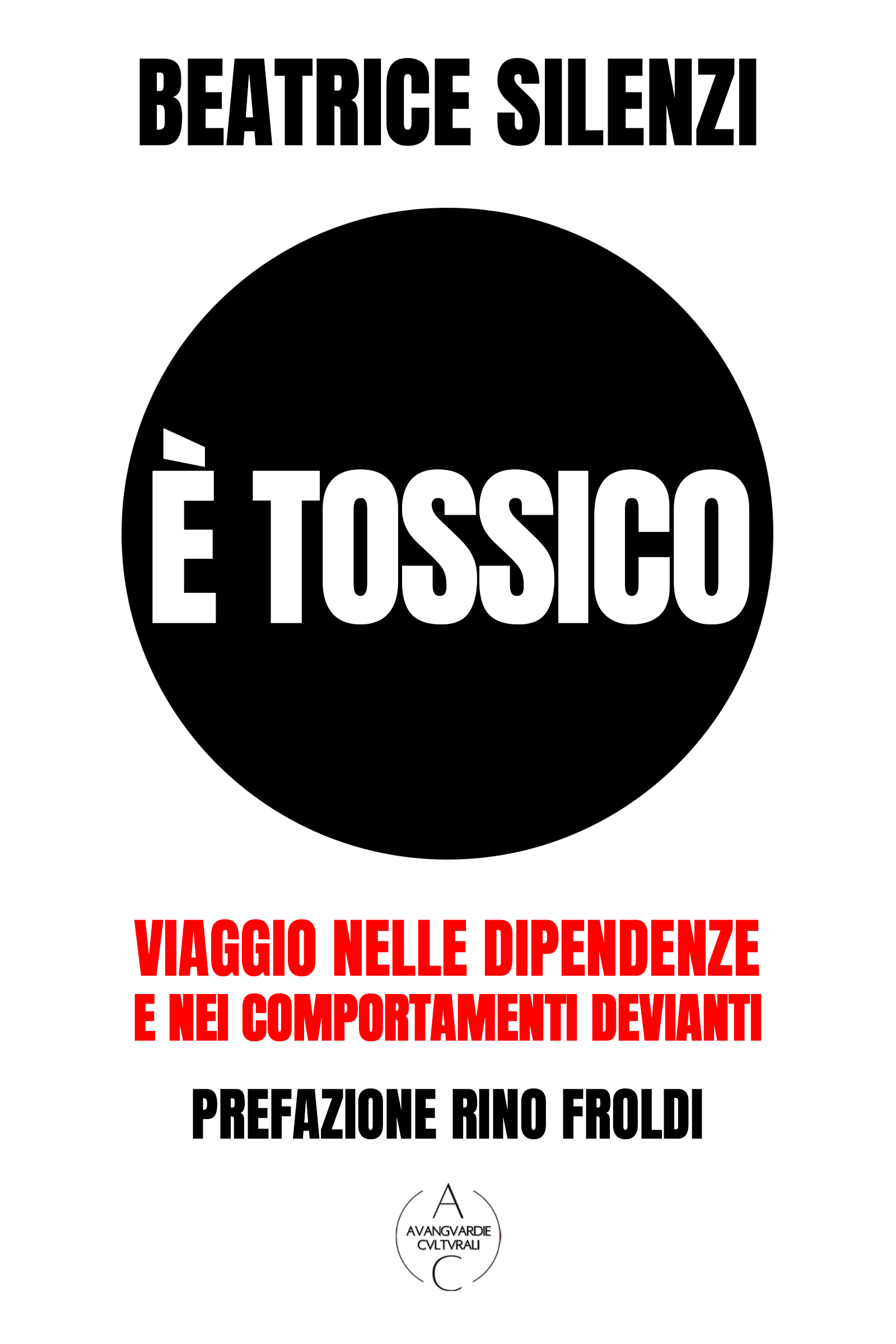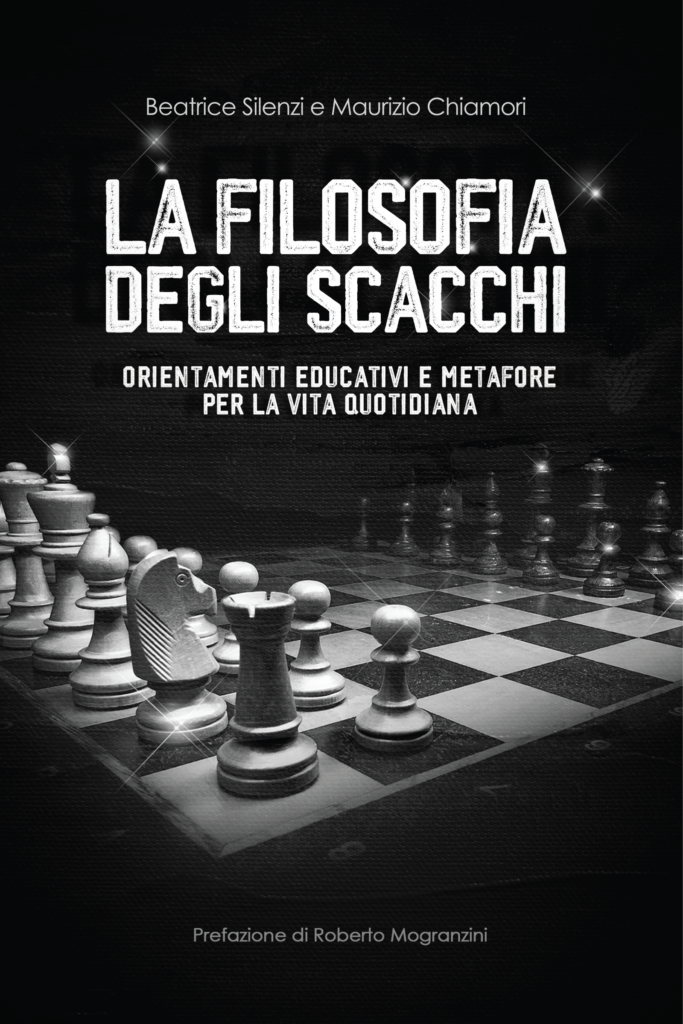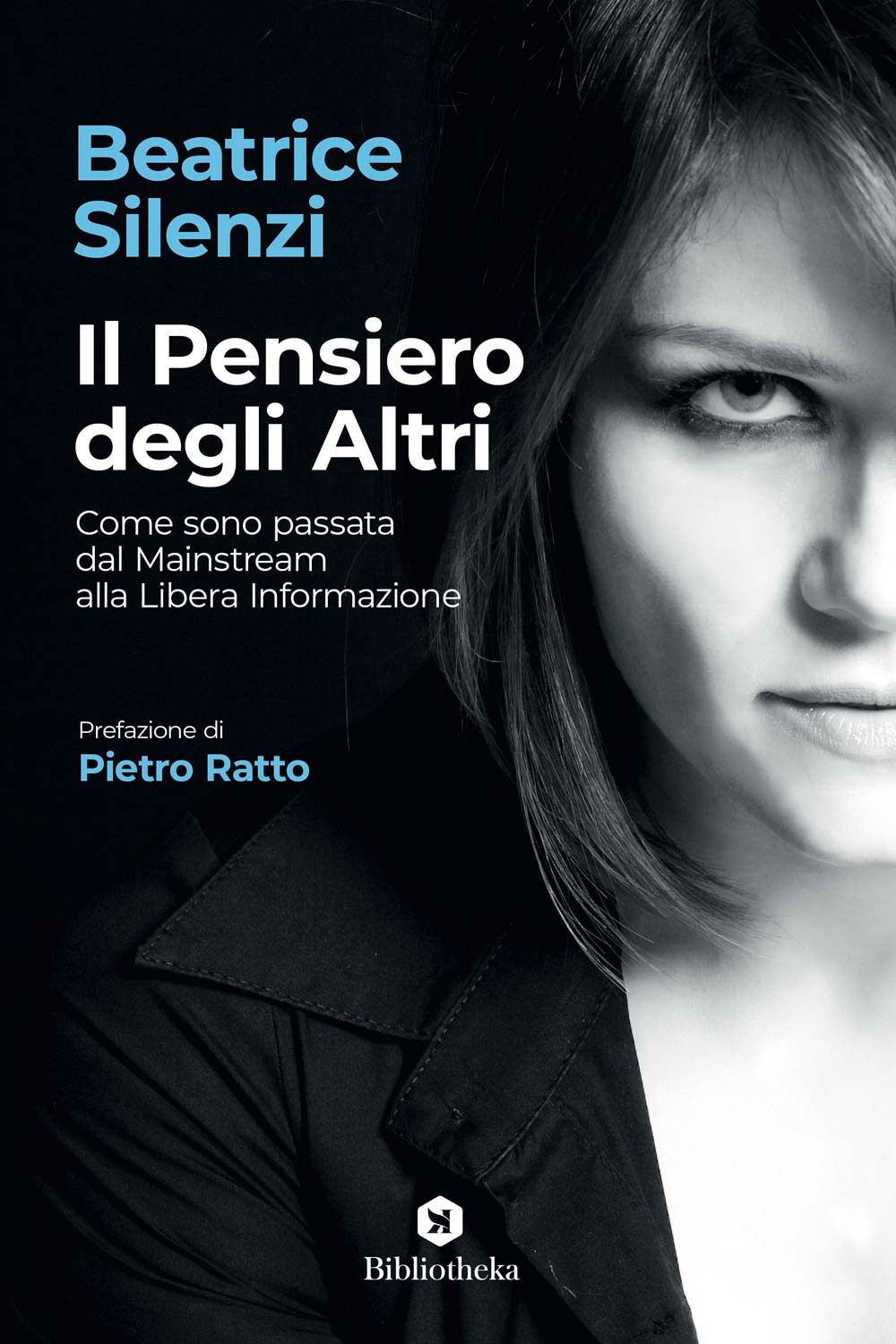Clicca per guardare il video
La rubrica Viaggio nella Storia Contemporanea è a cura dello scrittore e giornalista d’inchiesta Franco Fracassi e Beatrice Silenzi, direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
Gli Anni ’80: Con la nascita del Neoliberismo Tra Sogno Americano e Contraddizioni Globali
Gli anni Ottanta, spesso ricordati con una patina di nostalgia edulcorata, sono stati in realtà un decennio di profonde trasformazioni, ribaltamenti narrativi e cambiamenti radicali che hanno gettato le basi per molte delle dinamiche che ancora oggi viviamo.
Lungi dall’essere solo l’epoca spensierata della moda e della musica pop, gli anni ’80 hanno rappresentato un crocevia politico, economico e culturale che ha ridefinito il mondo occidentale e i suoi rapporti globali.
Il panorama politico internazionale di quel decennio era dominato da due figure iconiche: Ronald Reagan negli Stati Uniti e Michail Gorbaciov nell’Unione Sovietica.
Un parallelismo evocativo viene tracciato con il film “Rocky IV”, dove la rappresentazione di un Occidente “umano” e “povero di tecnologia” si contrapponeva a un blocco sovietico “alieno” e “ipertecnologico” incarnato dal pugile Ivan Drago.
Questa narrazione, come sottolinea Fracassi, era l’esatto opposto della realtà. Erano gli occidentali a essere all’avanguardia tecnologica, mentre i sovietici erano ben più “ruspanti”.
Questo ribaltamento della realtà fu una costante della propaganda dell’epoca, simile a quanto accade anche oggi con attribuzioni di responsabilità che spesso contraddicono i fatti.
Gli anni ’80 hanno visto l’affermazione di una filosofia economica e sociale che prometteva benessere diffuso attraverso l’arricchimento dei più facoltosi, la cosiddetta “Reaganomics”: l’idea era che “dando più soldi ai ricchi sarebbero arrivati i soldi anche ai poveri”, ma l’esito fu l’esatto contrario.
Il decennio si chiuse con il “Black Monday” del 1987, un crollo borsistico rovinoso, scandali finanziari a Wall Street e l’inizio di una sperequazione sociale senza precedenti, dove la forbice tra ricchi e poveri si allargò vertiginosamente.
Culturalmente, gli anni ’80 furono il decennio dell’apparenza, del denaro come metro di successo e della moda che da effimera divenne quasi un culto. L’esplosione di Wall Street e l’aspirazione al successo finanziario come unico cammino per la libertà e la felicità divennero dogmi. Film come “Il segreto del mio successo” con Michael J. Fox incarnavano questa mentalità, dove l’astuzia e la capacità di “intortare” i ricchi portavano alla realizzazione personale.
Questa corsa all’arricchimento celava spesso una realtà più cupa, fatta di truffe e speculazioni. Il mondo del jet set, descritto da Marina Ripa di Meana nella sua autobiografia, divenne un modello da emulare, promuovendo valori effimeri e talvolta moralmente discutibili che in decenni precedenti sarebbero stati condannati.
Ronald Reagan, 40° Presidente degli Stati Uniti (1981-1989), fu il volto del repubblicanesimo di quegli anni.
Essere repubblicani significava smantellare lo stato sociale e ridurre l’invasività dello Stato. Fino agli anni ’70, l’Occidente aveva costruito un sistema di welfare state impensabile nella storia, anche per contrastare l’ideologia socialista.
Gli anni ’80 demolirono questa immagine, proponendo un “mondo nuovo” all’esatto opposto del precedente.
Lo smantellamento dello stato sociale fu una caratteristica essenziale della politica di Reagan si ispirò a Margaret Thatcher, che in Gran Bretagna aveva anticipato questa tendenza con un approccio più diretto e “con i manganelli”, come ricorda Fracassi, escludendo violentemente dalla società chi non si adeguava alle nuove regole. Reagan, invece, operò attraverso un messaggio culturale, persuadendo la popolazione che i “paletti” ingabbiavano la libertà e che liberarsi significava abbracciare la ricchezza e il “bello” derivante dalle cose costose.
Sul fronte sovietico, Michail Gorbaciov si presentò come il contraltare di Reagan. Paradossalmente, come spesso accade tra figure estreme, Reagan e Gorbaciov riuscirono a dialogare, stringendo trattati storici sulle armi atomiche. Gorbaciov fu il personaggio più “occidentale” che l’Unione Sovietica potesse produrre, capace di sorridere e di badare all’apparenza.
La sua visita a Roma nel 1989 fu un trionfo, accolto come una rockstar. Eppure, in patria, Gorbaciov è ricordato in maniera pessima.
La “glasnost” (trasparenza) e la “perestrojka” (ricostruzione) che in Occidente furono percepite positivamente, per i sovietici rappresentarono lo smantellamento dello Stato e un trauma sociale.
L’Unione Sovietica era allo stremo delle forze, indebolita dalla guerra in Afghanistan, e Gorbaciov tentò di navigare acque tempestose, mostrando al mondo e a se stessi la crisi interna. Il risultato fu uno spappolamento della società che, lungi dall’essere visto come un rinnovamento, fu percepito come un fallimento.
Confrontando il passato con il presente, Fracassi individua alcune concordanze. La capacità di riflettere e agire con logica attraverso la cultura e la conoscenza accomuna personaggi come Gorbaciov e Putin.
Dall’altra parte, l’ignoranza, intesa come scarsa profondità culturale, caratterizzava Reagan – che aveva difficoltà a leggere documenti complessi – e, seppur in modo diverso, anche Trump. La differenza sostanziale è che Reagan era il frontman di un movimento più ampio, mentre Trump è lui stesso il trascinatore e l’impositore di regole.
Il parallelismo tra Reagan attore e Zelensky attore è interessante. Entrambi hanno usato la propria abilità performativa. Zelensky, pur essendo stato inizialmente una “marionetta”, ha poi preso in mano la propria sceneggiatura, diventando un attore che si scrive il proprio ruolo, forte del sostegno popolare e determinato a mantenere il potere attraverso la continuazione del conflitto.
Infine, la discussione si è soffermata sui fenomeni di violenza e sugli attentati, come quello in cui ha perso la vita il consigliere di Trump, Kirk. Fracassi ricorda come la violenza sia sempre esistita, citando tentativi di omicidio contro Trump stesso.
Negli Stati Uniti, la violenza spesso si personifica, abbattendo il simbolo per distruggere il movimento.
Il caso di Kirk è complesso: da fervente conservatore e finanziato da movimenti sionisti, si era allontanato da alcune posizioni, contestando Israele e avendo diverbi con Trump. Questa complessità rende difficile etichettare la sua morte e individuarne i responsabili con certezza, lasciando aperte numerose ipotesi su chi e perché abbia voluto eliminarlo.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.