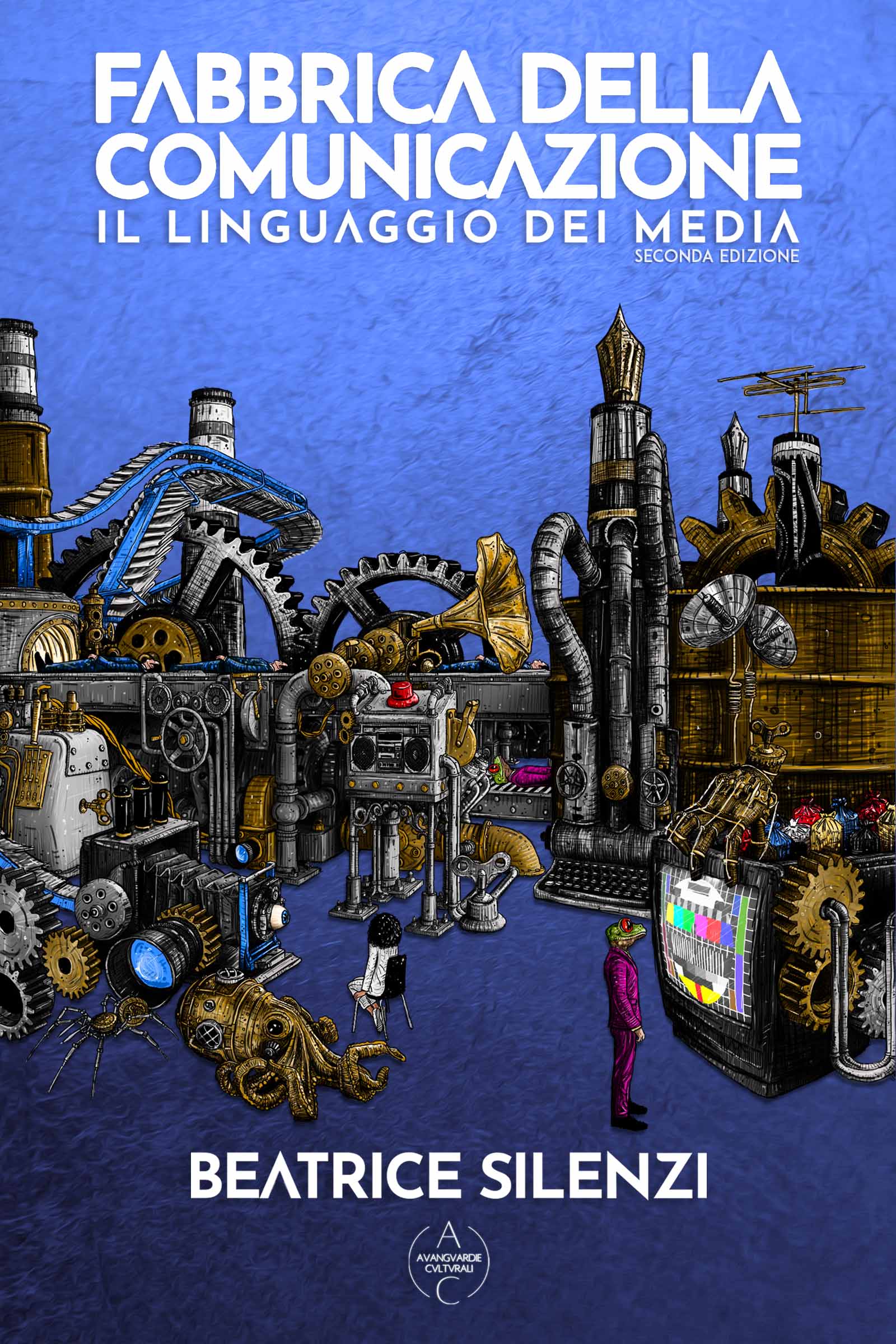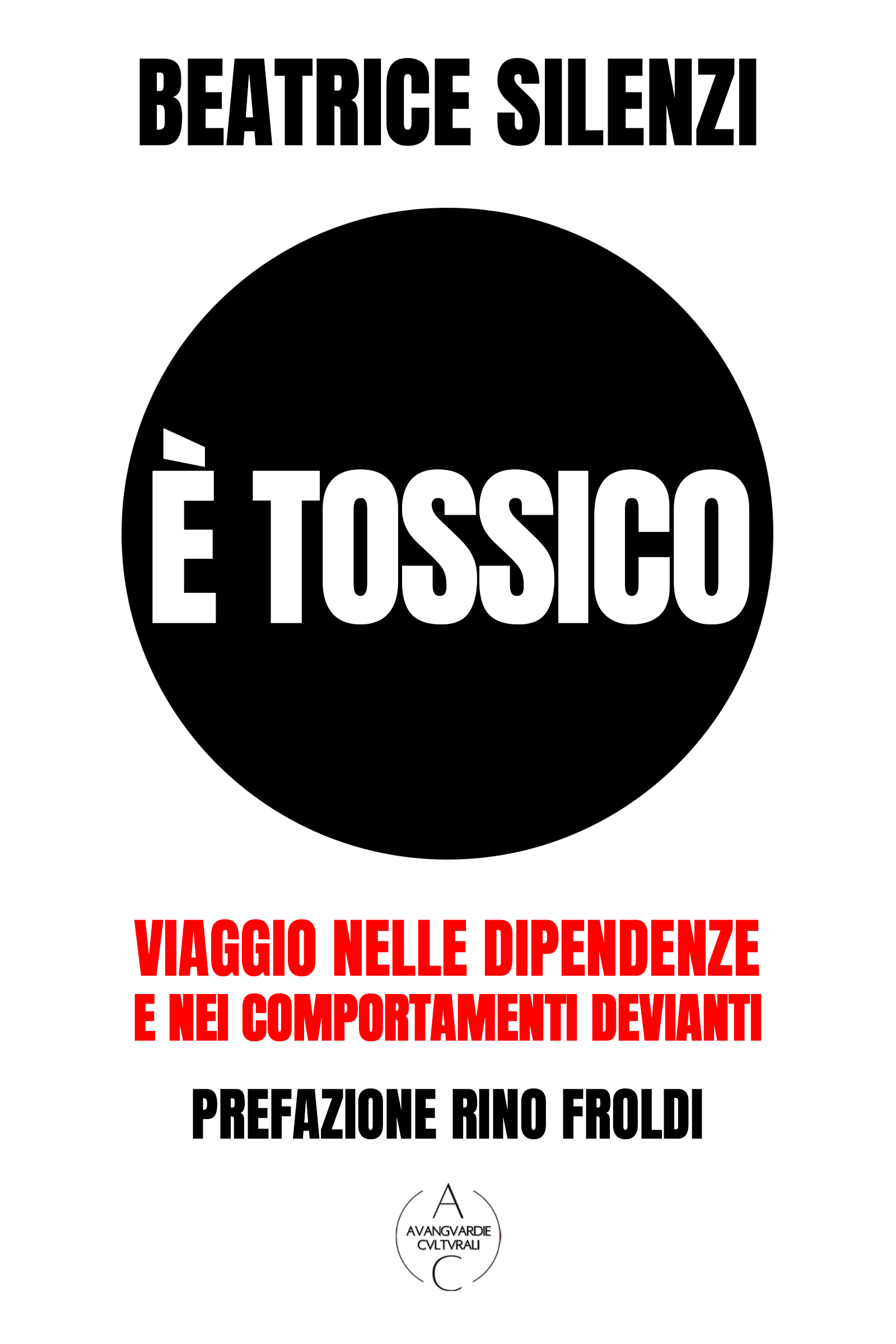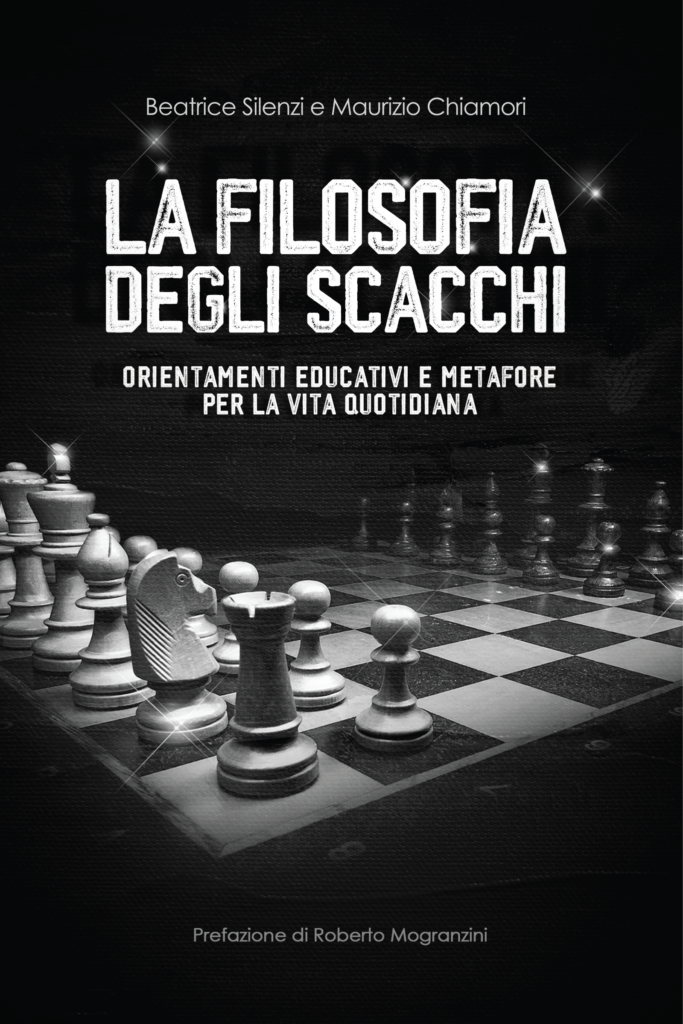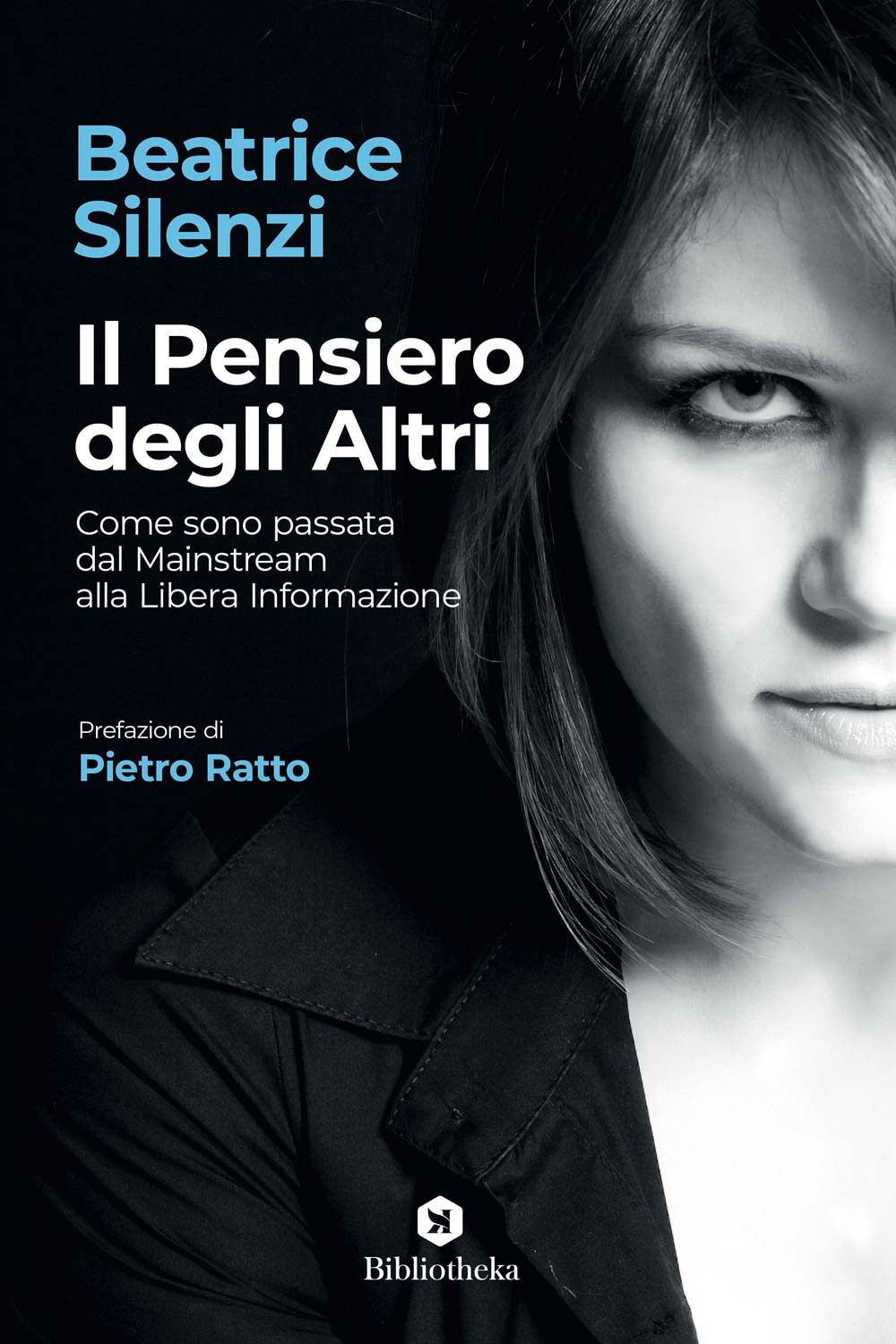Clicca per guardare il video
La rubrica Focus Radio è a cura della giornalista Beatrice Silenzi – direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
Segui tutti gli appuntamenti di Focus Radio in questo sito
Parlare oggi di separazione delle carriere significa entrare nel cuore del dibattito sul futuro della giustizia italiana.
Non si tratta solo di una questione tecnica, riservata agli addetti ai lavori, ma di un tema che tocca direttamente i fondamenti dello Stato di diritto: l’indipendenza dei magistrati, l’equilibrio tra accusa e difesa, la fiducia dei cittadini nella giustizia.
Dopo anni di confronto politico e istituzionale, il Parlamento ha approvato in via definitiva la riforma che modifica la Costituzione introducendo la netta distinzione tra giudici e pubblici ministeri.
Con il via libera del Senato, che ha concluso le quattro letture previste per le modifiche costituzionali, la riforma è ora legge.
Ma la partita è tutt’altro che chiusa: maggioranza e opposizioni hanno annunciato la volontà di promuovere un referendum confermativo.
Consultazione che si terrà in primavera e che non prevede quorum. Saranno dunque i cittadini, con il loro voto, a dire l’ultima parola su un tema che divide il mondo politico, la magistratura e l’opinione pubblica.
La riforma Nordio, al di là del linguaggio tecnico, rappresenta un passaggio storico per l’ordinamento italiano.
Da una parte, segna un tentativo di allineare il nostro sistema a quelli di altre democrazie europee, introducendo una distinzione più netta dei ruoli.
Dall’altra, apre una fase di incertezza sul futuro equilibrio tra poteri dello Stato.
Il referendum sarà quindi un banco di prova non solo per il governo, ma per la maturità civica del Paese.
La sfida sarà quella di discutere nel merito, lontano dalle semplificazioni e dalle contrapposizioni ideologiche.
Perché ci interessa così tanto parlare di separazione delle carriere?
Perché il fondamento è nell’idea di rafforzare l’indipendenza e l’imparzialità del sistema giudiziario, mirando a distinguere nettamente chi giudica — i giudici — da chi accusa — i pubblici ministeri — per evitare commistioni tra le due funzioni.
L’obiettivo dichiarato è duplice: assicurare che il giudice sia “terzo”, quindi completamente indipendente dalle parti in causa, e rafforzare l’equilibrio tra accusa e difesa nel processo penale.
Nel modello attuale magistrati giudicanti e requirenti fanno parte dello stesso ordine. Entrano con un unico concorso e possono, entro certi limiti, cambiare funzione nel corso della carriera.
La riforma approvata cambia radicalmente questo assetto, stabilendo che il magistrato dovrà scegliere fin dall’inizio se intraprendere la carriera di giudice o quella di pubblico ministero, senza più possibilità di passaggi successivi.
Tra i principali argomenti a sostegno della separazione vi sono: l’indipendenza del giudice che deve essere terzo e imparziale, per garantire che chi decide non abbia mai avuto un ruolo attivo in procedimenti analoghi.
L’equilibrio tra accusa e difesa e ponendo il giudice come vero garante delle libertà individuali e della corretta applicazione della legge.
La possibilità che un sistema giudiziario percepito come indipendente dalle dinamiche interne e dalle influenze politiche aumenti la fiducia collettiva nella giustizia.
La riforma, secondo i promotori, inoltre, rende più chiara e trasparente la divisione dei ruoli, evitando commistioni tra chi accusa e chi giudica, come previsto nei moderni ordinamenti democratici.
Dall’altra parte, i critici della riforma, tra cui l’ANM e molti costituzionalisti, sollevano invece alcune preoccupazioni: la prima risiede nella frammentazione dell’ordine giudiziario poiché dividere giudici e pubblici ministeri in due carriere autonome potrebbe indebolire il senso di appartenenza a un’unica magistratura, rendendo più difficile il coordinamento e l’uniformità interpretativa della legge.
Si potrebbe verificare una ipotesi di subordinazione del pubblico ministero che potrebbe diventare più esposto a pressioni politiche, soprattutto se dovesse dipendere, anche solo indirettamente, dal potere esecutivo.
Va detto: la riforma non interviene sui biblici tempi della giustizia o sulla riduzione dell’arretrato processuale.
Oggi in Italia i magistrati, dopo aver superato lo stesso concorso, possono scegliere di svolgere sia la funzione giudicante che quella requirente.
La loro formazione è comune, e fino alla riforma Cartabia del 2022 potevano passare da un ruolo all’altro fino a quattro volte nel corso della carriera.
Con la Cartabia, questo limite è stato ridotto a un solo cambio entro i primi dieci anni di servizio.
La riforma Nordio abolisce anche questa possibilità.
Un’altra novità significativa riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo di autogoverno dei magistrati.
Finora ne esisteva uno solo, presieduto dal Presidente della Repubblica e con competenze su tutto l’ordine giudiziario. Con la riforma, il CSM viene sdoppiato in due: un Consiglio per la magistratura giudicante, che avrà competenza sui giudici; ed uno per la requirente, che si occuperà ovviamente dei pubblici ministeri.
Il voto del Senato — 112 favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti — ha segnato il traguardo legislativo di una lunga battaglia politica. Ma il giorno dopo l’approvazione, le reazioni non si sono fatte attendere.
La premier Giorgia Meloni ha parlato di un “traguardo storico” e di “un passo avanti per una giustizia più giusta”. Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini.
La riforma è stata fortemente voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha proposto un confronto pubblico con l’Associazione Nazionale Magistrati che ha accettato l’invito, aprendo alla possibilità di un dibattito.
Forza Italia ha dedicato il successo della riforma alla memoria di Silvio Berlusconi. “È la vittoria di mio padre”, ha dichiarato la figlia Marina commentando il voto parlamentare.
Di tutt’altro segno le reazioni delle opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha accusato il governo di voler “mettere le mani sulla giustizia”, sostenendo che la riforma “non migliora la vita dei cittadini né la velocità dei processi”.
Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle è stato ancora più duro: “Vogliono pieni poteri. Questa legge stravolge la Costituzione”.
Enrico Grosso, avvocato e professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino, è presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione e per il No al referendum.
La storia insegna che la giustizia è la spina dorsale di una nazione: se è forte e credibile, lo è anche la democrazia. trova tre titoli brevi ed efficaci
Focus Radio. L’essenziale, in profondità.
Articolo precedente:
MOFLIN PET ROBOT E I RISCHI DEL CONFORTO TECNOLOGICO
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.