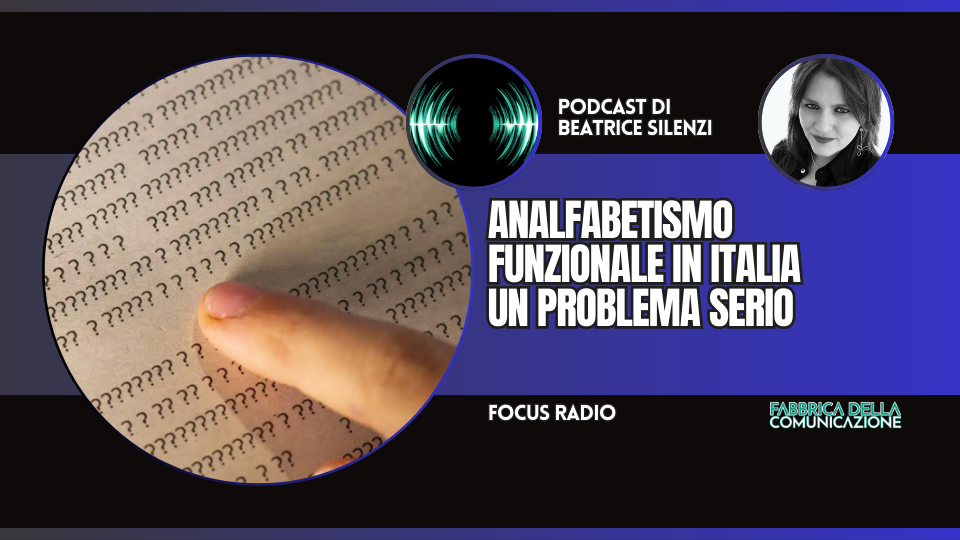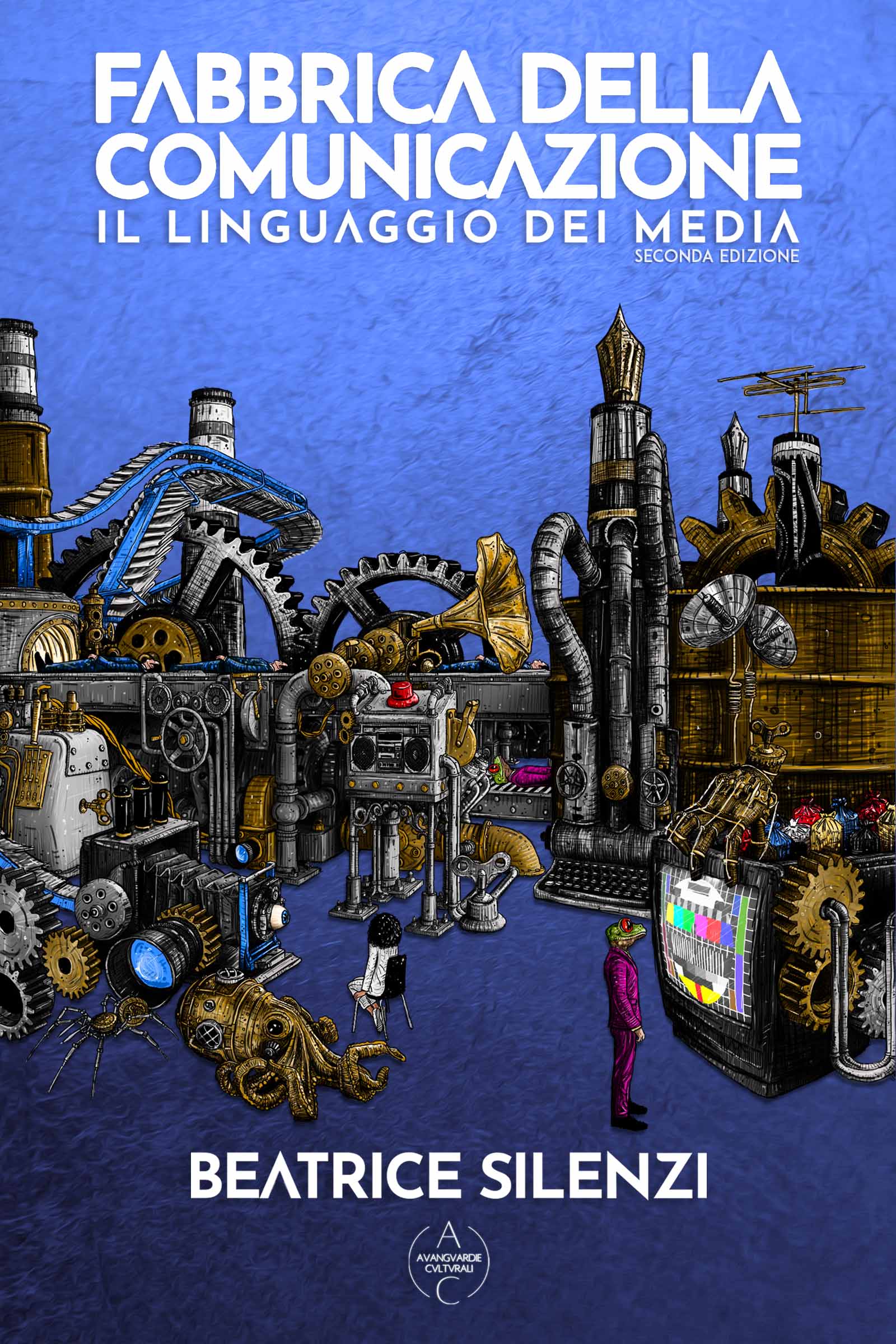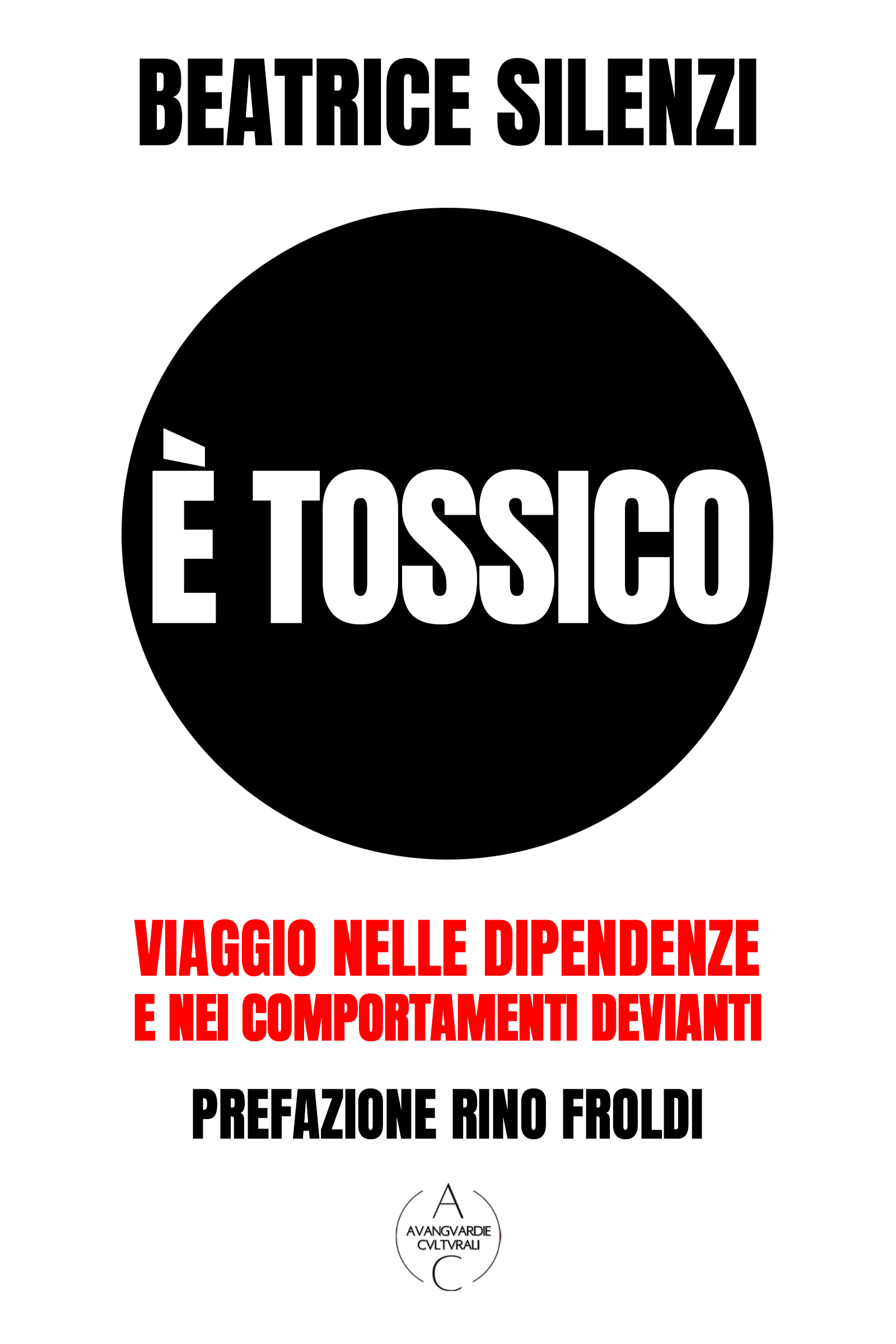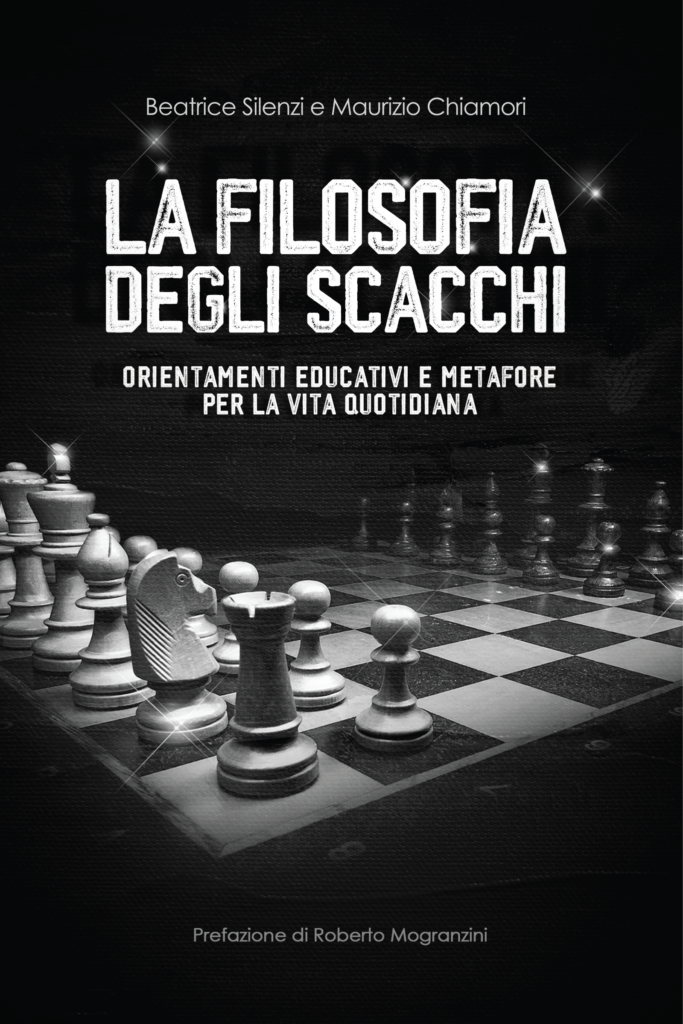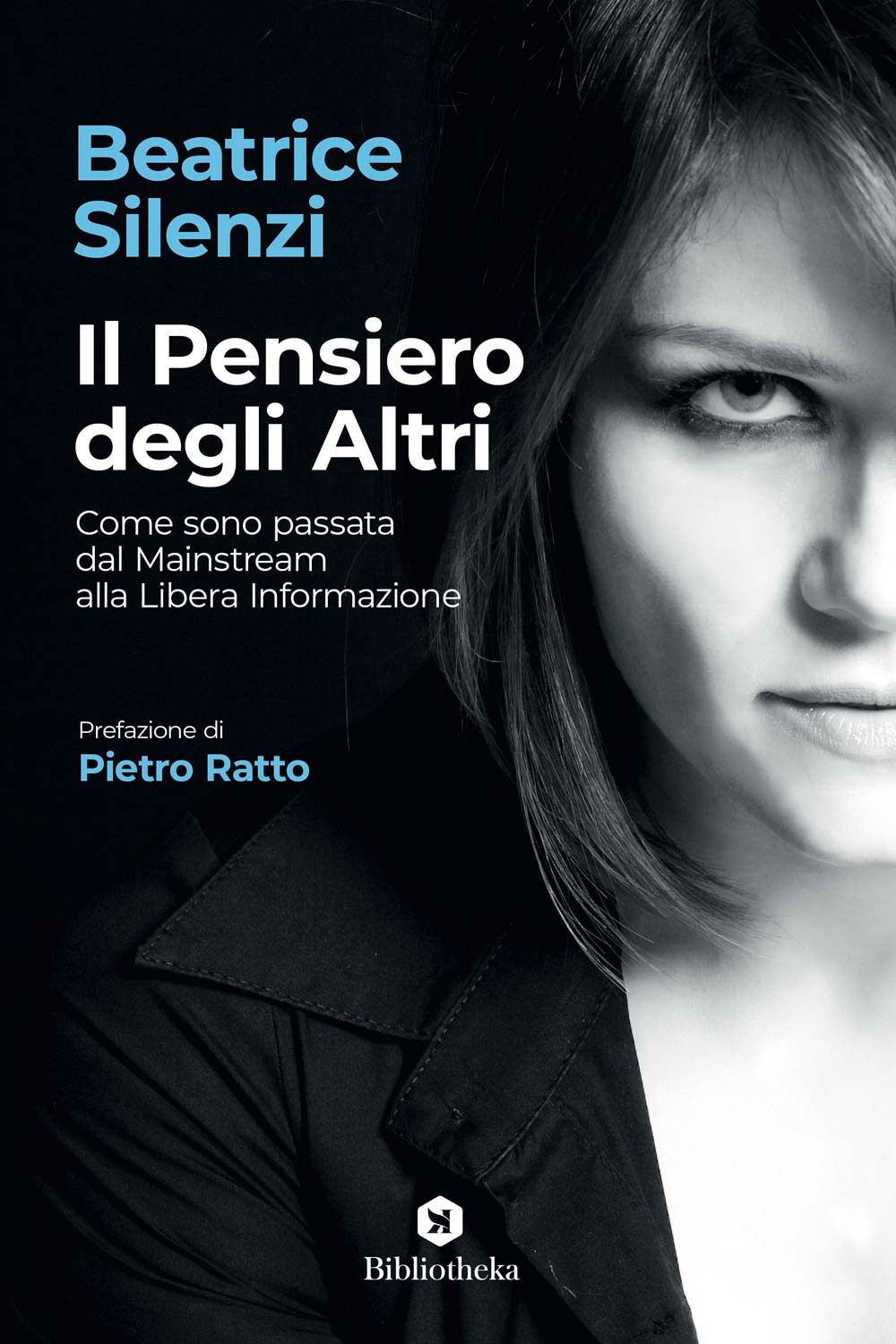Clicca per guardare il video
La rubrica Focus Radio è a cura della giornalista Beatrice Silenzi – direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
Segui tutti gli appuntamenti di Focus Radio in questo sito
L’analfabetismo in Italia ha sempre avuto una doppia natura: da un lato materiale, cioè legata all’incapacità di leggere e scrivere, dall’altro funzionale e simbolica, riflesso di una frattura sociale ed economica.
Nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, quasi l’80 per cento della popolazione era analfabeta. Un dato impressionante che segnalava non soltanto un ritardo scolastico, ma soprattutto un divario di sviluppo tra le diverse regioni del Paese.
L’analfabetismo era quasi totale nel Meridione rurale
In alcune aree del Nord, invece, specialmente urbane, già esisteva una quota significativa di popolazione scolarizzata: in altre parole, l’Italia nasceva divisa anche sul piano delle competenze culturali.
Le riforme post-unitarie, a partire dalla legge Coppino del 1877 che introdusse l’obbligo scolastico fino ai nove anni, tentarono di colmare il divario. Eppure, a lungo l’istruzione rimase un privilegio più che un diritto diffuso.
La crescita economica, l’urbanizzazione e l’aumento dell’obbligo scolastico contribuirono a creare un Paese formalmente alfabetizzato.
Ma già in quegli anni, studiosi e pedagogisti cominciavano a osservare un fenomeno nuovo: molti cittadini, pur sapendo leggere e scrivere, non sviluppavano pienamente la capacità di comprendere testi complessi o di utilizzare le proprie competenze in maniera critica e funzionale.
In Italia, il dibattito si fece acceso perché mostrava un paradosso: il Paese che aveva dato i natali a Dante e Petrarca, che custodiva biblioteche millenarie e che aveva contribuito in modo decisivo alla storia della cultura europea, si trovava a fare i conti con milioni di cittadini incapaci di leggere e interpretare in modo critico la realtà scritta intorno a loro.
Il sistema educativo continuò a concentrarsi sull’istruzione primaria e secondaria, trascurando la formazione permanente degli adulti, mentre il tessuto sociale — con il calo della lettura di libri e l’affermarsi di un consumo rapido e superficiale di informazioni — accentuava la fragilità di base.
Non si tratta dunque di un fenomeno passeggero, ma della manifestazione attuale di una storia lunga, che parte dalle disuguaglianze post-unitarie, passa attraverso le difficoltà di consolidare un sistema scolastico nazionale, e arriva fino alla società iperconnessa di oggi, dove la quantità di informazioni non si traduce necessariamente in capacità di comprenderle e usarle.
L’analfabetismo funzionale è il volto contemporaneo di un’antica frattura
La traiettoria storica ci dice una cosa chiara: vi è differenza tra élite colte e la maggioranza che fatica a padroneggiare gli strumenti della conoscenza.
Oggi, però, il rischio è ancora più alto: perché in un mondo dominato dai flussi digitali e dall’economia della conoscenza, non saper interpretare testi, numeri e informazioni non significa solo restare indietro, ma essere esclusi da processi fondamentali di cittadinanza, lavoro, salute, diritti.
Focus Radio. L’essenziale, in profondità.
Articolo precedente:
https://www.fcom.it/snark-il-vandalismo-della-parola/
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.