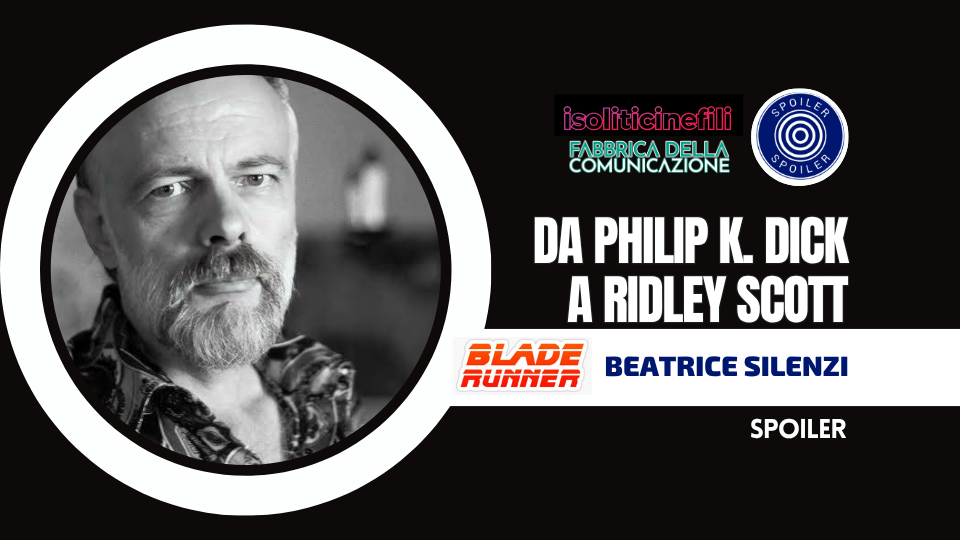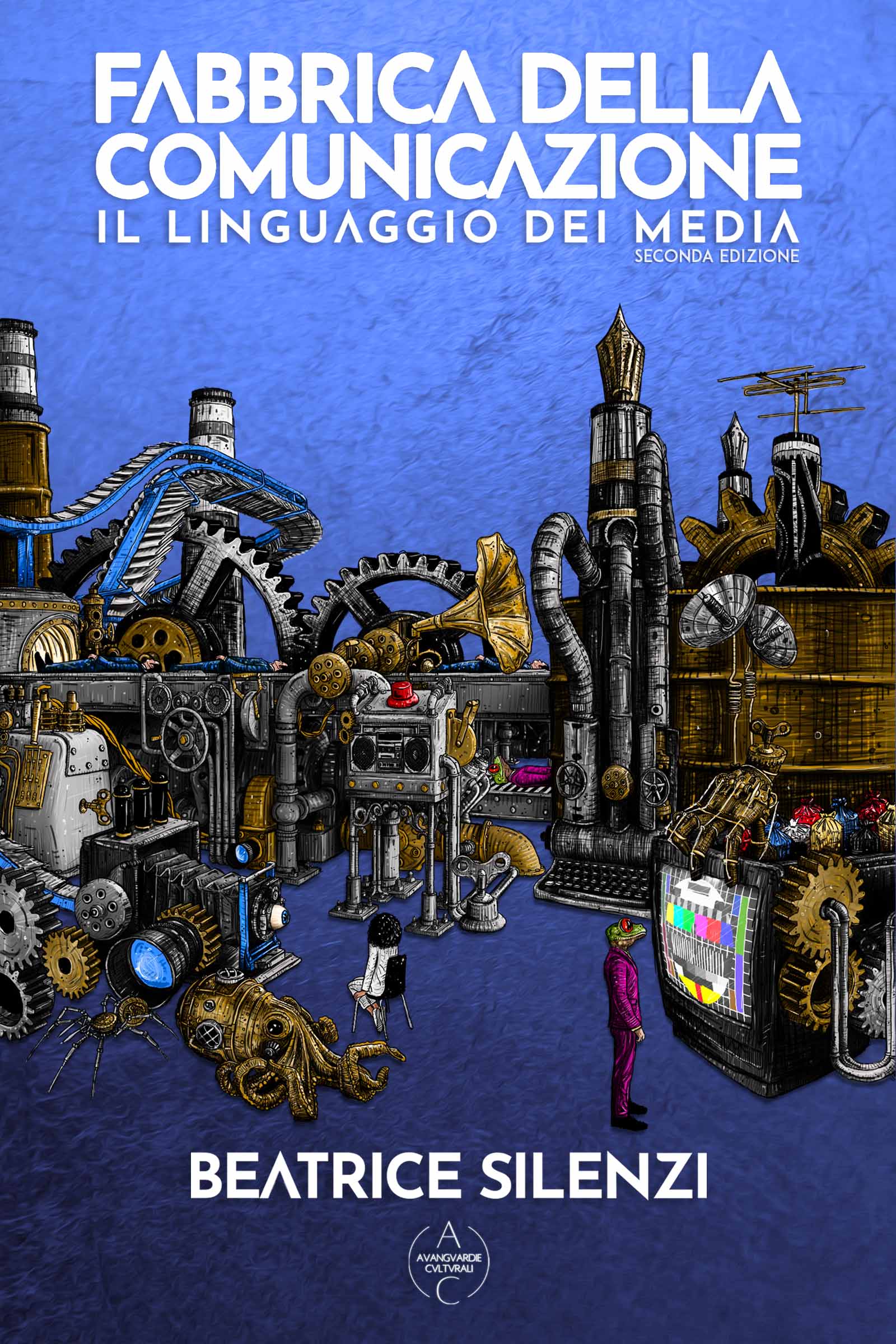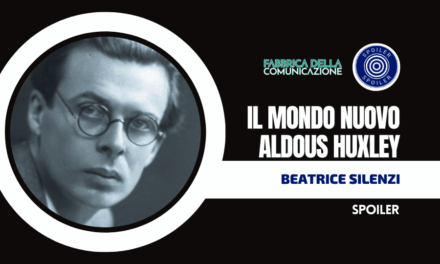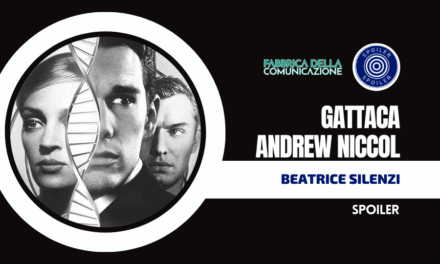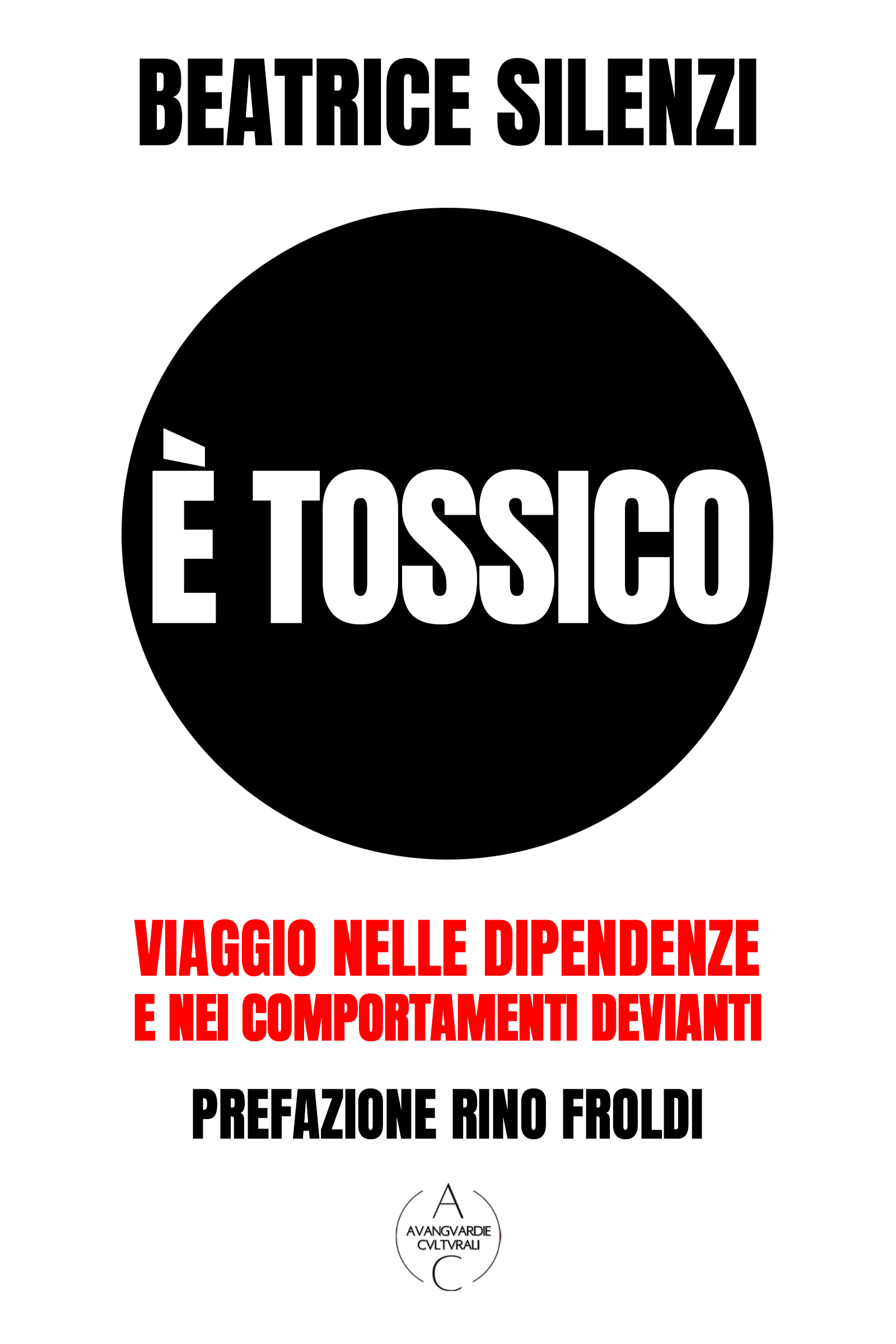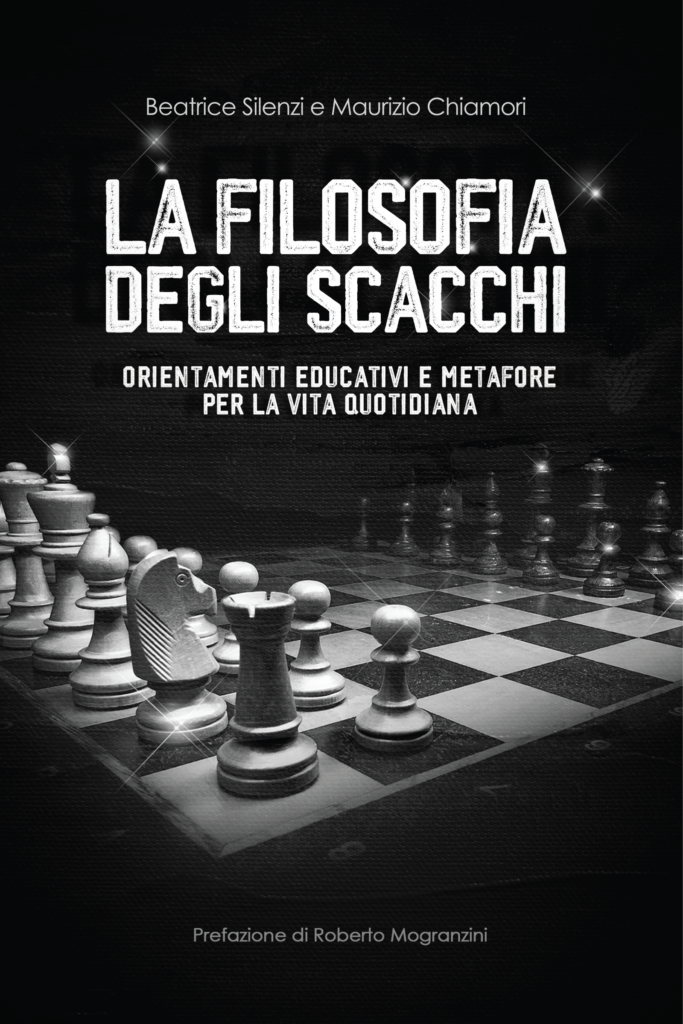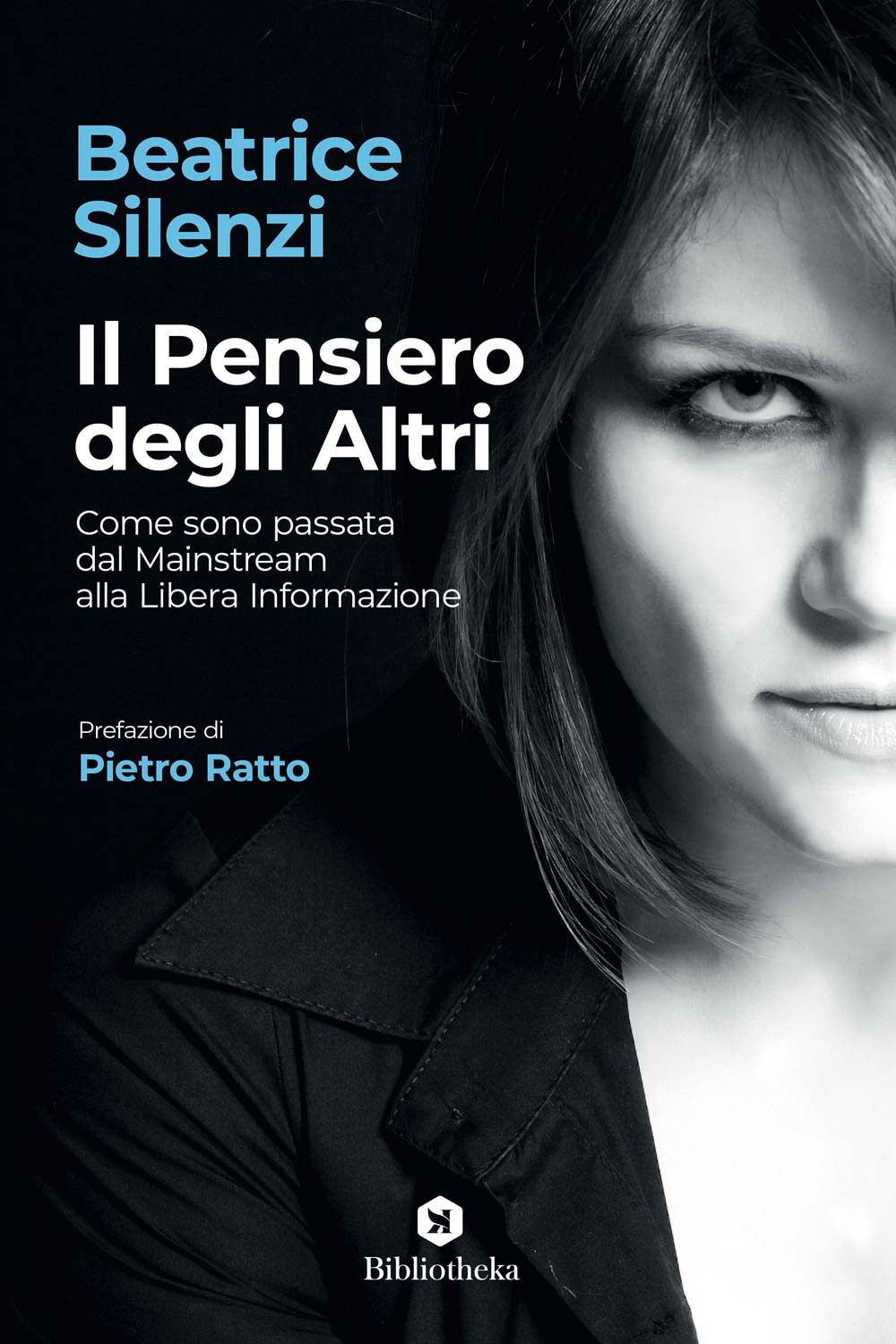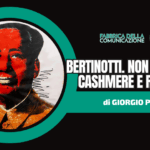Clicca per guardare il video
La rubrica Spoiler – podcast è cura della giornalista Beatrice Silenzi – direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
Segui tutti gli appuntamenti di Spoiler sul nostro sito.
“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.”
Questa celebre frase, pronunciata dal replicante Roy Batty nel film “Blade Runner” (1982) di Ridley Scott, è impressa nell’immaginario collettivo. Tuttavia, è fondamentale sapere che questo monologo è frutto della sceneggiatura del film e non è presente nel romanzo da cui la pellicola è liberamente ispirata: “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” (titolo originale: “Do Androids Dream of Electric Sheep?”) di Philip K. Dick, pubblicato nel 1968.
Anzi, molto del film non trova corrispondenza diretta nel libro, che offre un’esplorazione filosofica ancora più profonda e complessa.
Il romanzo di Dick ci trasporta in un futuro distopico, una San Francisco devastata dalla Guerra Mondiale Terminale, presumibilmente avvenuta agli inizi degli anni ’90 (del XX secolo, secondo la cronologia del libro).
La Terra è un luogo semideserto e contaminato dalle radiazioni. Gran parte della popolazione umana è emigrata sulle colonie extramondo, mentre molte specie animali si sono estinte.
In questo scenario desolante seguiamo le vicende di Rick Deckard, un cacciatore di taglie incaricato di “ritirare” – un eufemismo per eliminare – alcuni androidi modello Nexus-6, fuggiti dalle colonie e rifugiatisi illegalmente sulla Terra.
Fin dalle prime pagine, Dick ci immerge in un mondo straniante dove tecnologie futuristiche convivono con problemi atavici dell’umanità: la solitudine, la ricerca di significato, e il disperato bisogno di empatia in un ambiente ostile.
Umani, Androidi e il Test dell’Empatia
Il tema centrale del romanzo è la difficile, se non impossibile, distinzione tra esseri umani e androidi. Gli androidi del romanzo sono biologicamente indistinguibili dagli umani, dotati di intelligenza acuta, ma privi di un elemento essenziale: l’empatia.
Sono progettati senza la capacità di provare compassione o immedesimazione, potendo al massimo simulare emozioni umane superficiali.
Per questo, l’umanità ha stabilito l’empatia come criterio assoluto per riconoscere un vero essere umano.
Il test Voight-Kampff, che Deckard utilizza, misura le reazioni emotive di un individuo davanti a situazioni empatiche per smascherare eventuali androidi.
Dick, però, rovescia le aspettative: non è tanto la somiglianza degli androidi agli uomini ad inquietare, quanto la progressiva somiglianza degli uomini alle macchine.
Gli umani utilizzano macchine per modulare le proprie emozioni (come il modulatore di umore Penfield), e i cacciatori di taglie come Deckard devono sopprimere la propria empatia naturale per portare a termine il loro “lavoro” di uccidere esseri che, esteriormente, paiono umani.
Mercerismo: Una Fede Artificiale per un’Umanità Svuotata?
Un altro asse tematico fondamentale è quello spirituale-religioso, incarnato dal Mercerismo.
In un mondo dove le religioni tradizionali sembrano aver perso presa, gli umani abbracciano questa nuova fede collettiva. Wilbur Mercer è una figura mistica che scala perennemente una collina sotto una pioggia di pietre, in un ciclo infinito di sofferenze e rinascita.
Gli adepti, attraverso delle “scatole empatiche”, si fondono con l’esperienza di Mercer, condividendo il suo dolore e la sua ascesa.
Questo culto, con evidenti richiami cristologici, rappresenta un tentativo di recuperare un senso di comunità e compassione.
La figura di Buster Friendly, un popolare conduttore televisivo onnipresente (che si scoprirà essere un androide), svela che l’intera storia di Mercer potrebbe essere un inganno, una montatura costruita in studio. Questa rivelazione nichilista mina alle fondamenta la fede, lasciando l’umanità ancora più sola.
Rick Deckard: Il protagonista anti-eroe. Inizialmente appare stanco, frustrato e un po’ arido, mosso più dal desiderio di guadagnare abbastanza per comprare un vero animale (status symbol in un mondo dove sono rarissimi) che da convinzioni etiche.
Nel corso della vicenda, attraversa uno sviluppo interiore significativo, interrogandosi sulla natura del suo lavoro e sulla sua stessa umanità, specialmente dopo l’incontro con Rachael Rosen.
Rachael Rosen: Una bellissima androide della Rosen Corporation, che inizialmente tenta di ingannare Deckard. La loro complessa relazione, che include un rapporto sessuale, porta Deckard a una crisi profonda, facendolo dubitare della sua capacità di uccidere altri androidi.
La crudeltà finale di Rachael, che uccide la capra di Deckard, spezza l’illusione e lo riporta, paradossalmente, al suo ruolo.
J.R. Isidore: Uno “speciale”, un umano reso meno intelligente dalle radiazioni ed escluso dall’emigrazione. Vive da solo in un palazzo abbandonato e incarna un’innocenza e un’empatia quasi istintive, accogliendo gli androidi fuggitivi e cercando compagnia.
La sua linea narrativa si interseca con quella di Deckard, offrendo un punto di vista alternativo.
Roy Baty e Irmgard Baty: Leader del gruppo di androidi fuggitivi. Nel romanzo, non hanno il rilievo iconico del film, ma la loro relazione suggerisce che anche tra androidi possa esistere un legame di affetto o attaccamento reciproco.
Lo stile di Dick è asciutto, funzionale, punteggiato da improvvisi lampi visionari e momenti di ironia cupa. I dialoghi sono brevi e taglienti.
La narrazione adotta principalmente il punto di vista di Deckard, ma si interseca con capitoli dedicati a J.R. Isidore, creando un doppio binario narrativo che converge nel climax. L’economia descrittiva stimola l’immaginazione del lettore, mantenendo un ritmo sostenuto.
Eredità e Rilevanza Attuale
Quando “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” fu pubblicato nel 1968, la fantascienza viveva una stagione di rinnovamento intellettuale. Il romanzo fu candidato al Premio Nebula nel 1969, segno del riconoscimento del suo valore innovativo.
L’impatto culturale più clamoroso è avvenuto indirettamente tramite il cinema. L’adattamento “Blade Runner” (1982), pur differente, ha reso immortale l’idea di Dick di un futuro cyberpunk dominato da megacorporazioni, umani decadenti e replicanti in cerca di vita.
Philip K. Dick stesso, prima di morire, vide alcuni spezzoni del film e ne fu entusiasta, affermando che gli effetti speciali erano “il mio stesso mondo interiore”.
A oltre cinque decenni dalla sua pubblicazione, il romanzo non ha perso la capacità di stimolare domande. Anzi, con il progredire della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, le sue questioni diventano sempre più concrete: un’IA può essere cosciente?
Dovremmo concedere diritti legali a un androide se divenisse senziente? Come evitare di disumanizzarci nell’interazione con macchine sempre più simili a noi?
“Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” è più di un semplice racconto di caccia ai robot. È una parabola filosofica che intreccia riflessioni post-umane, istanze esistenzialiste e critica nichilista.
Il romanzo intercetta e anticipa tendenze come il postumanesimo, la massificazione mediatica e la coscienza ambientalista.
Non offre risposte facili, ma la sua bellezza sta proprio nell’inquietudine che lascia, nel leggero disagio che induce a guardare in modo nuovo sia il nostro animale domestico sul divano, sia le nostre interazioni con gli altri.
Forse la risposta ultima alla domanda del titolo è che sì, gli androidi sognano pecore elettriche, ma siamo noi umani a dover sognare e praticare abbastanza empatia da accogliere tutti nel nostro gregge, senza perdere la nostra anima.
È un classico moderno che, come tutte le grandi opere, offre più domande che risposte, rimanendo per questo sempre vivo ed attuale.
Approfondimento dell’appuntamento precedente Propaganda di Edward Bernays
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.