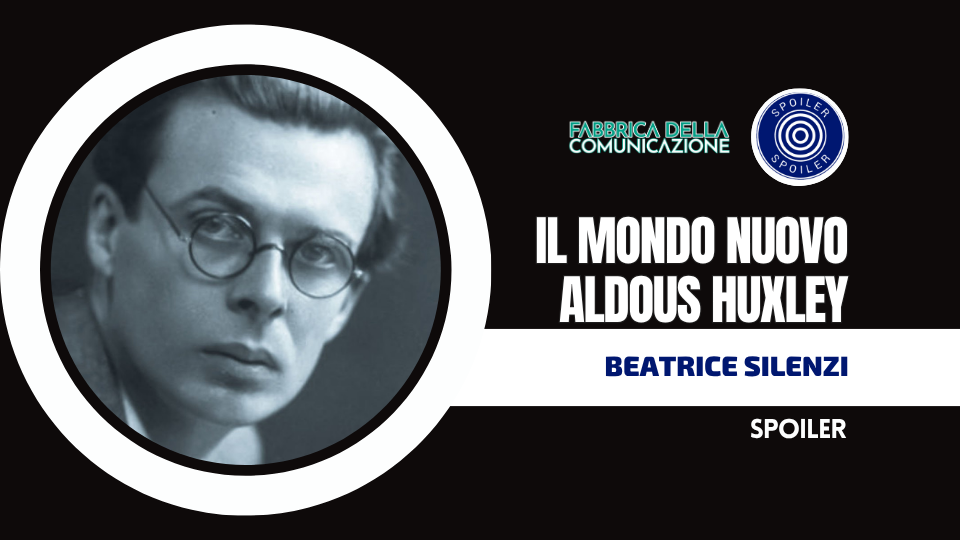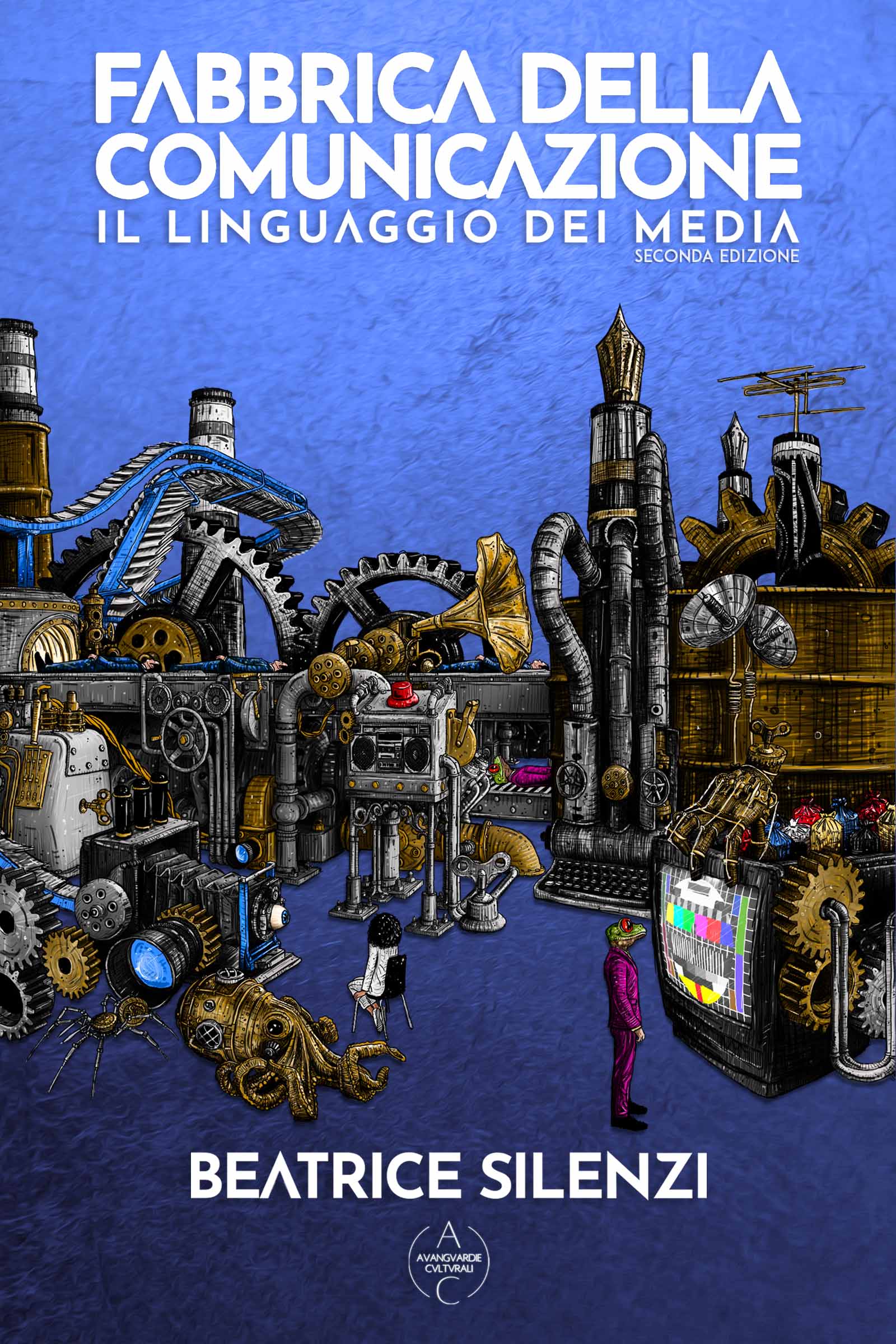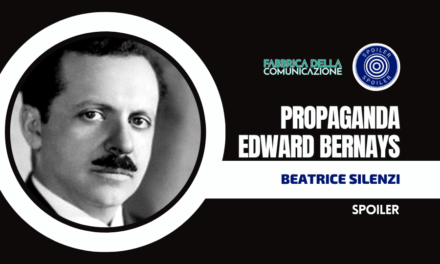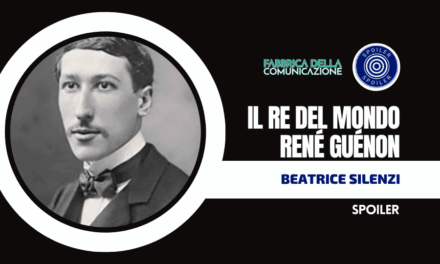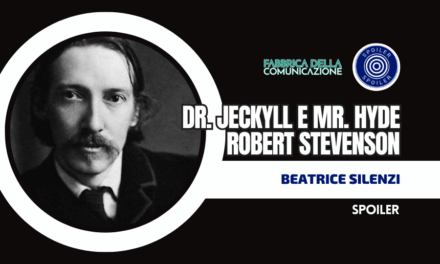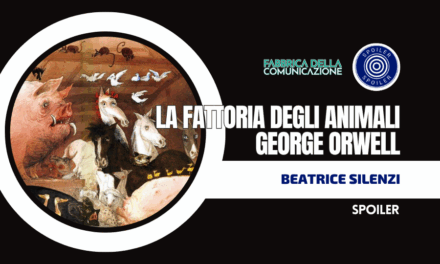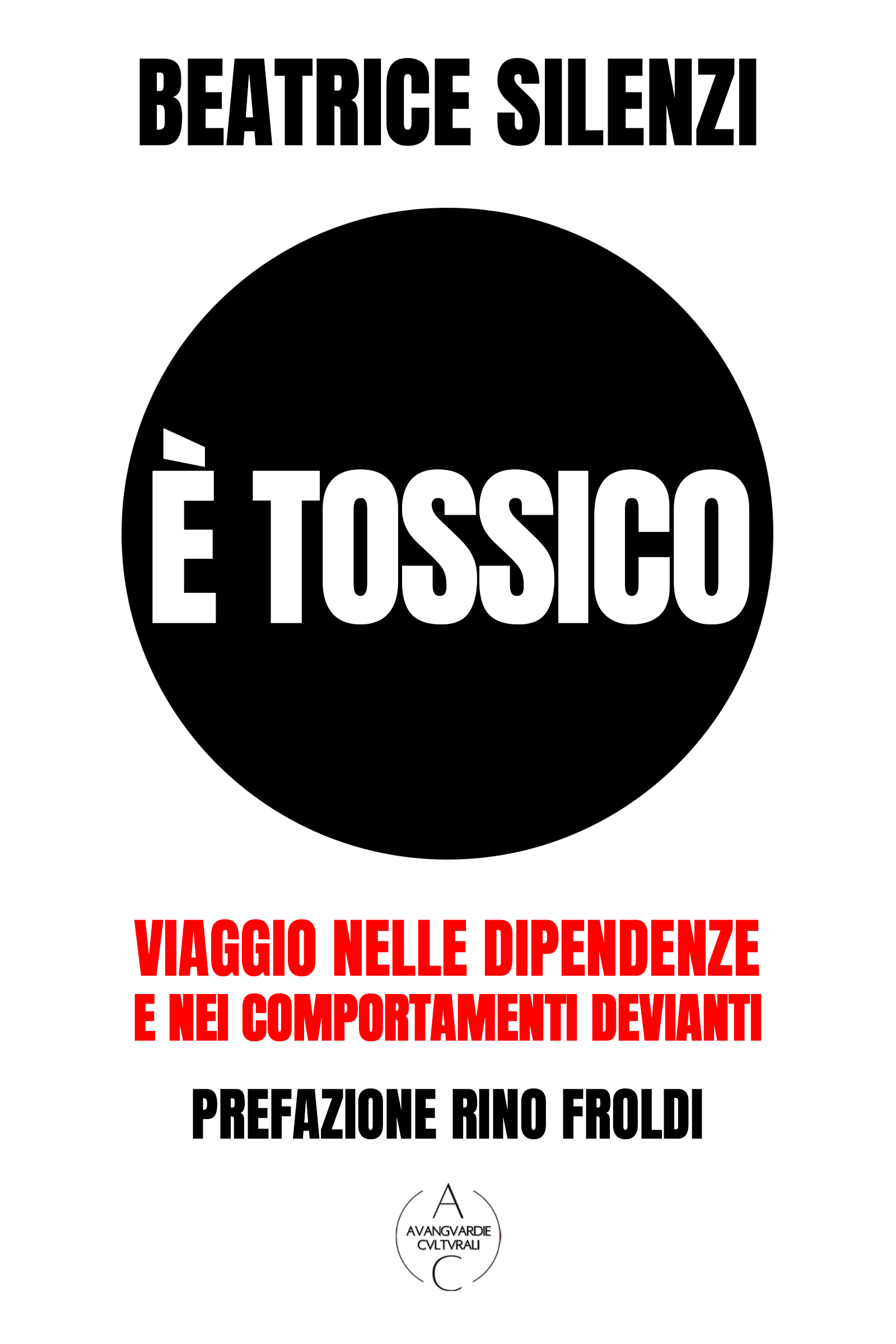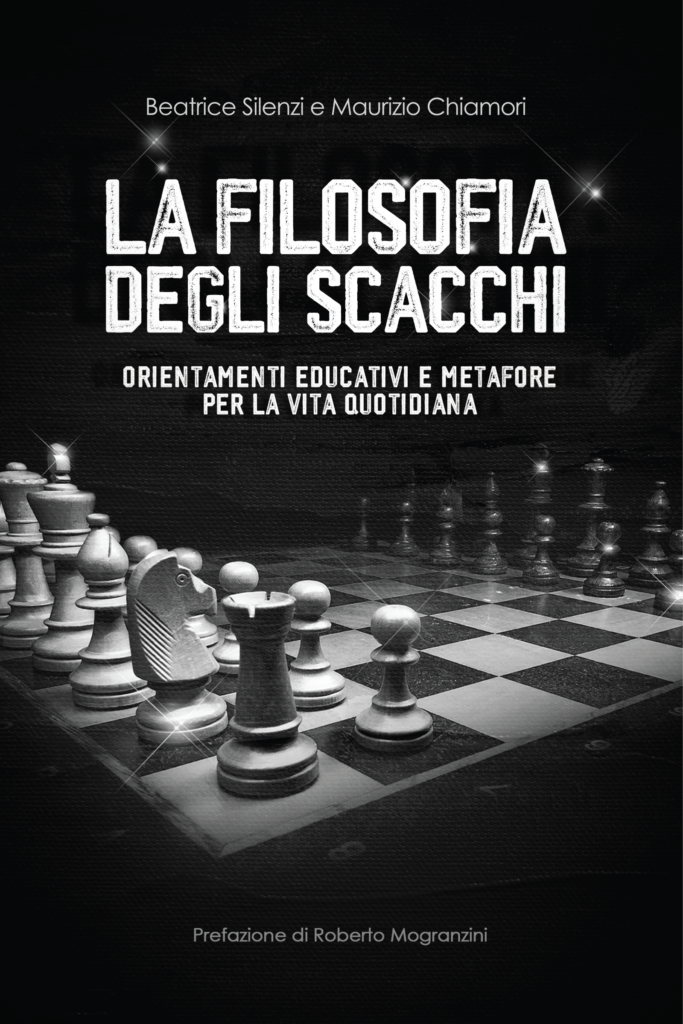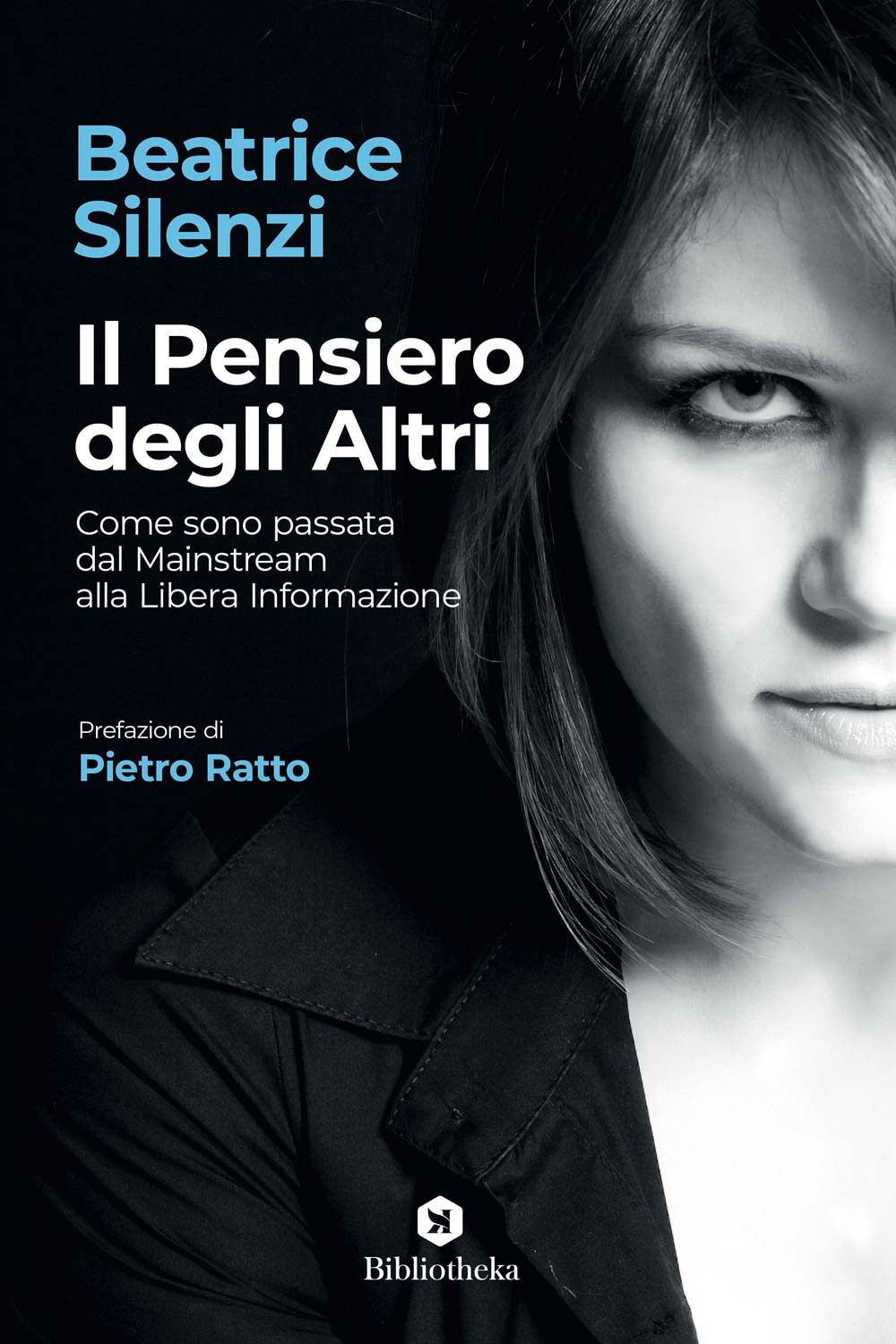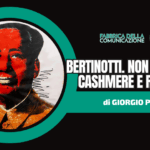Clicca per guardare il video
La rubrica Spoiler – podcast è cura della giornalista Beatrice Silenzi – direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
Segui tutti gli appuntamenti di Spoiler sul nostro sito.
La distopia più inquietante, che bussa oggi alle porte della nostra civiltà, non ha il volto truce del totalitarismo di George Orwell, ma il sorriso seducente e vacuo del Mondo Nuovo di Aldous Huxley. Pubblicato nel 1932, questo capolavoro letterario e filosofico si rivela, a quasi un secolo di distanza, non tanto una fantasia futuribile, quanto un’impietosa diagnosi del presente.
Huxley non ci ha messo in guardia da una prigione che avremmo odiato, ma da una gabbia dorata che avremmo imparato ad amare. Una prigione costruita non sulla paura, ma sulla seduzione del piacere, del comfort e della distrazione perpetua.
Scritto nel turbolento interregno tra le due guerre mondiali, in un’epoca di crisi economiche e fermenti ideologici, Il mondo nuovo nasce da un’intuizione geniale. Aldous Huxley, erede di una dinastia di scienziati e intellettuali, comprese che la minaccia più grande alla libertà umana non sarebbe venuta dalla sofferenza imposta, ma dalla felicità scientificamente pianificata.
La riproduzione umana è stata abolita.
I bambini nascono in provetta, nei “Centri di Incubazione e Condizionamento”. Attraverso il “processo Bokanovsky”, da un singolo ovulo si producono fino a novantasei gemelli identici, predestinati a far parte di caste immutabili: dagli intelligenti Alfa, destinati al comando, fino ai sub-umani Epsilon, programmati per accettare con gioia i lavori più umili.
La disuguaglianza sociale non è più un’ingiustizia da combattere, ma un fatto biologico incontrovertibile.
Fin dalla nascita, la mente dei cittadini viene plasmata. L’ipnopedia, l’insegnamento nel sonno, inculca slogan e verità morali (“Tutti appartengono a tutti gli altri”, “Un grammo di soma è meglio di un accidente”) che diventano riflessi incondizionati.
L’amore per la natura e per i libri viene estirpato nelle caste inferiori attraverso shock elettrici associati a fiori e volumi. L’individuo non pensa, ma ripete. Non sceglie, ma obbedisce a impulsi indotti.
La Droga della Pace Sociale. L’invenzione più profetica di Huxley è il soma, una droga perfetta che offre euforia e oblio senza effetti collaterali.
È il lubrificante che annulla ogni attrito sociale ed esistenziale. Ansia, tristezza, noia, delusione? C’è una pillola per questo. In questa “farmacocrazia”, il benessere chimico ha sostituito la ricerca di senso, la spiritualità e la resilienza umana.
Il cuore filosofico del romanzo pulsa nel dialogo tra il “Selvaggio” John, un reietto cresciuto in una riserva leggendo Shakespeare, e Mustapha Mond, il Governatore Mondiale.
John incarna tutto ciò che il Mondo Nuovo ha abolito: l’amore passionale, la gelosia, la famiglia, la sofferenza, l’arte, il bisogno di Dio. Mond, d’altra parte, non è un tiranno malvagio, ma un intellettuale lucido che ha fatto una scelta consapevole.
Ha sacrificato la verità, la bellezza e la libertà sull’altare della stabilità e della felicità universale. “La gente è felice,” spiega a un inorridito John, “ottiene ciò che vuole, e non vuole mai ciò che non può ottenere”.
L’arte è destabilizzante, la scienza pura è pericolosa, la religione è superflua quando non si ha più paura della morte e della vecchiaia.
Il patto faustiano è stato siglato: in cambio della sicurezza e del piacere, l’umanità ha rinunciato alla propria anima. John rivendica il diritto di essere infelice, di piangere, di peccare, di soffrire.
Ma in un mondo che ha cancellato queste parole dal proprio vocabolario, la sua richiesta è incomprensibile, folle.
Come ha acutamente osservato il critico Neil Postman, la nostra società assomiglia molto più alla visione di Huxley che a quella di Orwell. Orwell temeva che i libri venissero messi al bando; Huxley temeva che nessuno avrebbe più avuto voglia di leggerli, troppo distratto da piaceri più immediati.
Orwell temeva che la verità ci venisse nascosta; Huxley temeva che la verità sarebbe stata annegata in un oceano di irrilevanza.
La ricerca compulsiva di gratificazione istantanea (like, follower), la performance di una felicità patinata, la fuga dalla noia in un flusso infinito di contenuti triviali. Non siamo forse costantemente in “vacanza dalla realtà”?
Lo slogan del Mondo Nuovo “più rammendi, meno rendi” è il mantra della nostra economia basata sull’obsolescenza programmata e sul desiderio perennemente rinnovato.
La tendenza a trattare ogni disagio emotivo, ogni tristezza e ogni ansia come un disturbo chimico da correggere con un farmaco riecheggia la funzione pacificatrice del soma.
Il dogma “tutti appartengono a tutti gli altri” trova un’eco perversa in una cultura dove la sessualità è spesso slegata dall’intimità e l’esclusività affettiva è vista con sospetto, mentre la vita privata diventa spettacolo pubblico.
Il mondo nuovo non è più fantascienza. È un manuale per comprendere le tentazioni del XXI secolo.
Non ci descrive un futuro imposto da un potere esterno, ma un futuro che potremmo scegliere noi stessi, scambiando la faticosa libertà di essere umani per la comoda schiavitù del benessere.
La domanda che il capolavoro di Huxley ci pone, oggi più che mai, non è se saremo costretti a entrare in questa prigione dorata, ma se non abbiamo già iniziato a costruirla, mattone dopo mattone, con le nostre stesse mani, desiderandola.
BLADE RUNNER. DA PHILIP DICK A RIDLEY SCOTT
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.