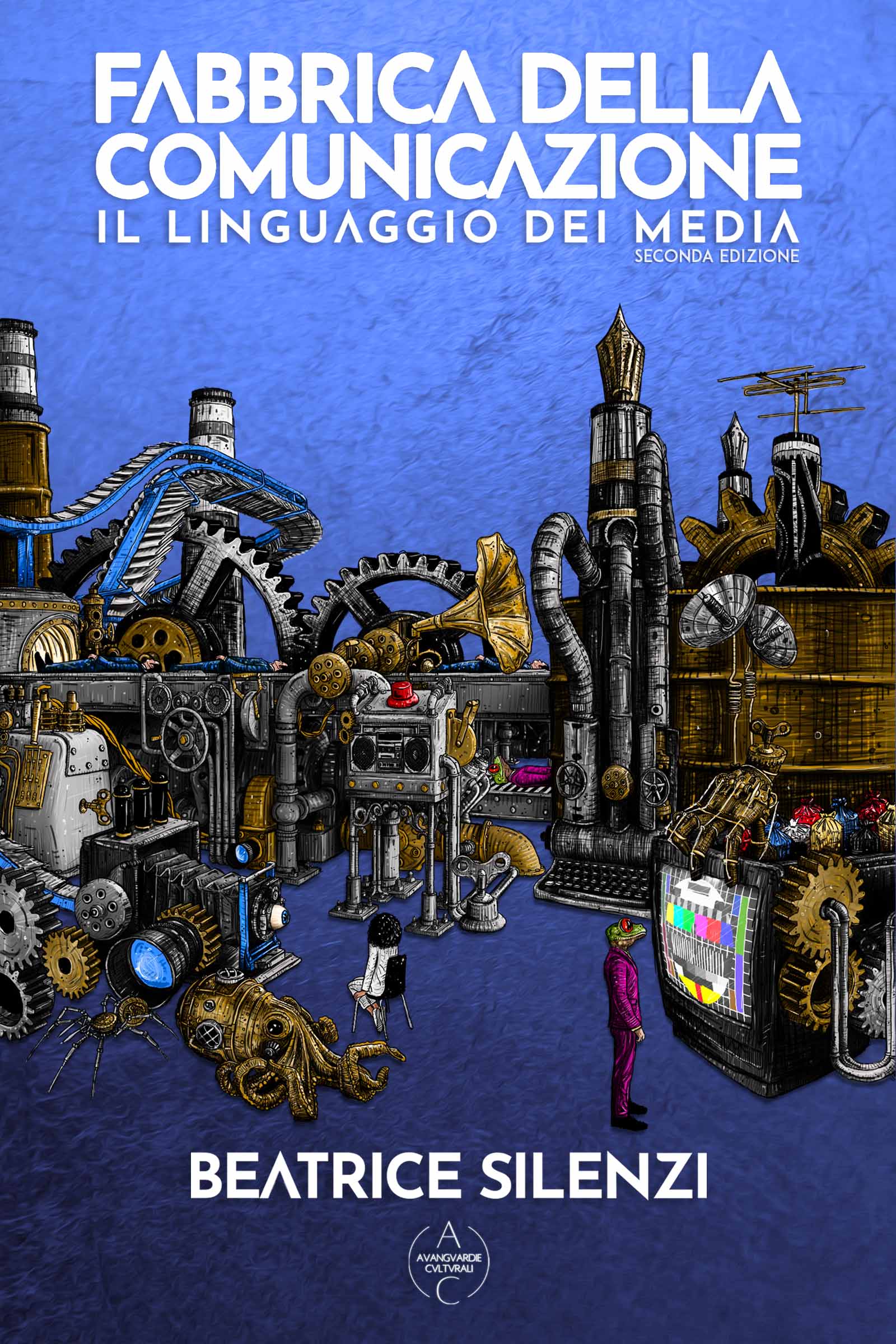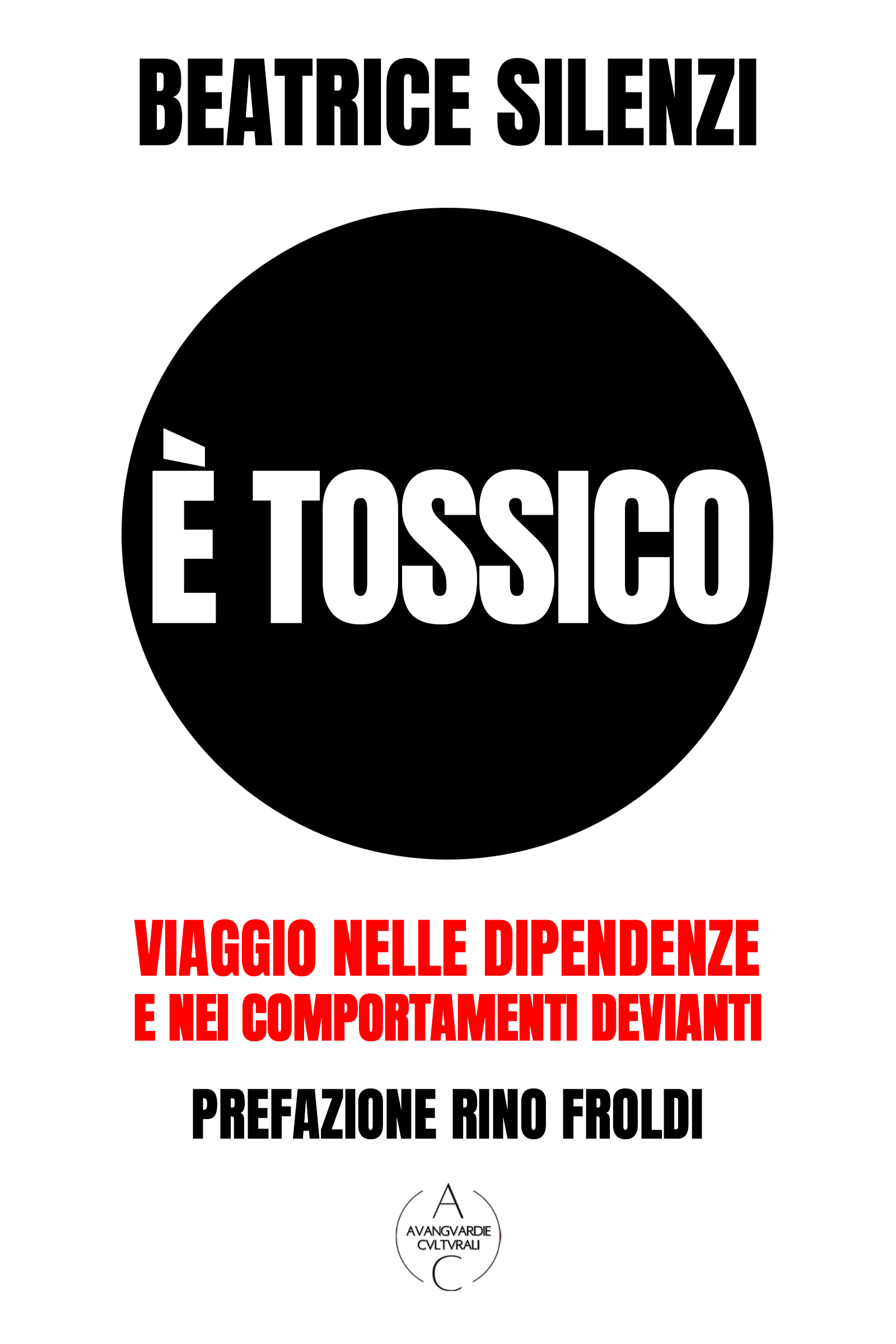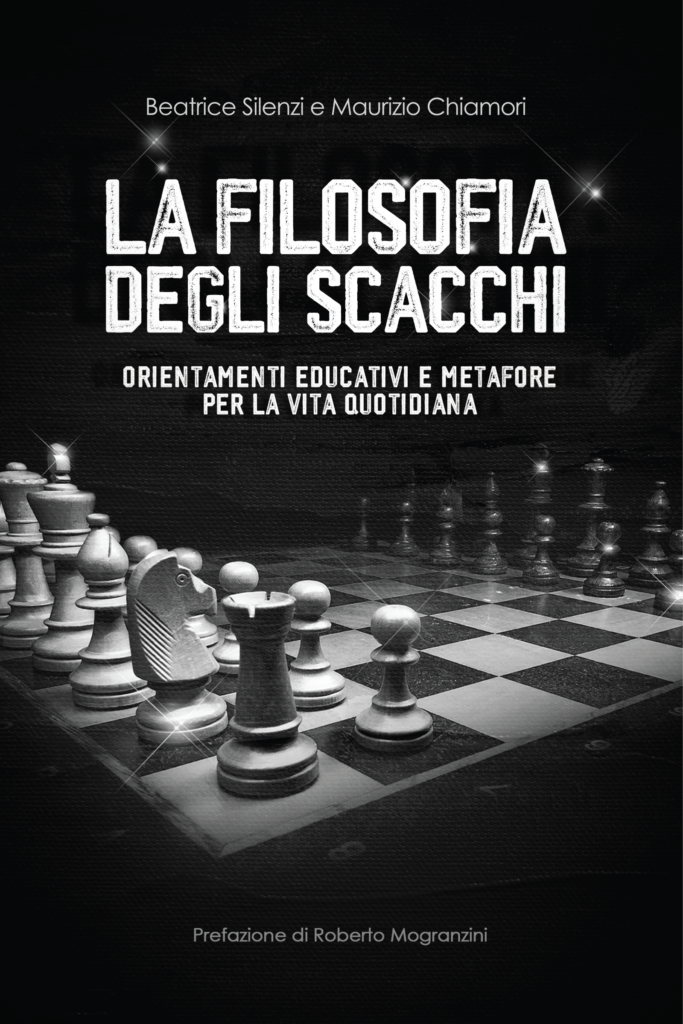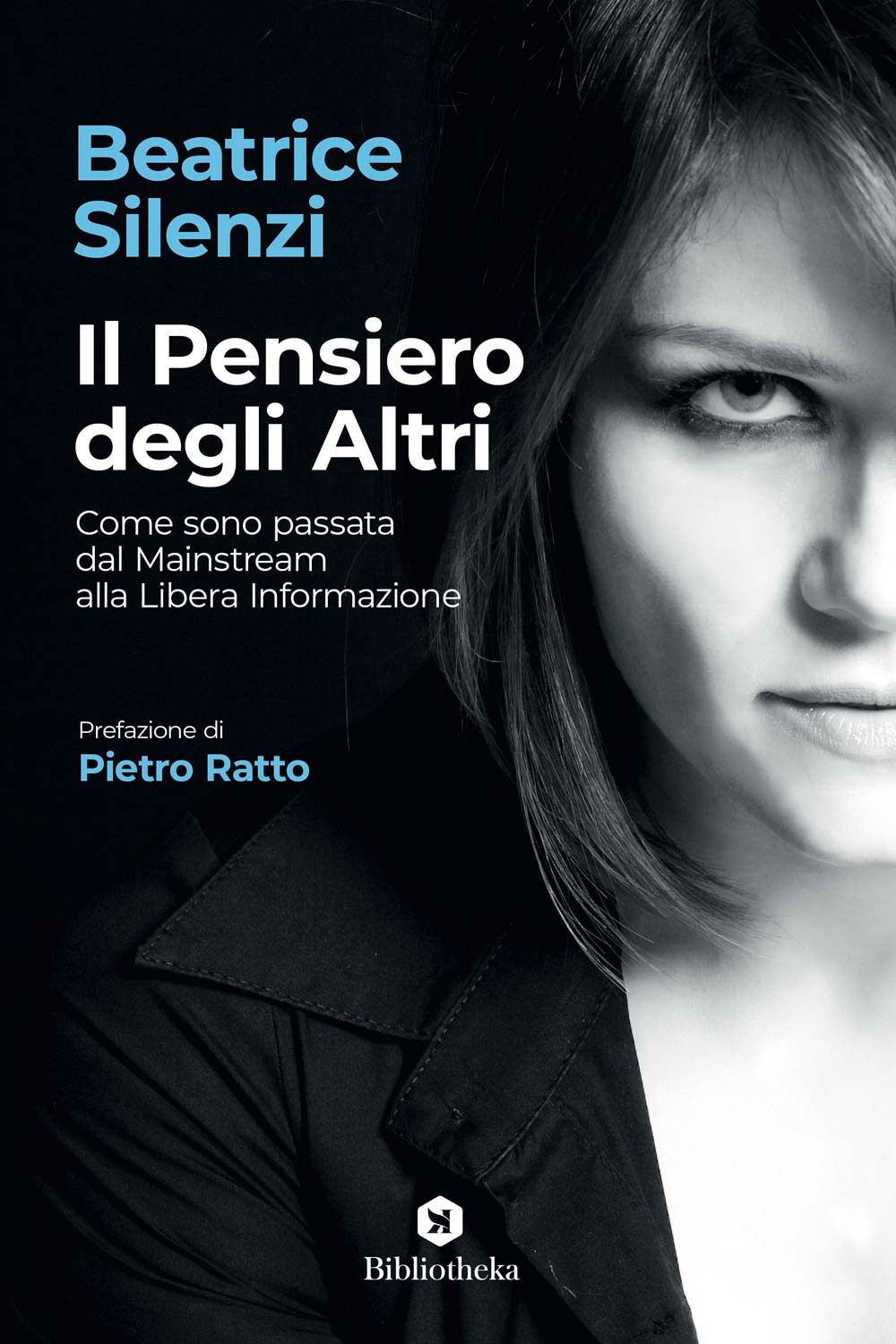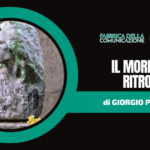Clicca per guardare il video
Su Fabbrica della Comunicazione, la rubrica Viaggio nella Storia Contemporanea è a cura del giornalista e scrittore Franco Fracassi – già co-autore di una collana di 12 volumi dal titolo “Nei Secoli Brevi” – che commenta con Beatrice Silenzi fatti e personaggi degli ultimi 120 anni.
Origini e significato storico del 25 aprile
Il 25 aprile 1945 rappresenta per l’Italia la conclusione formale dell’occupazione nazifascista, un momento di riscatto collettivo che segna la fine di un periodo oscuro.
Contrariamente a narrazioni distorte, non si trattò di una guerra civile, ma di una liberazione da un invasore: la Germania nazista. L’8 settembre 1943, con l’annuncio dell’armistizio, il Paese fu lasciato in balia delle truppe tedesche, che ne occuparono militarmente il territorio.
La Repubblica Sociale Italiana (RSI), istituita a Salò, assunse il ruolo di collaborazionista, sostenendo l’occupante. Questa dinamica differisce da altri contesti europei, dove i collaborazionisti erano spesso élite locali senza precedenti alleanze con i nazisti. La RSI, invece, era composta da ex alleati dei tedeschi, trasformati in strumenti di controllo dopo l’invasione.
Le diverse facce della Resistenza
La Resistenza italiana non fu un fenomeno omogeneo, ma un mosaico di esperienze regionali e sociali.
– Napoli: l’insurrezione spontanea
Un caso unico in Europa fu l’insurrezione di Napoli tra il 27 e il 30 settembre 1943. Senza coordinamento con gli Alleati o i partigiani, la popolazione insorse contro i tedeschi, liberando la città con armi rudimentali e coraggio. Questo episodio, noto come le “Quattro Giornate”, dimostrò come la ribellione popolare potesse nascere dal basso, coinvolgendo donne, bambini e anziani.
– Sicilia: tra sbarchi alleati e potere
In Sicilia, lo sbarco angloamericano del luglio 1943 si intrecciò con gli interessi della mafia, rilegittimata dopo anni di repressione fascista.
Figure come Calogero Vizzini collaborarono con gli Alleati, garantendo controllo sul territorio in cambio di potere. La Resistenza siciliana fu quindi più un’operazione militare esterna che una mobilitazione interna, con eccezioni limitate a gruppi partigiani isolati.
– Roma: la resistenza “borghese”
Nella capitale, la Resistenza assunse tratti peculiari. Il nucleo attivo fu composto da intellettuali, studenti e professionisti, spesso affiliati al Partito Comunista.
I Gruppi Armati Patriottici (GAP), organizzati in cellule segrete, includevano figure come Carla Capponi, aristocratica istruita, e il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, militare monarchico.
La battaglia di Porta San Paolo (8-10 settembre 1943) vide la partecipazione di civili, religiosi e militari, con 51 donne cadute in combattimento.
– Gli Appennini e il Nord: contadini e operai
Nelle zone rurali degli Appennini e nelle fabbriche del Nord, la Resistenza fu animata da contadini e operai.
Nelle campagne, i partigiani trovarono sostegno logistico tra le comunità locali, mentre al Nord, in città come Milano e Torino, gli scioperi del 1943-1944 paralizzarono la produzione bellica.
Qui, la lotta si fuse con rivendicazioni sociali, ponendo le basi per il dopoguerra.
Il ruolo dell’esercito italiano nella Liberazione
Un capitolo spesso trascurato riguarda il contributo delle Forze Armate regolari. Dopo l’8 settembre, molti militari rifiutarono di aderire alla RSI, unendosi alla Resistenza o agli Alleati.
Il Regio Esercito ricostituito (circa 300.000 uomini) combatté a fianco degli angloamericani sulla Linea Gustav e nel Corpo Italiano di Liberazione.
Ufficiali come Montezemolo, fucilato alle Fosse Ardeatine, divennero simboli del riscatto istituzionale. Le armi utilizzate dai partigiani provenivano spesso da depositi militari abbandonati, segnando una continuità tra Stato pre-fascista e nuova Italia.
Morte di Mussolini e fuga di Hitler: due destini divergenti
La fine dei due dittatori riflette dinamiche geopolitiche complesse.
La cattura di Mussolini il 27 aprile 1945 fu orchestrata con precisione. Vestito da soldato tedesco, tentò la fuga verso la Svizzera, ma fu riconosciuto a Dongo da partigiani informati dagli inglesi.
La decisione di giustiziarlo senza processo derivò da pressioni alleate, timorose che rivelasse legami compromettenti con Churchill e l’MI6. La sua figura scomoda, legata a finanziamenti britannici negli anni ’20, fu eliminata per cancellare tracce di collusioni prebelliche.
Fonti documentarie, come il libro *Hitler 1945* di Franco Fracassi, suggeriscono che il Führer fuggì in Sudamerica con l’aiuto di Allen Dulles, futuro capo della CIA.
Già dal 1942, gerarchi nazisti avevano negoziato con gli Alleati per salvarsi in funzione anticomunista.
L’operazione “Paperclip” trasferì scienziati e ufficiali nazisti negli USA, mentre reti come ODESSA li protessero in America Latina. La versione ufficiale del suicidio nel bunker servì a coprire questa operazione.
I trattati postbellici e la subordinazione agli Stati Uniti
L’armistizio di Cassibile (3 settembre 1943) e gli accordi segreti del *Italy Project* legarono l’Italia agli USA in un rapporto asimmetrico.
L’articolo 12 del trattato di Cassibile, vago su concessioni future, diede agli americani carta bianca.
Il *Italy Project*, negoziato con esponenti fascisti, trasformò il Paese in un avamposto anticomunista, con basi NATO e influenza sulla politica interna.
Negli anni ’50-’70, l’Italia tentò di bilanciare l’alleanza atlantica con una diplomazia autonoma. Enrico Mattei, presidente dell’ENI, stabilì accordi con l’URSS e i Paesi arabi, sfidando le major petrolifere.
Aldo Moro promosse il dialogo Mediterraneo, mentre il PCI di Berlinguer sostenne movimenti di liberazione nel Terzo Mondo. Questa fase si chiuse con gli omicidi di Mattei (1962) e Moro (1978), eventi in cui ebbero ruolo servizi deviati e logiche internazionali.
Dagli anni ’90, l’allineamento agli USA è diventato incondizionato. La partecipazione a missioni NATO, come in Jugoslavia e Libia, e l’acquisto di armamenti dimostrano una subordinazione strategica.
Visite di leader italiani alla Casa Bianca, come quella di Giorgia Meloni nel 2023, confermano una dinamica clientelare, senza contropartite concrete.
L’eredità del 25 aprile non è solo memoria, ma monito per il presente. La Resistenza insegnò che l’unità trasversale (militari, civili, monarchici, comunisti) è possibile contro un invasore.
Oggi, la sfida è preservare la sovranità nazionale in un contesto globale segnato da nuove forme di dipendenza. La storia, come dimostrano i trattati del 1943, avverte: la libertà si perde anche con firme su carte oscure.
Beatrice Silenzi ha collaborato con gli autori del libro “Hitler 1945” e “The Italy Project” che trattano approfonditamente queste tematiche e che sono disponibili anche gli audiolibri, scrivendo mail a
francofracassi1@gmail.com
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.