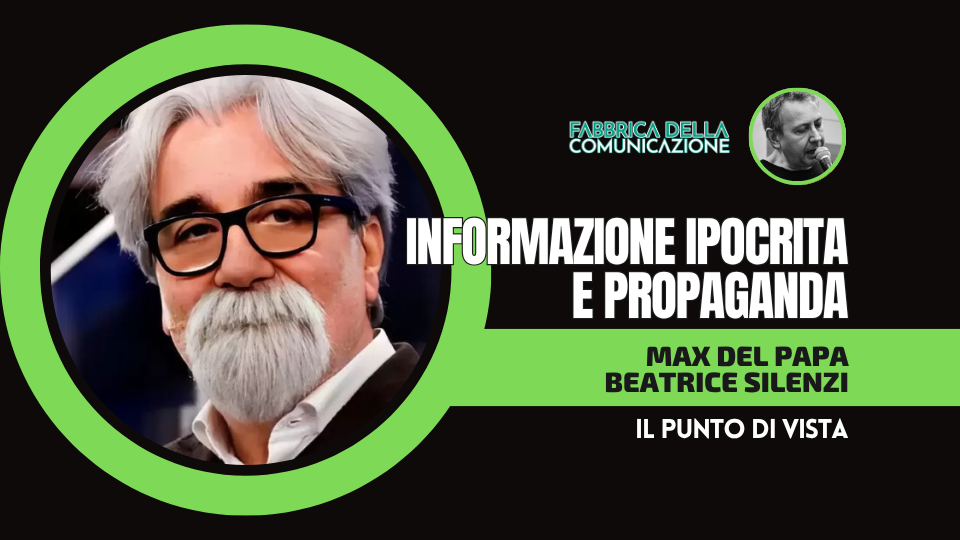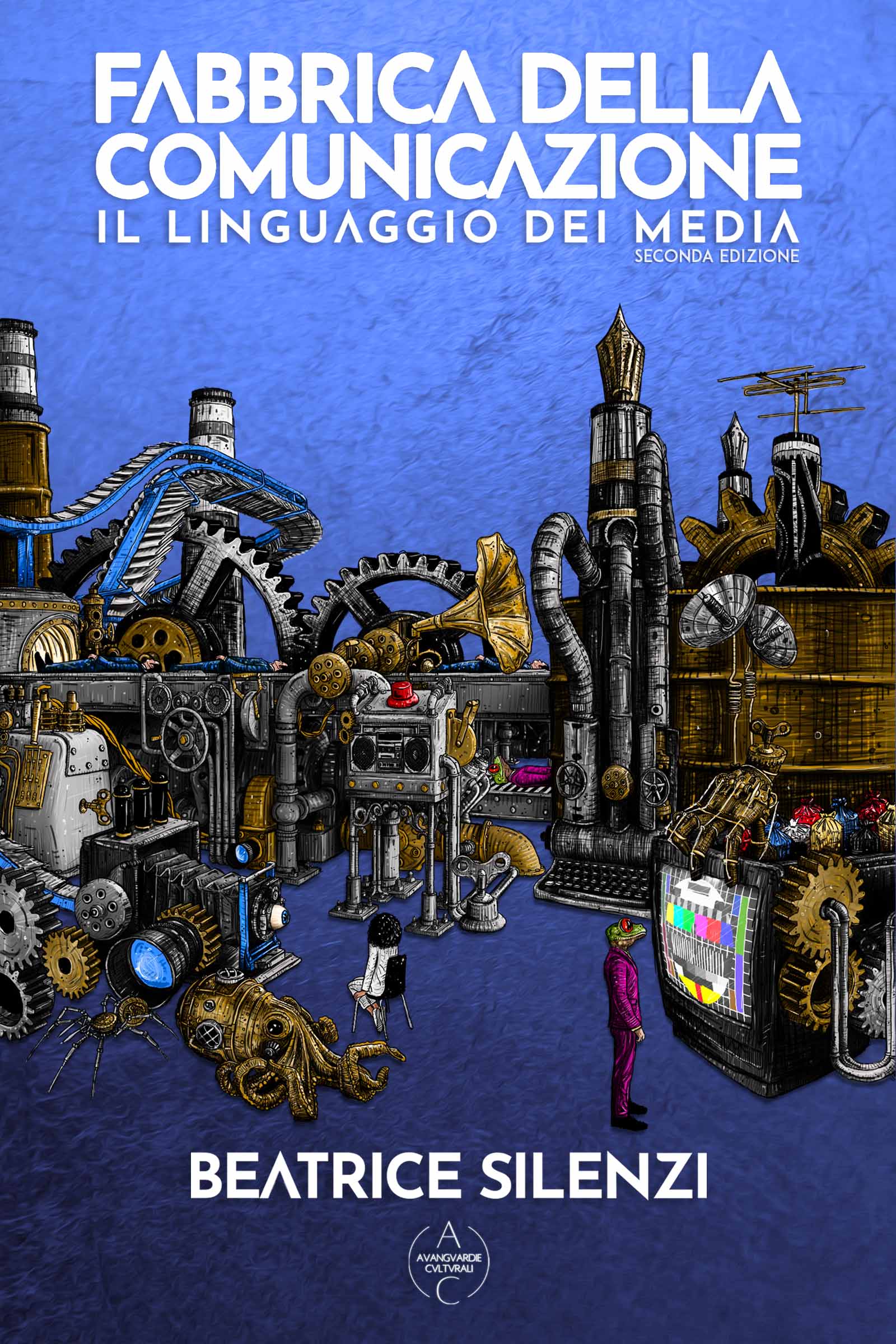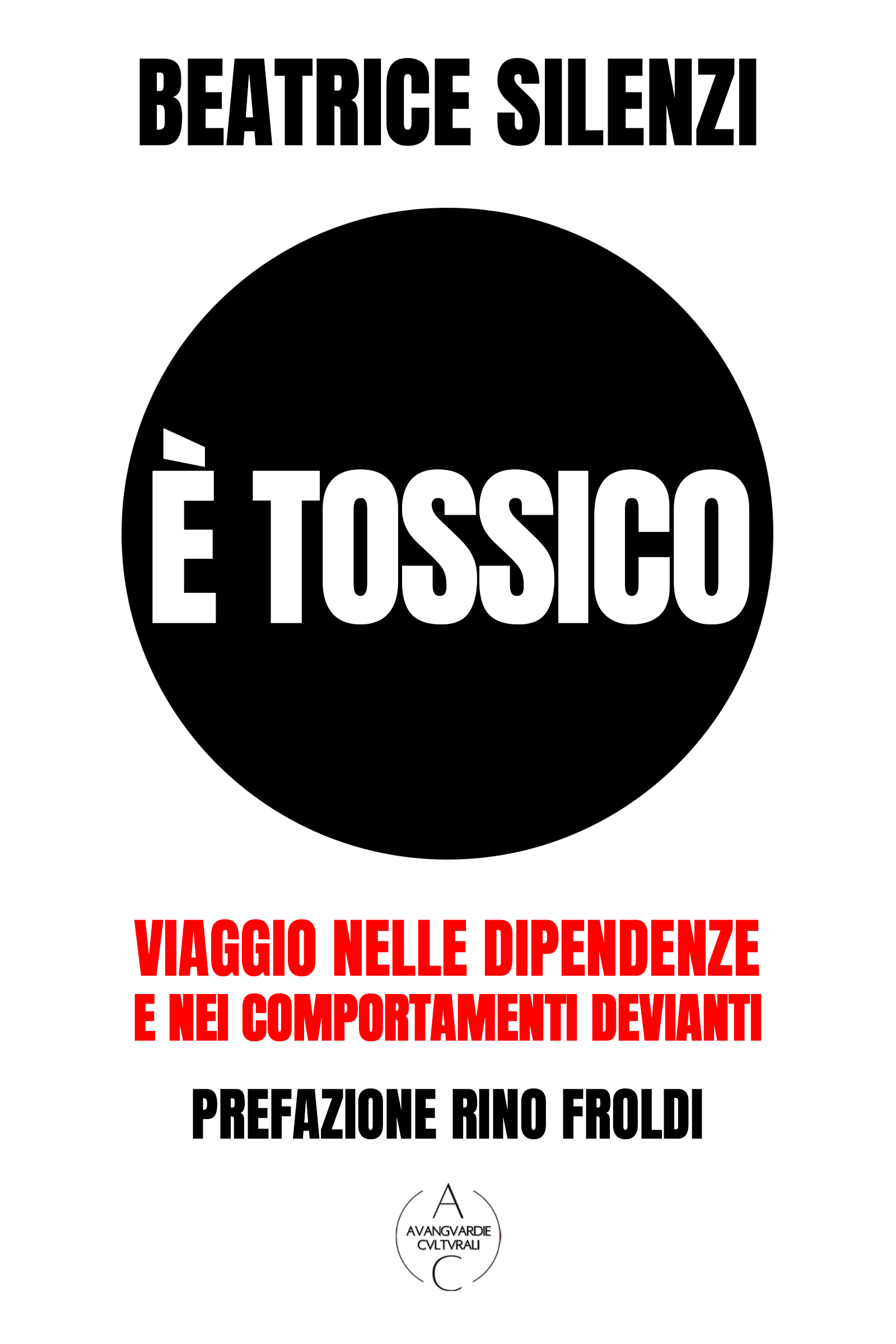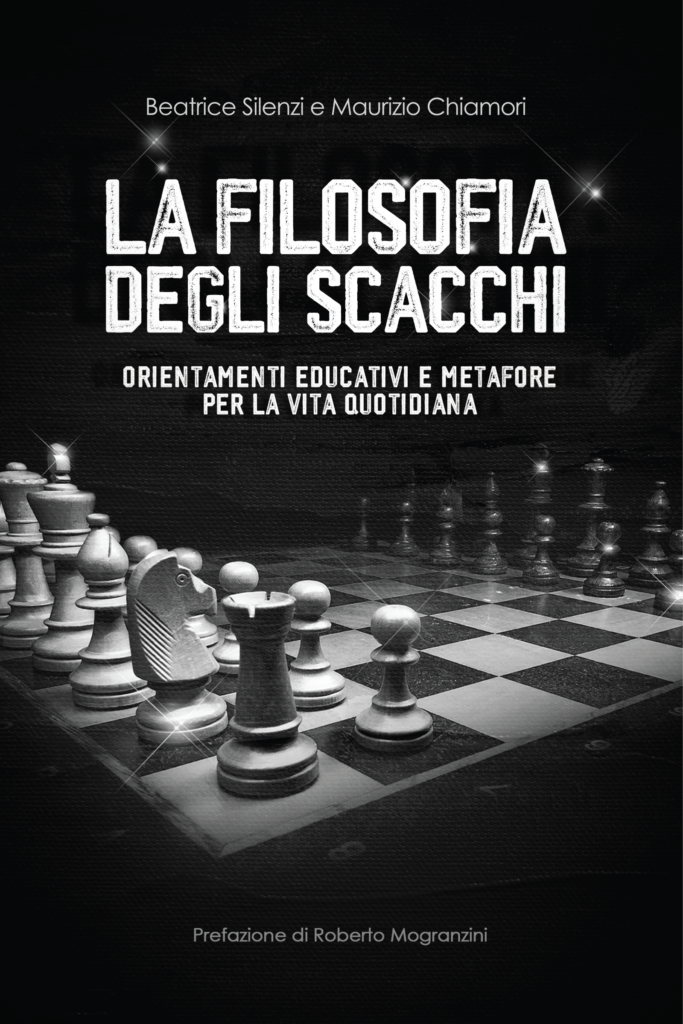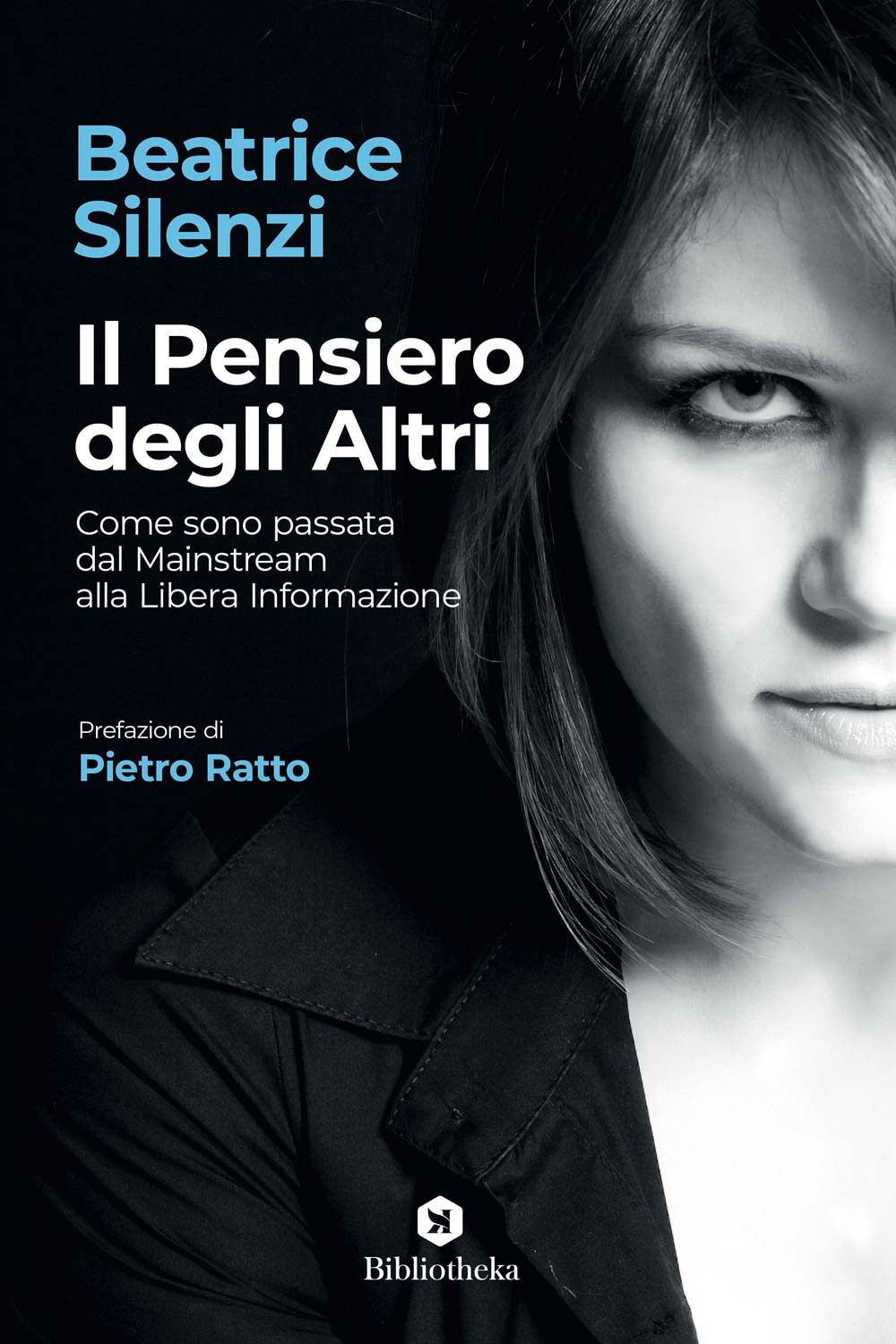Clicca per guardare il video
La rubrica Il Punto di Vista è a cura dello scrittore e giornalista Max del Papa e Beatrice Silenzi, direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
INFORMAZIONE IPOCRITA E PROPAGANDA
La recente e improvvisa scomparsa del maestro Beppe Vessicchio, figura iconica del Festival di Sanremo, ha scosso l’opinione pubblica, non solo per la perdita di un artista amato, ma anche per il vortice di notizie e speculazioni che ne è seguito.
A 69 anni, la sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo della musica e dello spettacolo, diventando però anche il catalizzatore di un dibattito più ampio e spinoso: quello sullo stato di salute dell’informazione e sulla sua crescente incapacità di fornire un quadro chiaro e veritiero dei fatti.
Vessicchio, la BBC e il Funerale dell’Informazione: Quando la Verità è la Prima Vittima
La vicenda di Vessicchio si è trasformata in un emblematico caso di studio sulla confusione mediatica contemporanea. Le prime ore successive alla notizia sono state caratterizzate da un’incertezza sulla causa del decesso, terreno fertile per il proliferare di ipotesi e congetture.
Si è parlato di problematiche pregresse, di una presunta familiarità con patologie gravi, fino all’emergere della diagnosi di polmonite interstiziale.
È a questo punto che il dibattito si è infiammato, intersecandosi con uno dei temi più divisivi degli ultimi anni: i vaccini.
Sono emerse voci, non confermate ufficialmente, secondo cui il maestro si sarebbe sottoposto a quattro dosi di vaccino anti-Covid e che, sentitosi poco bene, gli sarebbe stato somministrato un vaccino antinfluenzale poco prima del fatale peggioramento.
Questa narrazione ha immediatamente spaccato l’opinione pubblica e la stessa informazione.
Da un lato, testate come Open si sono affrettate a smentire qualsiasi correlazione tra il decesso e la vaccinazione, citando esperti e fornendo spiegazioni mediche sulla polmonite interstiziale.
Dall’altro, si è levato il coro di chi ha sollevato dubbi, ponendo domande sulla tempistica e sulle condizioni del maestro, sottolineando come la comunità scientifica internazionale non sia unanime nel negare possibili effetti avversi dei vaccini a mRNA.
Il problema, tuttavia, non risiede tanto nel sostenere una tesi o l’altra, quanto nel metodo con cui l’informazione ha gestito la vicenda. Invece di un’analisi pacata e basata sui fatti, si è assistito a una battaglia ideologica.
Da una parte i “negazionisti” di ogni correlazione, dall’altra i “complottisti” pronti a vedere un nesso in ogni evento. In questo scontro tra fanatismi, il giornalismo ha spesso abdicato al suo ruolo fondamentale: fare domande, ricostruire il contesto, presentare i fatti nella loro complessità, senza la pretesa di avere certezze assolute ma con l’onestà di esplorare ogni legittimo dubbio.
Questa crisi di credibilità non è un fenomeno esclusivamente italiano. A riprova di ciò, è quasi contemporaneo lo scandalo che ha travolto la BBC, un’istituzione considerata a lungo un faro del giornalismo mondiale.
L’emittente britannica è stata accusata di aver manipolato discorsi dell’ex presidente americano Donald Trump, tagliando e montando ad arte alcuni passaggi per presentare un messaggio distorto e allarmistico.
Uno scandalo di proporzioni epocali, che ha portato alle dimissioni di due figure di spicco e ha inferto un colpo durissimo alla reputazione della BBC.
Questo episodio, così come le accuse di parzialità nella copertura di altri temi caldi come il conflitto a Gaza, dimostra come la tentazione di piegare i fatti alla propria narrazione ideologica sia una malattia che affligge anche le testate più blasonate.
In Italia, la situazione è ulteriormente aggravata da una commistione tossica tra informazione, politica e spettacolo.
Il giornalista Giulio Meotti ha provocatoriamente affermato che “l’informazione l’hanno uccisa i giornalisti”, una riflessione amara ma condivisibile sulla perdita di credibilità di una categoria che troppo spesso si comporta più da influencer o da attore politico che da mediatore imparziale.
Le “porte girevoli” tra redazioni e parlamenti, i condizionamenti economici degli sponsor
Un’ideologia “woke” che impone una lettura univoca della realtà, hanno eroso la fiducia del pubblico.
La distinzione tra informazione “mainstream” e “alternativa” è diventata sempre più labile e ingannevole. Spesso chi si erge a paladino dell’informazione “indipendente” opera con gli stessi meccanismi di propaganda e manipolazione, semplicemente a favore di una diversa agenda. Non esiste un’informazione senza “padrone”, che sia esso politico, economico o ideologico.
La vera differenza, un tempo, risiedeva in un senso di decenza e di limite che oggi sembra smarrito.
In questo contesto preoccupante si inserisce la recente decisione del governo italiano di istituire un albo per influencer e youtuber, con multe salatissime (da 250.000 a 600.000 euro) per chi diffonde contenuti ritenuti “nocivi”.
Una misura che, dietro la maschera della tutela, introduce un pericoloso strumento di controllo e un potenziale bavaglio alla libertà di espressione, paradossalmente attuato da un governo di destra che realizza un vecchio sogno della sinistra autoritaria.
Dalla morte di Vessicchio allo scandalo della BBC, emerge un quadro desolante. L’informazione, divorata dalla comunicazione e dalla pubblicità, sembra aver perso la sua bussola. In un mondo assetato di certezze, il giornalismo dovrebbe offrire il dubbio, la complessità, l’analisi critica.
Invece, troppo spesso, fornisce solo dogmi, tifoserie e una realtà semplificata ad uso e consumo della propaganda. E in questo funerale dell’informazione, la prima vittima è sempre la verità.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.