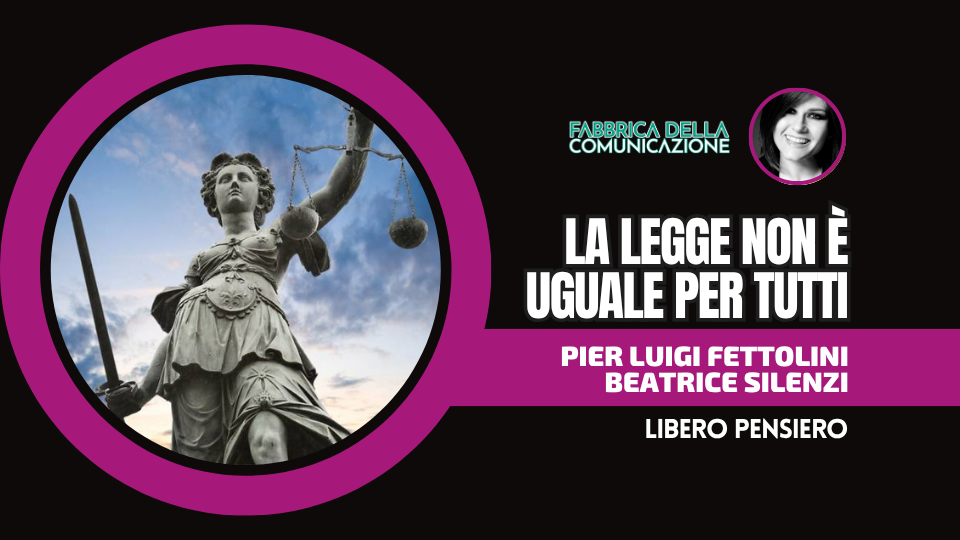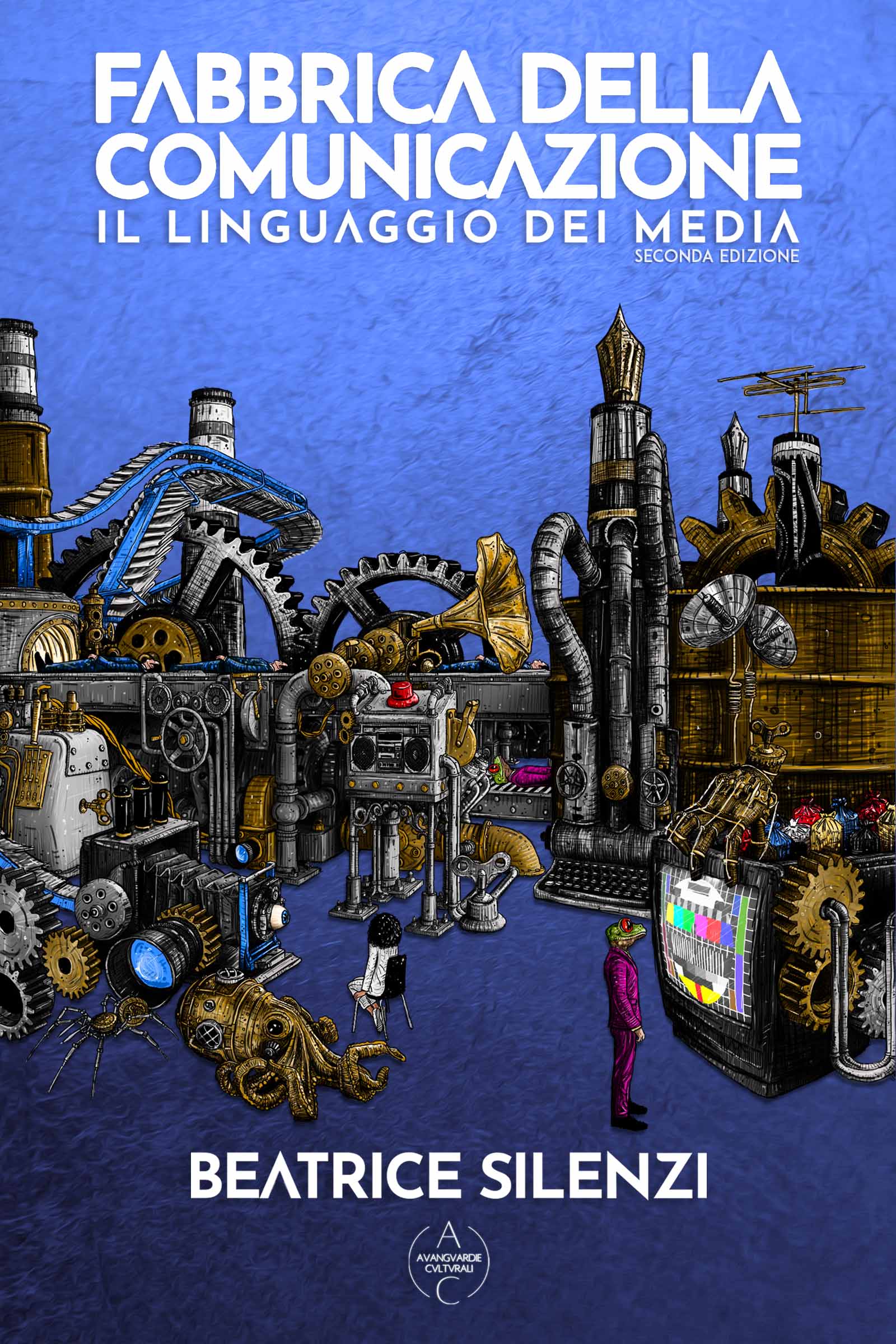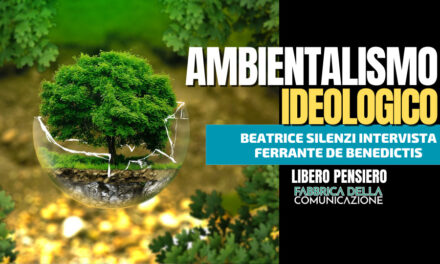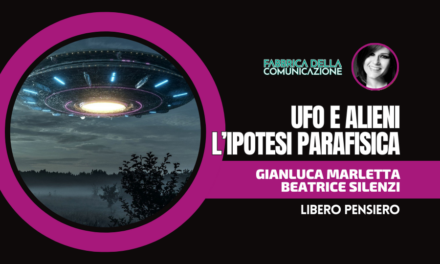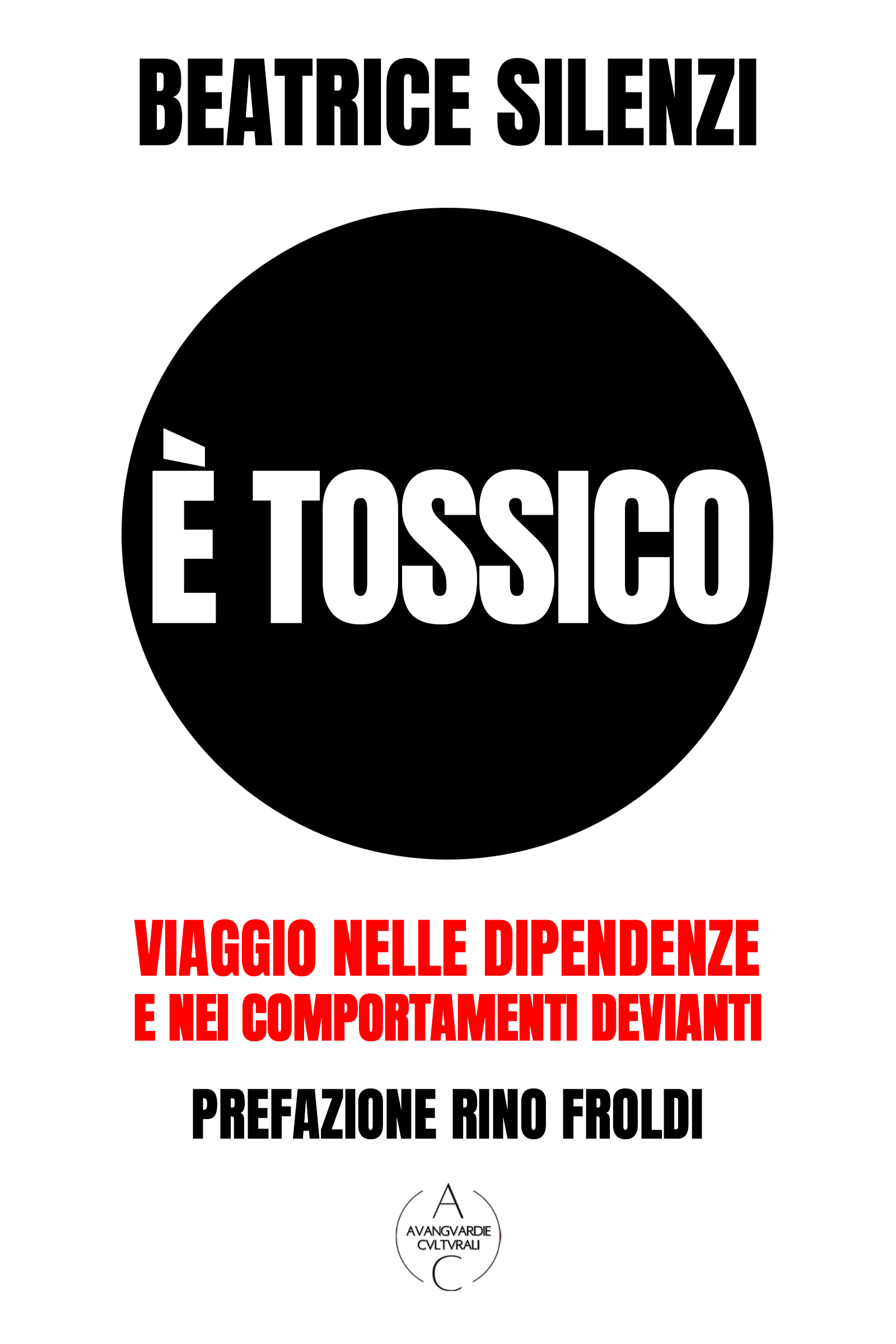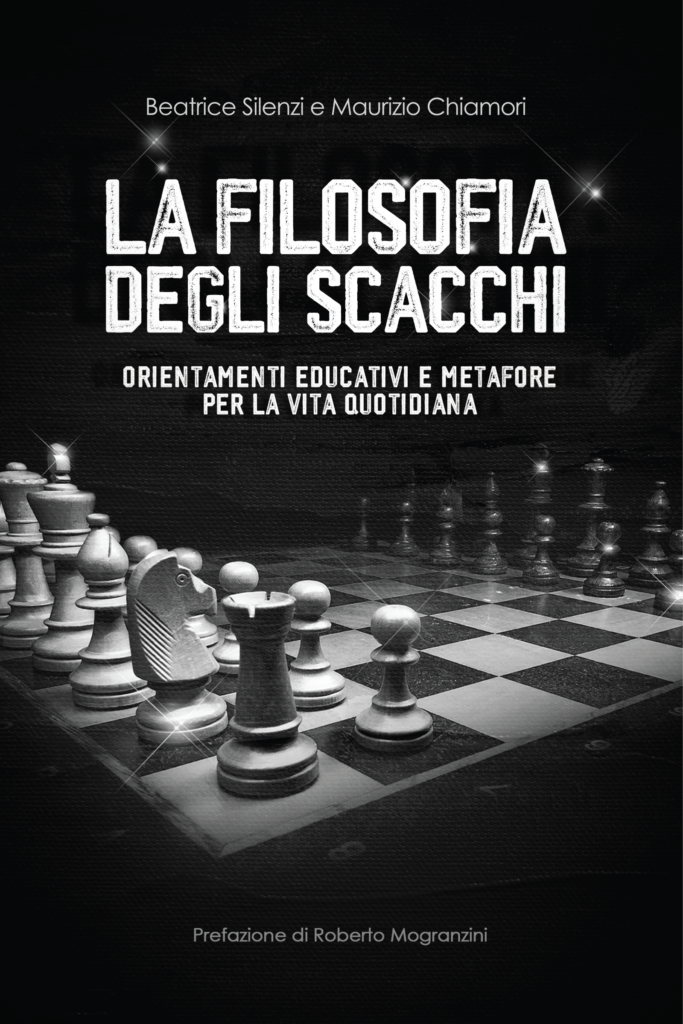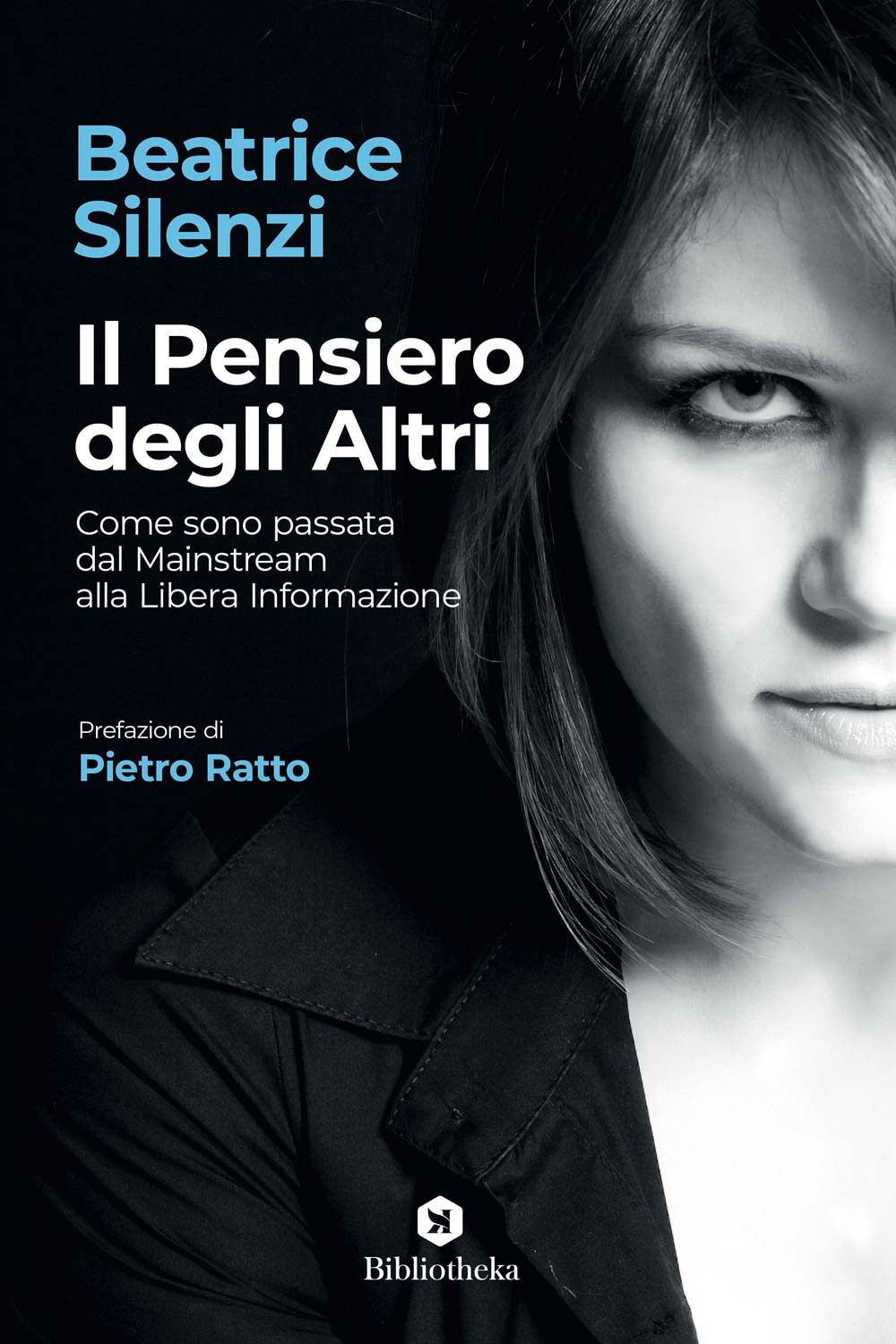Clicca per guardare il video
Su Fabbrica della Comunicazione la rubrica Libero Pensiero è cura di Beatrice Silenzi – giornalista e direttore responsabile, qui con Pier Luigi Fettolini.
Entrate in un’aula di tribunale.
Alzate lo sguardo. Prima ancora di incrociare quello del giudice, ne incontrerete un altro, più severo e impersonale: quello della scritta che domina la parete. “La legge è uguale per tutti”.
È più di una frase; è un patto di fiducia tra lo Stato e il cittadino, la promessa solenne che, di fronte alla bilancia della giustizia, ogni differenza di censo, potere o estrazione sociale svanirà.
Ma cosa succede quando quella promessa si rivela un’illusione? E se quella scritta, anziché descrivere una realtà, non fosse altro che un dogma da recitare per tenere in piedi un sistema profondamente iniquo?Questa è la tesi, brutale e senza sconti, sostenuta dall’avvocato Pierluigi Fettolini durante una discussione per “Fabbrica della Comunicazione”.
Con la lucidità di chi vive quotidianamente le contraddizioni del sistema, Fettolini risponde alla domanda fondamentale con un “monumentale no”, invitando a un “risveglio” collettivo da quella che definisce una “bella addormentata” concezione della giustizia.
La sua analisi non è un semplice sfogo, ma una meticolosa decostruzione di un castello di carte, che rivela come il diritto, in Italia, sia pesantemente condizionato da tre fattori ineludibili: il denaro, il potere e un disegno politico volto a scoraggiare, più che a servire, il cittadino.
Il primo, e forse più insormontabile, ostacolo all’uguaglianza è di natura economica. La giustizia, nel concreto, non è un diritto gratuito, ma un servizio con un costo.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è il velo che dovrebbe nascondere questa cruda realtà, garantendo assistenza legale ai meno abbienti.
Fettolini, però, lo squarcia senza pietà. Questo strumento, spiega, è un cerotto su una ferita profonda. Non solo non tutte le cause sono ammesse al patrocinio, ma la sua copertura è parziale e spesso insufficiente per una difesa ad armi pari.
L’esempio più calzante è la figura del Consulente Tecnico di Parte (CTP). In un contenzioso complesso, la perizia di un esperto di parte è fondamentale per dialogare, e se necessario contrastare, le conclusioni del perito nominato dal giudice (CTU).
La parcella di questo professionista, tuttavia, non rientra nel gratuito patrocinio. Il risultato è una disparità abissale: la parte facoltosa può schierare un proprio esperto per orientare la perizia, mentre la parte più debole deve subire passivamente le conclusioni del CTU, trovandosi di fatto disarmata.
Questa dinamica esplode con drammatica evidenza nel diritto di famiglia. Il divorzio, sancito come un diritto civile, diventa nella pratica un privilegio per ricchi.
Per una coppia con un reddito medio e figli a carico, l’idea di sdoppiare le spese – due affitti, due set di utenze, il mantenimento – è semplicemente insostenibile. “Le nostre nonne”, osserva Fettolini, “non divorziavano non solo per un diverso costrutto culturale, ma per una questione molto concreta: ‘dove vado?'”.
Il diritto esiste, ma il suo esercizio ha un costo che lo rende irraggiungibile, trasformando la libertà di scelta in una prigione economica.
Se il denaro è il primo muro, il potere politico e l’influenza sono la fortezza che vi si erge alle spalle.
Fettolini non teme di fare nomi e cognomi, citando casi che sono diventati il simbolo di una giustizia a due velocità. Parla degli “intoccabili”, come i cittadini americani coinvolti in gravi fatti di cronaca sul suolo italiano, che, in un modo o nell’altro, riescono quasi sempre a evitare una condanna definitiva.
Ma l’esempio più eclatante è quello di Silvio Berlusconi, un uomo che secondo l’avvocato, se non avesse avuto il suo nome e il suo potere, “avrebbe passato tre quarti della vita in carcere”, e che invece ha ricevuto come massima pena un “premio di consolazione” sotto forma di affidamento ai servizi sociali.
Il problema, tuttavia, è ancora più radicale. Il potere non si limita a influenzare i processi; scrive le regole del gioco a proprio vantaggio.
Il Parlamento decide cosa è reato e cosa non lo è. Ed è qui che si cela il paradosso: “I parlamentari”, afferma Fettolini, “non renderanno mai reati quelle condotte che loro stessi commettono più di frequente”.
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio è l’esempio perfetto. Si trattava di un illecito tipico di chi detiene una carica pubblica, non del cittadino comune.
La sua cancellazione dall’ordinamento è stata un’auto-assoluzione preventiva, un modo per la classe politica di garantirsi l’impunità.
Nel 2016, una significativa riforma ha depenalizzato una lunga serie di reati, tra cui l’ingiuria e il danneggiamento semplice. La motivazione ufficiale era snellire la macchina della giustizia.
In realtà, sostiene Fettolini, è stata una manovra per scoraggiare i cittadini. Un fatto che prima poteva essere denunciato gratuitamente alle forze dell’ordine, innescando un procedimento penale, è stato trasformato in un mero illecito civile.
Questo cambiamento ha conseguenze devastanti per l’accesso alla giustizia. Il cittadino offeso o danneggiato non può più contare sull’azione dello Stato. Se vuole un risarcimento, deve avviare una causa civile a proprie spese: pagare un avvocato e versare il contributo unificato.
È un calcolo semplice: nessuno spenderà migliaia di euro per un danno di poche centinaia. La porta della giustizia, di fatto, viene sbarrata.
Questa dinamica, secondo Fettolini, alimenta un clima da “Far West”, dove, venendo meno la tutela dello Stato, si fa strada la tentazione di una giustizia privata e sommaria. Non è un errore di sistema, ma il suo preciso funzionamento: creare ostacoli per ridurre la domanda e mantenere un controllo più saldo in un contesto di caos controllato.
Tutte queste storture sono emerse in modo inequivocabile durante l’emergenza pandemica. Quella fase storica, secondo Fettolini, è stata il pretesto per sferrare “un attacco diretto e feroce” alla Costituzione italiana.
Diritti fondamentali, considerati inviolabili, sono stati compressi e sospesi in nome di una logica emergenziale che ha spazzato via decenni di tutele giuridiche.
Ancora una volta, l’impatto non è stato uguale per tutti. La sospensione dal lavoro ha colpito in modo drammaticamente diverso chi viveva del proprio stipendio e chi poteva contare su ingenti risparmi.
Una multa di 100 euro, insignificante per un benestante, ha rappresentato un onere gravoso per una famiglia a basso reddito.
Qui emerge la verità più cruda, condensata in una frase lapidaria di Fettolini: “La tua libertà è correlata al tuo 730”. Se la legge fosse davvero uguale per tutti, le sanzioni dovrebbero essere parametrate al reddito, per avere lo stesso impatto dissuasivo su chiunque.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.