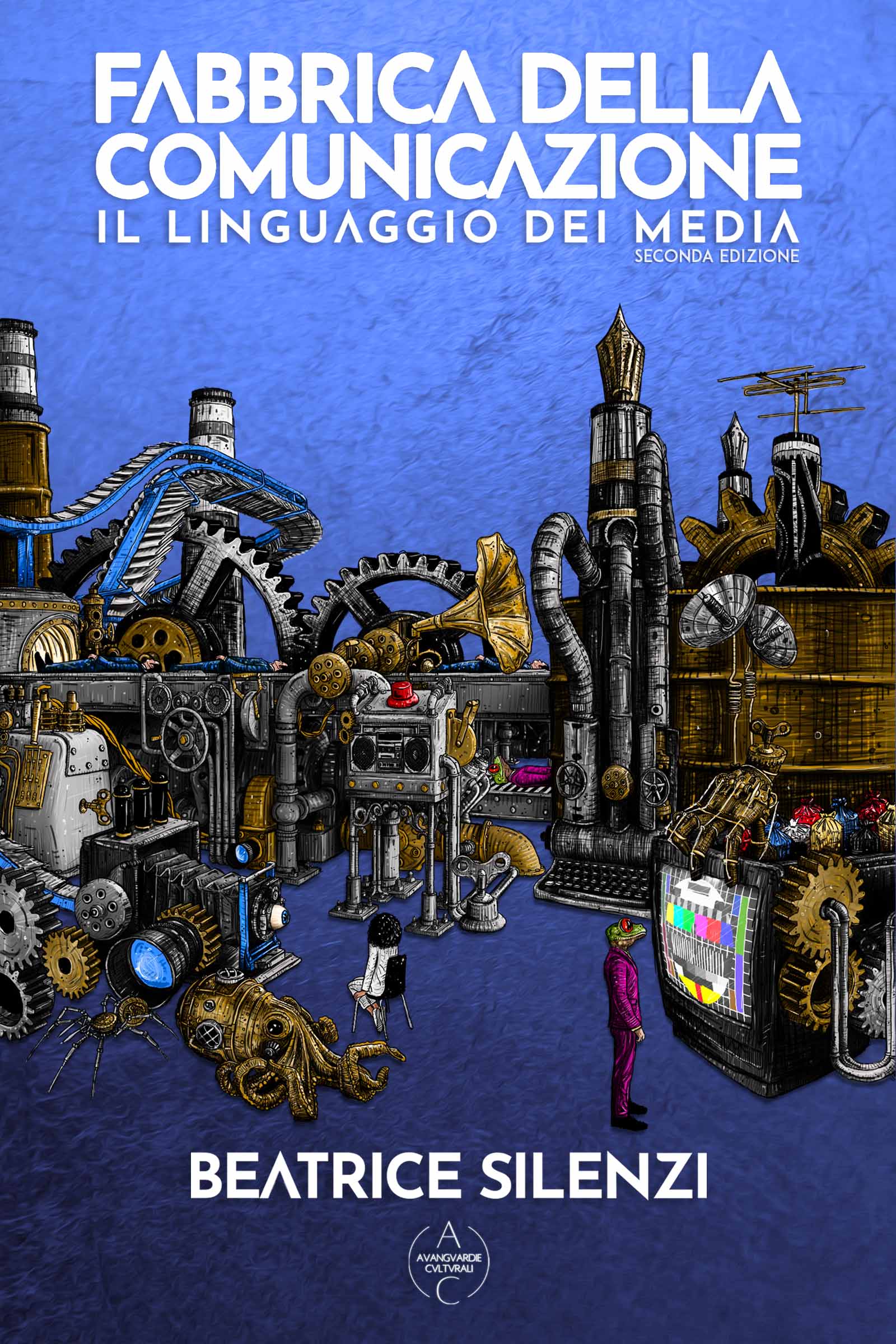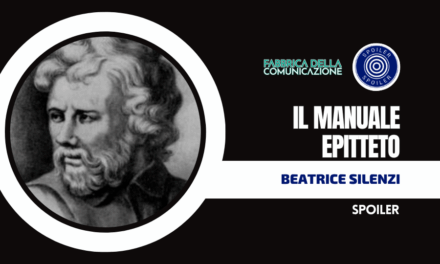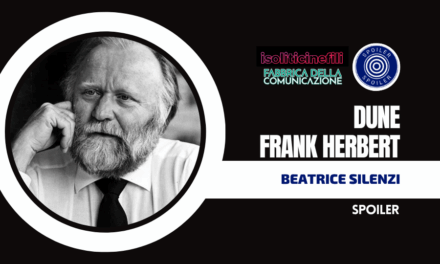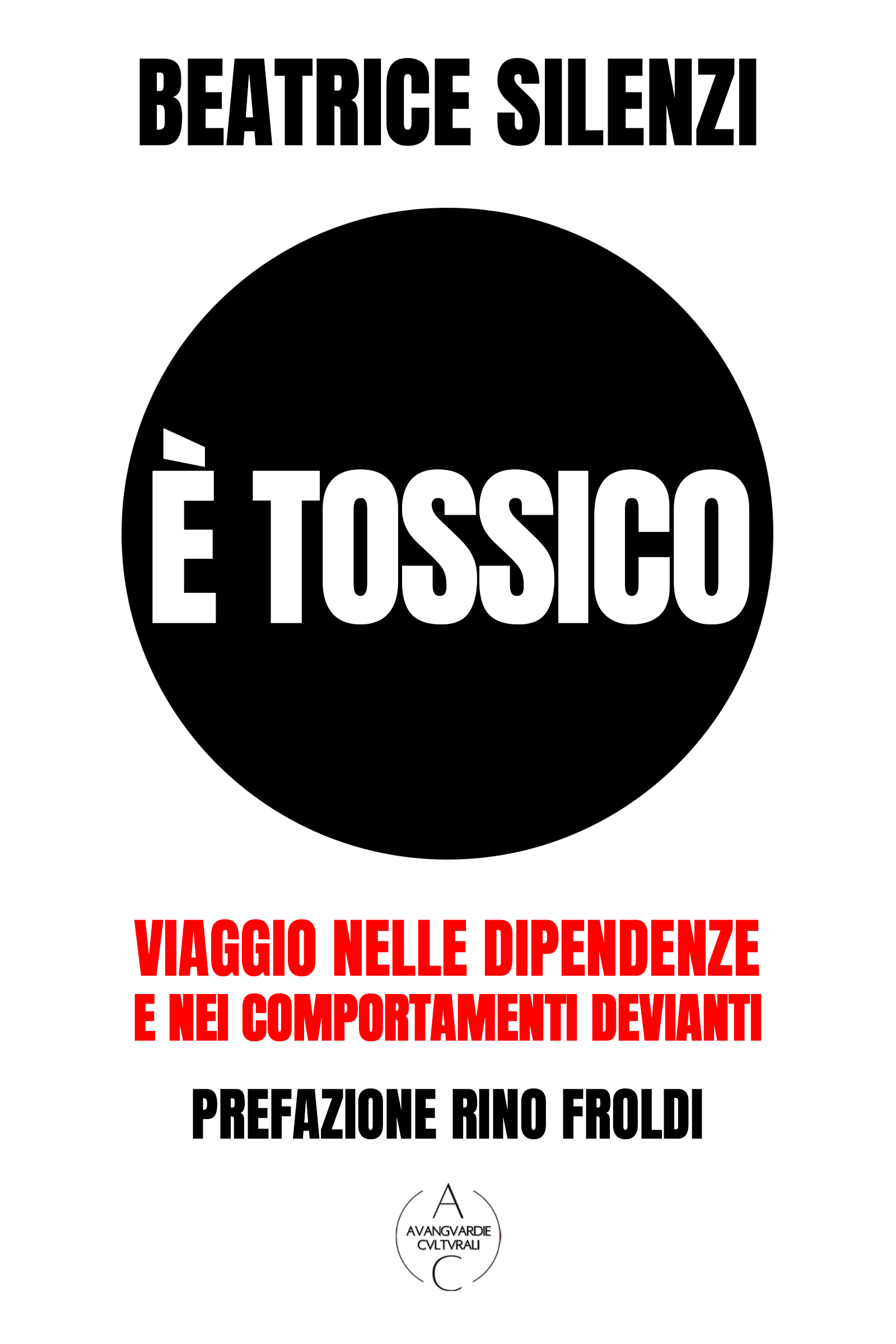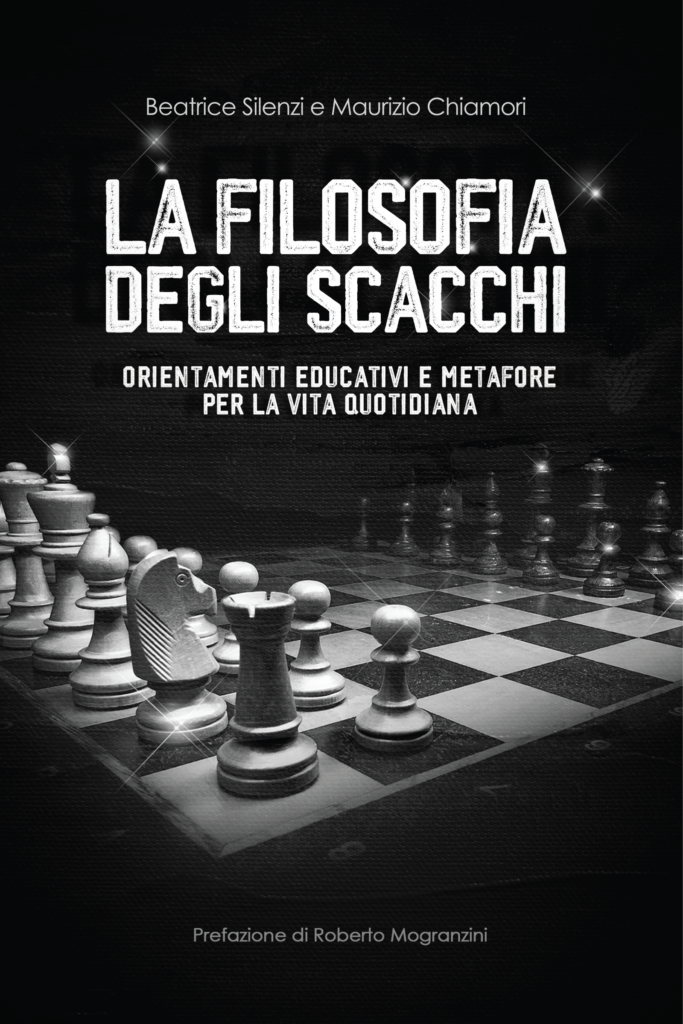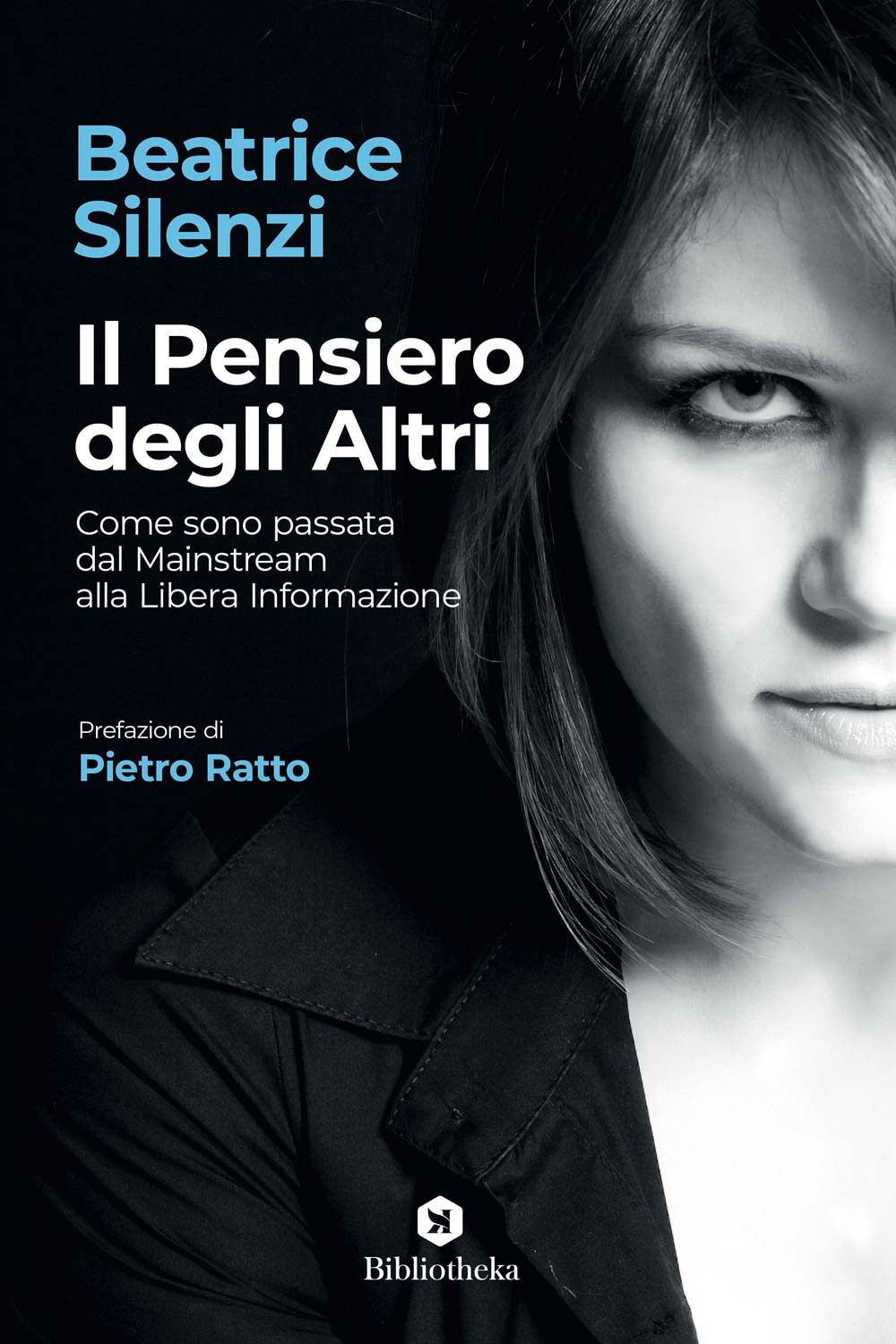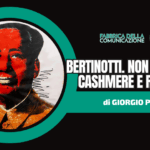Clicca per guardare il video
La rubrica Spoiler – podcast è cura della giornalista Beatrice Silenzi – direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
Segui tutti gli appuntamenti di Spoiler sul nostro sito.
L’ombra dello scorpione di Stephen King è un grande affresco di parole
Siamo nel 1978, e per colui che sarà chiamato il “Re dell’horror”, è il quarto lavoro uscito a suo nome (il quinto, se si considera quello pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman).
Stephen King immagina la fine del mondo. La realizza attraverso un’epidemia incontrollabile nata dalla dispersione di un’arma batteriologica sfuggita al controllo dell’uomo dai laboratori del governo statunitense: un virus conosciuto con il nome formale di Progetto Azzurro, mutazione letale dell’agente causa dell’influenza, caratterizzato da un tasso di infettività e di mortalità del 99 per cento.
In poche settimane, il mondo resta popolato da pochissimi esseri umani immuni.
Le città deserte sono punteggiate di cadaveri, il silenzio irreale è rotto solo dall’eco del vento, seguendo un topos letterario già oggetto di grandi classici e del romanzo del 1949 di George R. Stewart.
La potenza dell’idea risiede nella verosimiglianza, nell’aspetto scientifico, nell’imperizia umana. Stephen King attinge all’immaginario religios, alla tradizione epica, al dark fantasy. L’ombra dello scorpione riflette e amplifica paure che richiamano incidenti realmente avvenuti, la sfiducia verso le istituzioni, la tendenza governativa a nascondere errori fatali, la Guerra Fredda e, sullo sfondo, la disillusione post-Vietnam.
L’ombra dello scorpione è costruito come un’opera in tre atti, di respiro quasi cinematografico.
Nella prima parte spesso indicata come “Captain Trips”, dal soprannome dato al virus si assiste alla rapida diffusione dell’epidemia e al crollo della civiltà che King gestisce magistralmente in un costante crescendo di tensione.
Segue una lunga parte centrale dedicata al viaggio e alla rifondazione
Nella parte centrale del romanzo, la narrazione assume un ritmo più dilatato in cui King sceglie di costruire i personaggi con grande cura, spesso attraverso flashback delle loro vite prima dell’epidemia e dettagli quotidiani che li rendono estremamente veri.
Nell’ultima parte, infatti, si assiste al viaggio dei protagonisti rimasti verso Las Vegas e all’inevitabile resa dei conti. Se la struttura generale fino a questo punto ricalca quella di un’epica on the road, il finale rompe alcuni schemi.
Il Male viene sconfitto, e a caro prezzo, e con modalità quasi casuali che lasciano spazio a riflessioni sull’assurdità della violenza e, con il suo gusto tipico per l’ignoto King suggerisce che essenza del male, possa in qualche forma tornare, altrove. Poiché il Male è destinato a risorgere periodicamente.
Ma cosa succederebbe se all’improvviso l’uomo non dovesse più rispettare leggi e norme sociali, e potesse comportarsi liberamente come crede per proteggere se stesso?”.
Ecco che il romanzo punta l’attenzione sulla condizione umana nello stato di natura. Privati d’un tratto di governo, istituzioni, tecnologia e perfino della semplice presenza di altri esseri umani, i personaggi reagiscono in modi completamente differenti.
E il comportamento dell’essere umano, lasciato a se stesso, degenera inevitabilmente in sopraffazione reciproca (come ricorda il celebre homo homini lupus) o sceglie spontaneamente di collaborare per il bene comune?
Le risposte non sono semplici: in ciascuno coesistono luci ed ombre, e spesso la combinazione di scelte o seduzioni esterne fa pendere l’ago della bilancia.
Lungo tutto il romanzo aleggia la sensazione che gli eventi seguano un copione già scritto da forze superiori: alcuni personaggi appaiono predestinati nel loro ruolo e King dissemina nel testo, visioni e coincidenze provvidenziali che suggeriscono un piano più grande.
L’ombra dello scorpione è il libro di King che gli ha richiesto più tempo: quasi un anno e mezzo per la prima stesura,poiché, per quanto la storia e i personaggi gli piacessero, lo scrittore era giunto ad un punto morto e probabilmente avrebbe abbandonato il progetto, se non avesse già scritto cinquecento pagine e non fosse stato convinto che il romanzo era. buono.
Nelle sequenze più drammatiche l’autore non risparmia dettagli grafici e crudi: una morbosità volutamente scioccante, marchio di fabbrica di King, che non edulcora la realtà dell’orrore.
La rilevanza attuale dell’opera, è stata amplificata dalla realtà reduce dall’esperienza globale della pandemia di Covid-19 che ha spinto molti a riscoprire, tra gli altri, anche il romanzo di King ed innumerevoli articoli ne hanno citato l’inquietante somiglianza.
In un’era segnata da crisi mondiali (sanitarie, ecologiche, geopolitiche) il romanzo di King risuona con forza: basti pensare alla diffidenza verso le autorità e alle vicenda del laboratorio militare che richiama quello cinese di Wuhan, in cui il confine tra notizie attendibili e fake news si fa labile, in cui la polarizzazione estrema rappresentata da due comunità contrapposte viene letta come una metafora delle spaccature ideologiche contemporanee, in cui sembra sempre più difficile trovare una via moderata.
King è stato lungimirante nel raccontare come di fronte a un disastro epocale l’umanità tenda a dividersi non solo sul piano morale, ma anche in tribù contrapposte: un messaggio implicito che è anche un monito: se mai ci troveremo a dover ricostruire la società da zero, quali valori sceglieremo?
La risposta, suggerisce King, determinerà la nostra salvezza o il nostro ulteriore declino.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.