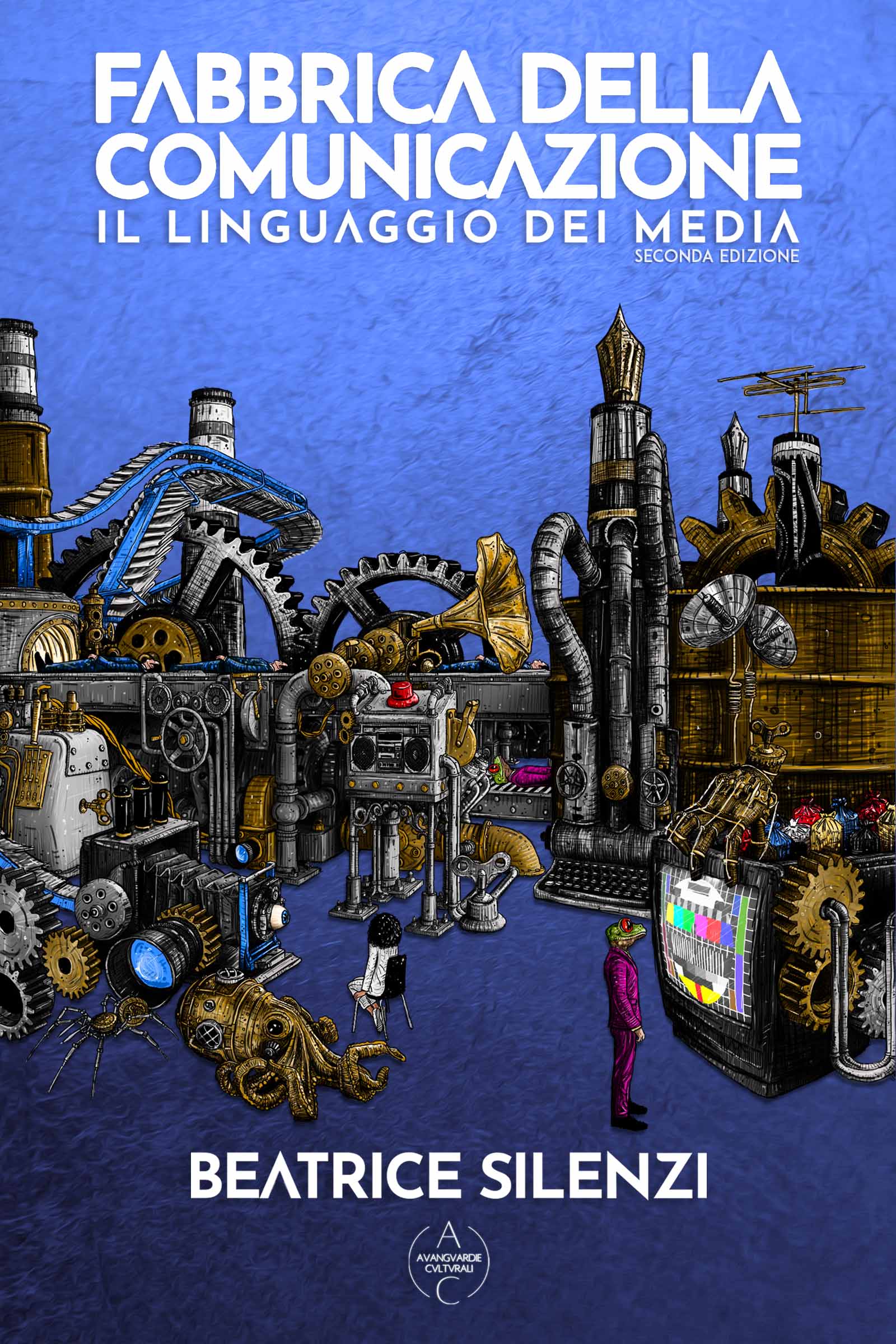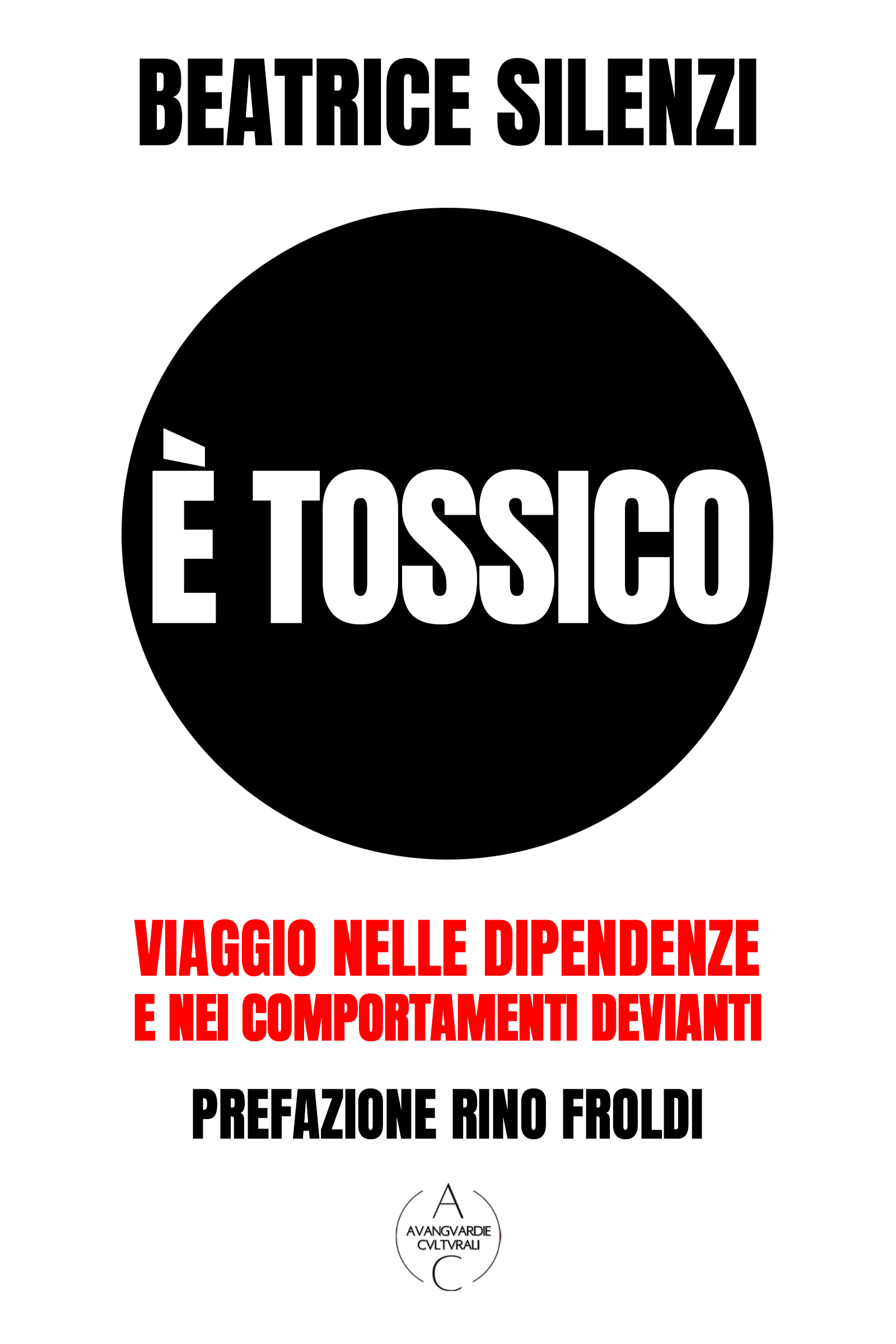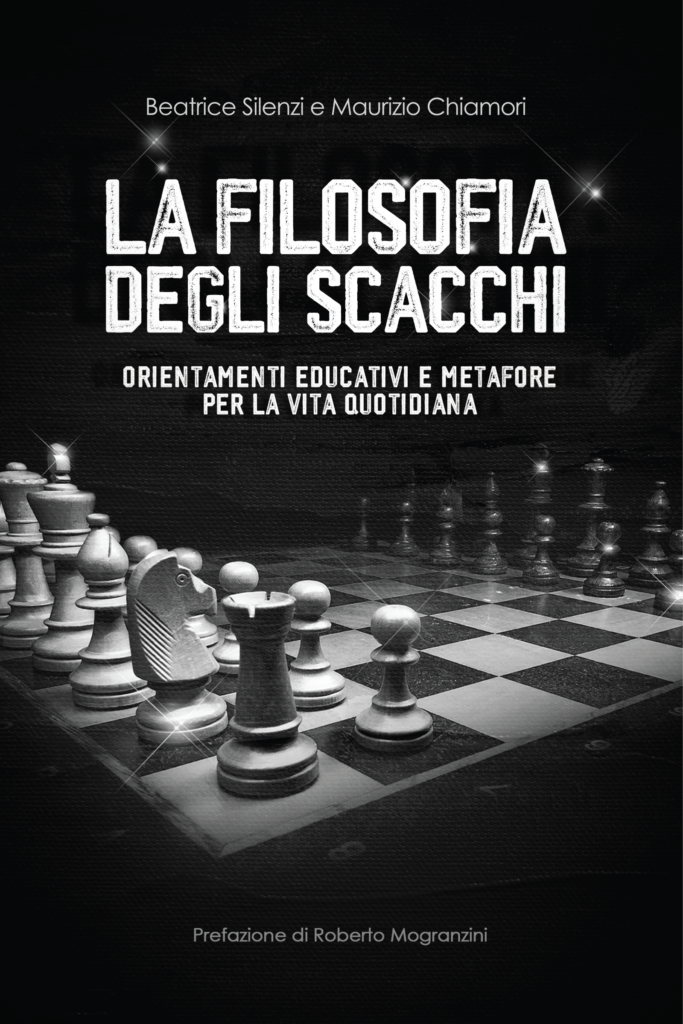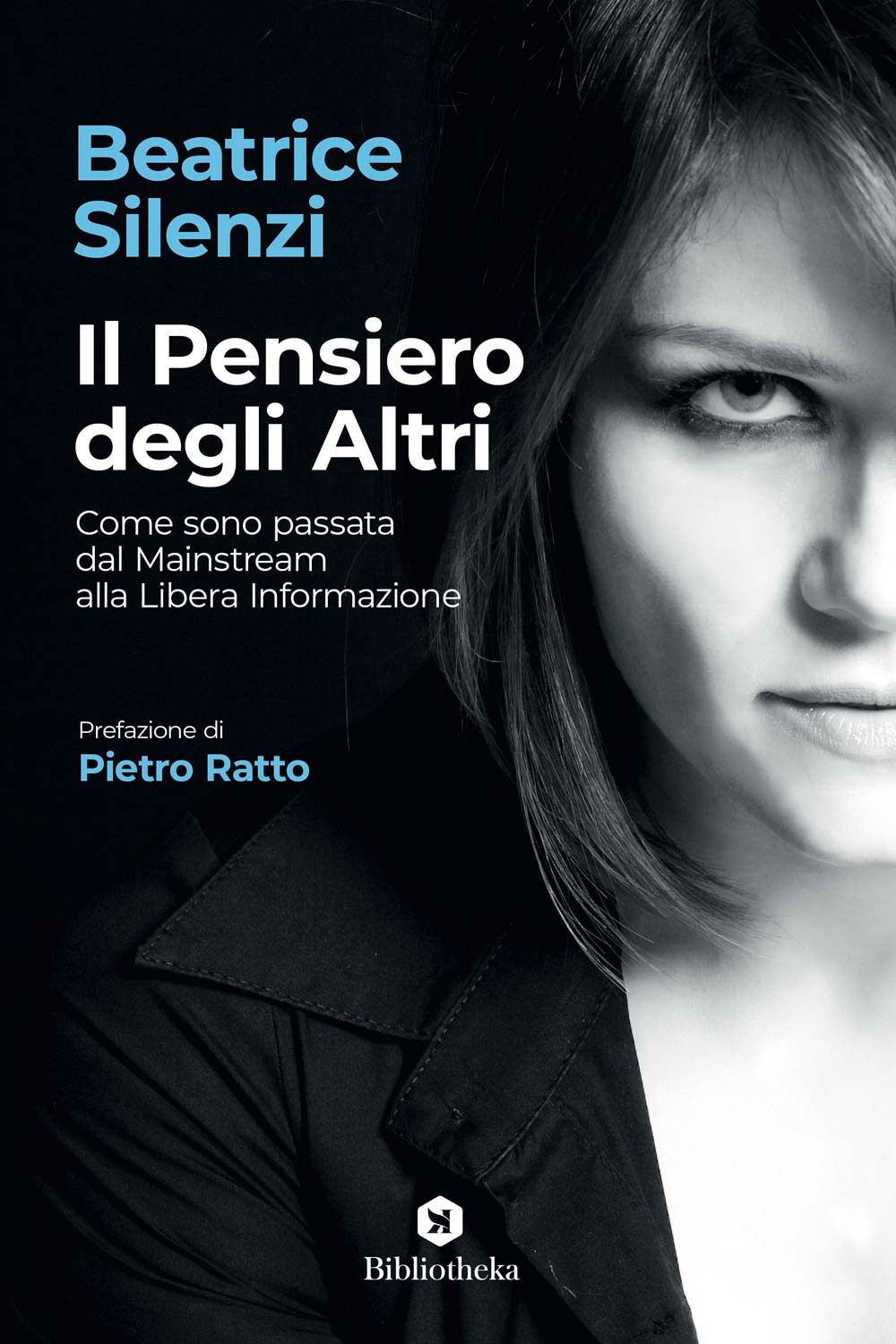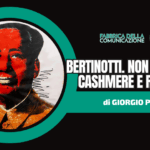Clicca per guardare il video
Su Fabbrica della Comunicazione, Beatrice Silenzi – giornalista e direttore responsabile – si occupa della rubrica, “Comunicazione e Dipendenze”, in collaborazione con Studi & Salute Bolgan.
Ospite di questo appuntamento è la dott. Cristina Ombra, psicoterapeuta.
“Una cosa è il conflitto, un’altra la violenza”. Con queste parole, la psicoterapeuta Cristina Ombra, ospite di un recente dibattito, ha acceso i riflettori su una realtà tanto diffusa quanto subdola: la violenza di genere.
Un fenomeno che, nonostante i progressi sociali e la rivoluzione sessuale degli anni ’60, continua a permeare la nostra società, spesso mascherato da dinamiche di coppia apparentemente normali.
È fondamentale distinguere tra conflitto e violenza all’interno di una relazione. Il primo è una componente inevitabile e, per certi versi, sana della vita di coppia. Nasce da divergenze di opinioni, bisogni o desideri e, se gestito in modo costruttivo, può portare a una maggiore comprensione reciproca e a una crescita della relazione. La violenza, al contrario, non è mai costruttiva. Si tratta di un abuso di potere, un tentativo di controllare e dominare l’altro attraverso la paura e l’intimidazione.
Quella di genere si manifesta in molteplici forme, non solo fisiche. Esiste una violenza psicologica, fatta di umiliazioni, insulti, minacce e isolamento. C’è la violenza economica, che si attua privando la partner dell’indipendenza finanziaria. E c’è la quella sessuale, che non si limita allo stupro, ma include qualsiasi atto sessuale imposto o non desiderato. Spesso queste forme si intrecciano, creando una spirale da cui è difficile uscire.
Non si tratta di fenomeni isolati, ma di stereotipi e pregiudizi. Uno degli aspetti più insidiosi di questa cultura è lo “slut-shaming”, un termine anglosassone che indica l’atto di criticare e far vergognare una donna per il suo comportamento sessuale, reale o presunto.
Si tratta di una forma di controllo sociale che mira a colpevolizzare la vittima, spostando l’attenzione dall’aggressore alla persona che ha subito la violenza.
Questo meccanismo di colpevolizzazione è un pilastro della “cultura dello stupro” (rape culture), un concetto emerso negli anni ’70 per descrivere un ambiente sociale in cui la violenza sessuale è normalizzata e giustificata. Si tende a minimizzare la gravità della violenza, a dubitare della parola delle vittime e a trovare scuse per gli aggressori. Frasi come “se l’è cercata” o “vestiva in modo provocante” sono esempi emblematici di questo modo di pensare.
Un esempio tristemente noto è il caso del magnate americano Jeffrey Epstein, accusato di abusi sessuali su decine di ragazze minorenni. Per anni, Epstein ha potuto agire indisturbato, protetto da una rete di potenti e da un sistema che ha a lungo ignorato le accuse delle sue vittime.
La documentarista Margaret Lazarus, già nel 1975, con il suo film “Rape Culture”, denunciava questa mentalità, mettendo in luce come la società stessa contribuisse a creare un ambiente favorevole alla violenza sessuale. Il suo lavoro, premiato e riconosciuto, ha aperto un dibattito che è ancora oggi di stretta attualità.
Una delle conseguenze più devastanti della violenza di genere è il profondo senso di vergogna e di colpa che attanaglia le vittime. La paura di essere giudicate, di non essere credute o, peggio, di essere ritenute responsabili della violenza subita, le spinge a chiudersi nel silenzio. Questo isolamento non fa che rafforzare il potere dell’aggressore e rende ancora più difficile chiedere aiuto.
La psicoterapeuta Cristina Ombra evidenzia come spesso le vittime abbiano vissuto situazioni di abuso già in famiglia, sviluppando una sorta di “assuefazione” alla violenza che rende difficile riconoscerla come tale. Si crea una confusione tra conflitto e violenza, tra amore e possesso, che intrappola la persona in una relazione tossica: rompere questo schema richiede un grande sforzo e, soprattutto, il supporto di una rete di professionisti in grado di offrire un aiuto psicologico e legale.
Con l’avvento di internet e dei social media, la violenza di genere ha assunto nuove e insidiose forme. Il “revenge porn”, la condivisione non consensuale di immagini o video intimi a scopo di vendetta, è un fenomeno in crescita che ha conseguenze devastanti sulla vita delle vittime.
La diffusione di questo materiale online crea una gogna mediatica permanente, che può portare a gravi problemi psicologici, all’isolamento sociale e, nei casi più estremi, al suicidio.
Il revenge porn è spesso legato al “sexting”, lo scambio di messaggi, foto o video a sfondo sessuale. Sebbene questo possa essere un gioco consensuale tra adulti, può anche diventare un’arma di ricatto e di violenza: la fiducia tradita e la violazione della propria intimità lasciano ferite profonde, difficili da sanare.
Come possiamo contrastare un fenomeno così complesso e radicato?
La risposta, secondo molti esperti, risiede nell’educazione e nella promozione di una cultura basata sull’empatia e sul rispetto.
È fondamentale insegnare ai giovani, fin dalla più tenera età, a riconoscere e a rispettare le emozioni proprie e altrui. L’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, è l’antidoto più efficace contro la disumanizzazione che sta alla base di ogni forma di violenza.
È necessario, inoltre, decostruire gli stereotipi di genere attraverso un impegno quotidiano che richiede coraggio, consapevolezza e, soprattutto, la volontà di non girarsi dall’altra parte.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.