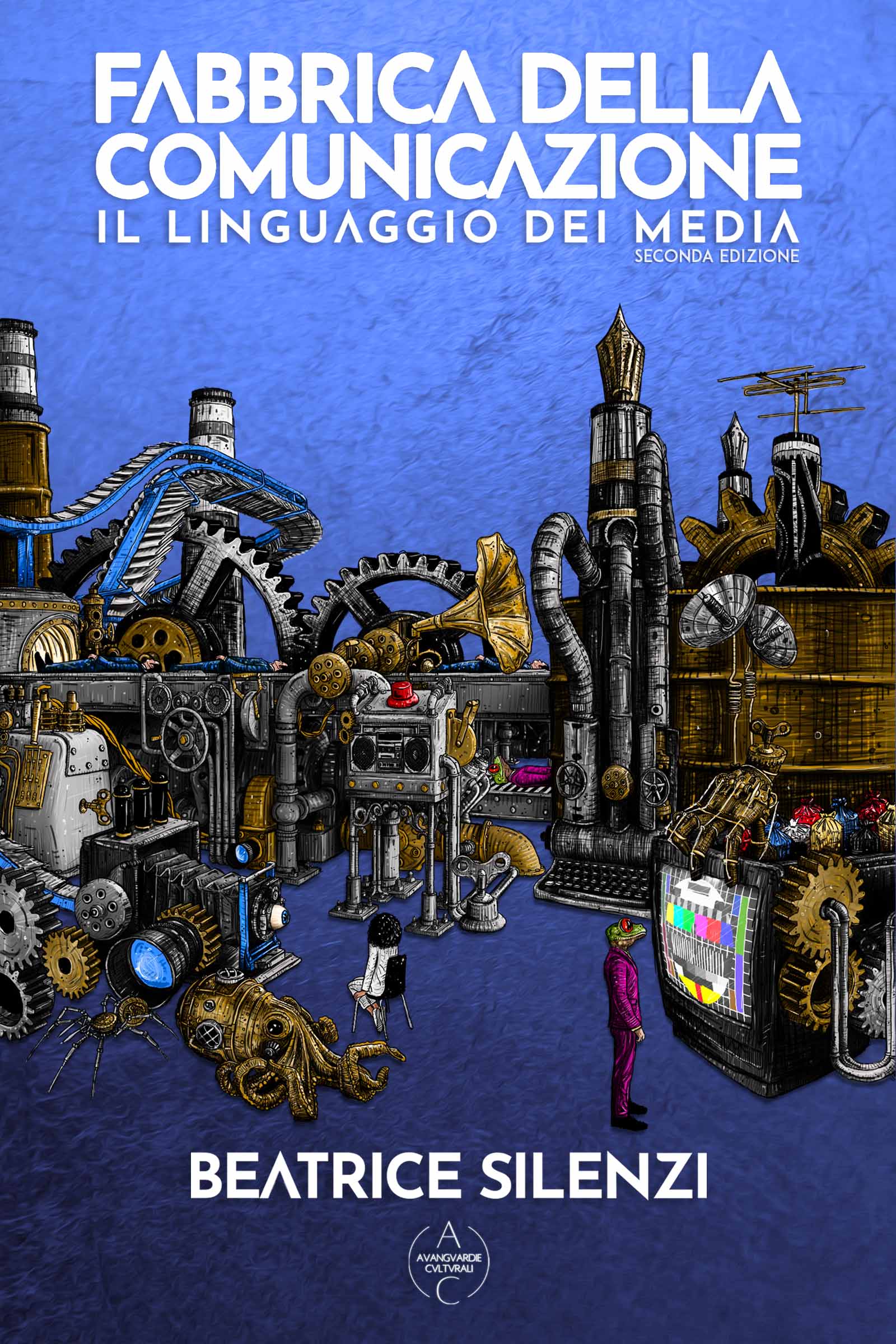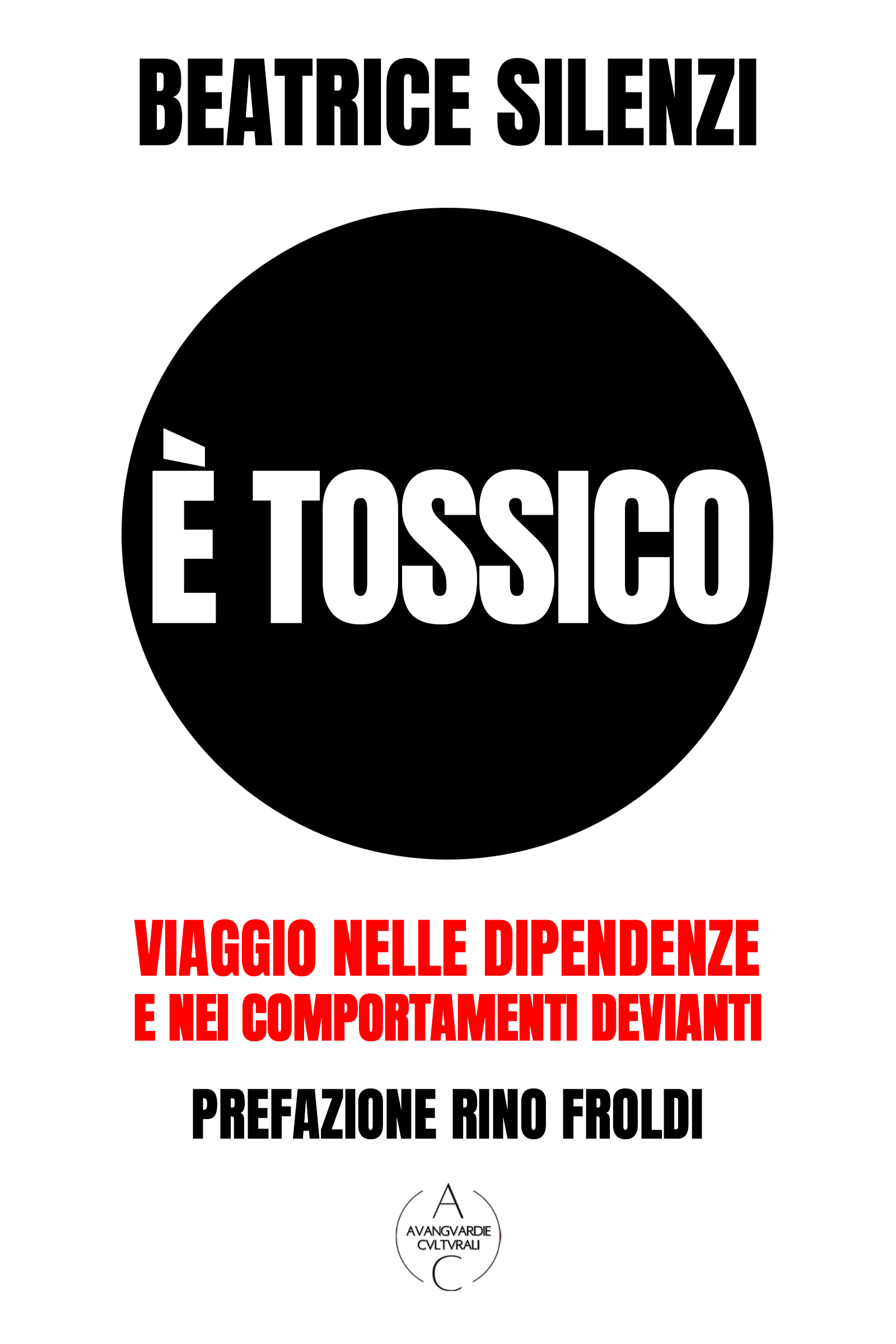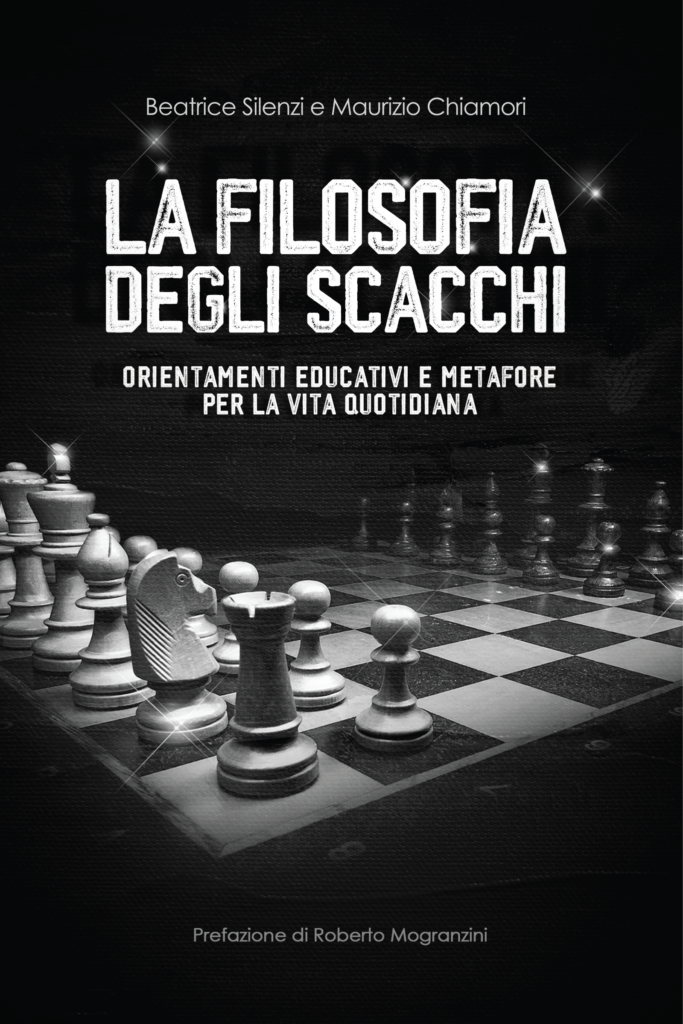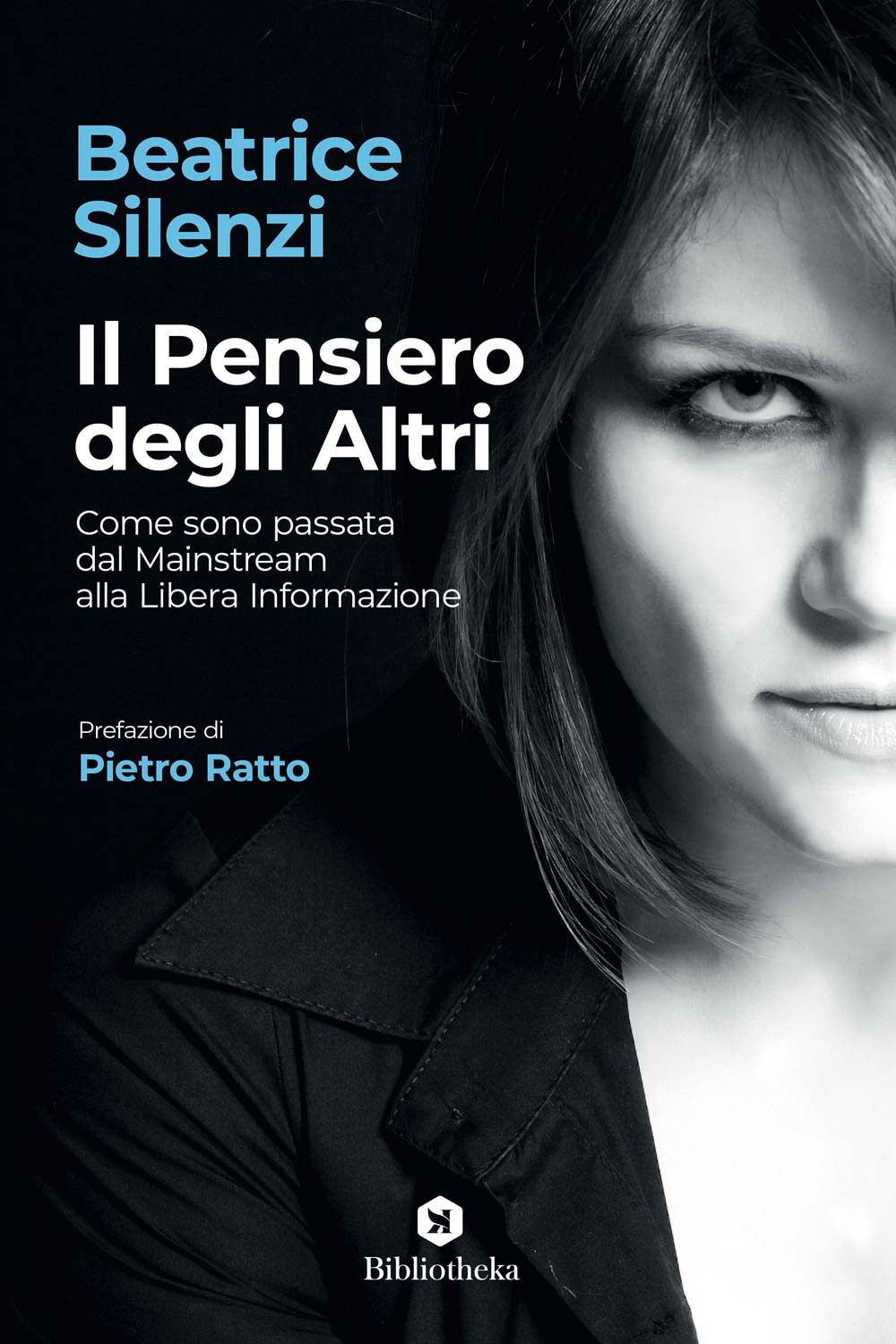Clicca per guardare il video
Su Fabbrica della Comunicazione la rubrica Dimensione Arte è cura del giornalista e critico musicale Giorgio Pandini.
Segui tutti gli appuntamenti di Dimensione arte sul nostro sito.
Pochi nomi negli annali della storia dell’arte evocano un tale miscuglio di splendore artistico, turbolenza esistenziale e persistente mistero come quello di Michelangelo Merisi, universalmente noto come Caravaggio.
Artista rivoluzionario, uomo tormentato, la sua parabola di vita, fugace quanto la luce che imprigionava sulle sue tele, continua a gettare lunghe ombre di interrogativi, in particolare riguardo alle sue opere disperse e agli enigmatici giorni finali.
Nato a Milano nel 1571, e cresciuto nel borgo di Caravaggio in provincia di Bergamo, il giovane Merisi giunse a Roma sul finire del XVI secolo, un crocevia di ambizioni e mecenatismo. Inizialmente, la sua arte faticò a trovare un pubblico, e i primi anni furono un susseguirsi di stenti e lavori occasionali.
La sua capacità di infondere realismo ai soggetti sacri, trasformando santi e madonne in figure umane, riconoscibili nelle loro imperfezioni e nella loro spiritualità tangibile, fu un elemento dirompente.
Il suo impiego del tenebrismo, dove forme emergono da un’oscurità quasi totale illuminate da un fascio di luce direzionale, non era un mero artificio stilistico, ma un veicolo per esprimere la drammaticità degli eventi e la rivelazione divina.
I personaggi, tratti dalla strada, con i loro volti segnati e i loro gesti quotidiani, portarono il sacro a un livello di prossimità mai visto prima, suscitando tanto ammirazione quanto scandalo.
Eppure, parallelamente alla sua ascesa artistica, la vita di Caravaggio precipitava in un gorgo di risse, duelli e frequentazioni equivoche. La sua indole irascibile e la sua tendenza a risolvere le dispute con la spada lo portarono a scontrarsi ripetutamente con la legge. Nel 1606, un duello con Ranuccio Tomassoni per una questione di gioco, o forse per un debito d’onore, culminò nell’uccisione di quest’ultimo.
La vita di Caravaggio si trasforma in una fuga disperata.
Una condanna a morte emessa dal Papa Paolo V lo costrinse ad abbandonare Roma, iniziando un peregrinare senza tregua che lo condusse a Napoli, Malta e infine in Sicilia.
Ogni tappa di questo esilio forzato fu segnata da una produzione artistica febbrile e intensissima.
A Napoli, la sua influenza fu immediata e profonda, dando vita a una scuola caravaggesca vibrante e duratura. A Malta, sotto la protezione dei Cavalieri di San Giovanni, dipinse capolavori come la Decollazione di San Giovanni Battista un’opera di dimensioni monumentali e di una potenza emotiva sconvolgente, in cui la luce sferza la scena con una violenza quasi tangibile. Ma anche qui, il suo temperamento gli giocò un brutto scherzo: un’altra rissa lo portò alla prigione e poi alla fuga, privato del suo rango di Cavaliere.
La Sicilia fu l’ultima tappa di questo tormentato viaggio. Siracusa, Messina, Palermo: qui realizzò opere di struggente bellezza, come il Seppellimento di Santa Lucia la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei Pastori. In questi dipinti, la tavolozza si fece più scura, le figure più esili, e l’atmosfera intrisa di un senso di
malinconia e disperazione, quasi un presagio della fine imminente.
Nel 1610, grazie all’intervento di potenti protettori, tra cui il cardinale Scipione Borghese, si profilava la possibilità di un perdono papale. Caravaggio si imbarcò su una feluca diretta a Porto Ercole, in Toscana, portando con sé un piccolo carico di opere d’arte, destinate forse come doni per i suoi benefattori o come merce di scambio per assicurarsi il ritorno a Roma.
Tra queste opere si presume vi fossero tre tele cruciali: la Maddalena in estasi, conosciuta attraverso copie e descrizioni d’epoca, era probabilmente un’opera di grande impatto emotivo, che esplorava il tema del pentimento e della redenzione con la consueta profondità caravaggesca.
Ma la feluca non giunse mai a destinazione con il suo prezioso carico intatto. Caravaggio, sbarcato a Porto Ercole, morì pochi giorni dopo, il 18 luglio 1610, in circostanze ancora oggi non del tutto chiare.
La versione ufficiale parlò di febbre, forse malaria, ma teorie alternative suggeriscono un avvelenamento o le conseguenze delle sue ferite pregresse.
Il suo corpo fu sepolto in una fossa comune, la sua tomba rimasta sconosciuta per secoli, alimentando ulteriormente il velo di segretezza intorno alla sua fine, un oblio che lo accomuna purtroppo a tanti altri geni che hanno costellato la storia dell’umanità.
E le opere scomparse non sono semplici pezzi mancanti di un puzzle, ma frammenti di un’anima artistica in costante evoluzione.
L’ultimo stadio della sua ricerca stilistica, la sintesi di una vita vissuta al limite, un testamento artistico che avrebbe potuto rivelare nuove sfaccettature del suo genio. La loro perdita aggiunge un ulteriore strato di malinconia alla sua già tragica esistenza, lasciando un vuoto nella narrazione della sua produzione.
Caravaggio non è solo un pittore, ma un archetipo dell’artista ribelle, del genio incompreso, della figura che brucia la propria esistenza sull’altare della propria arte. I suoi quadri, anche quelli sopravvissuti, sono intrinsecamente legati alla sua biografia, e ogni pennellata sembra portare il peso delle sue esperienze, delle sue passioni e delle sue sofferenze.
Approfondimento dell’appuntamento precedente: Pomodoro
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.