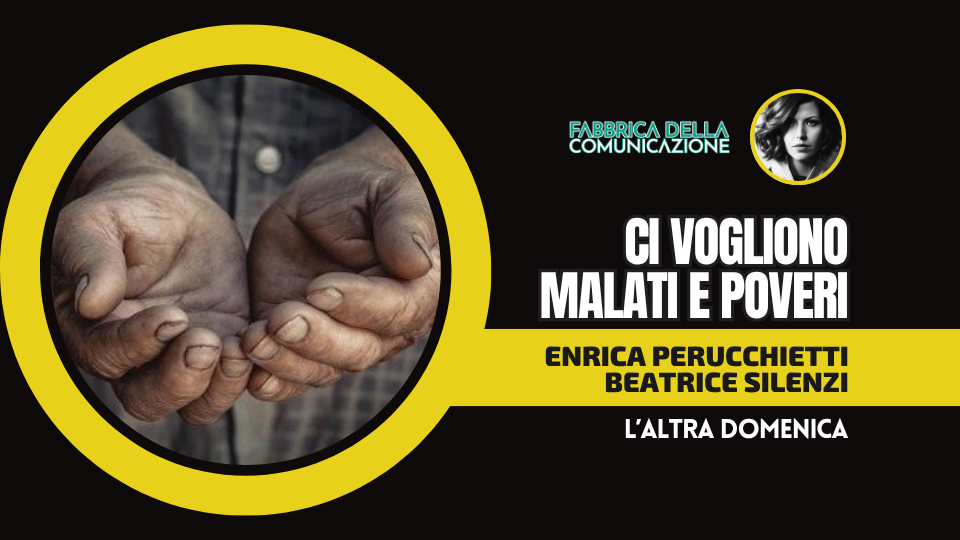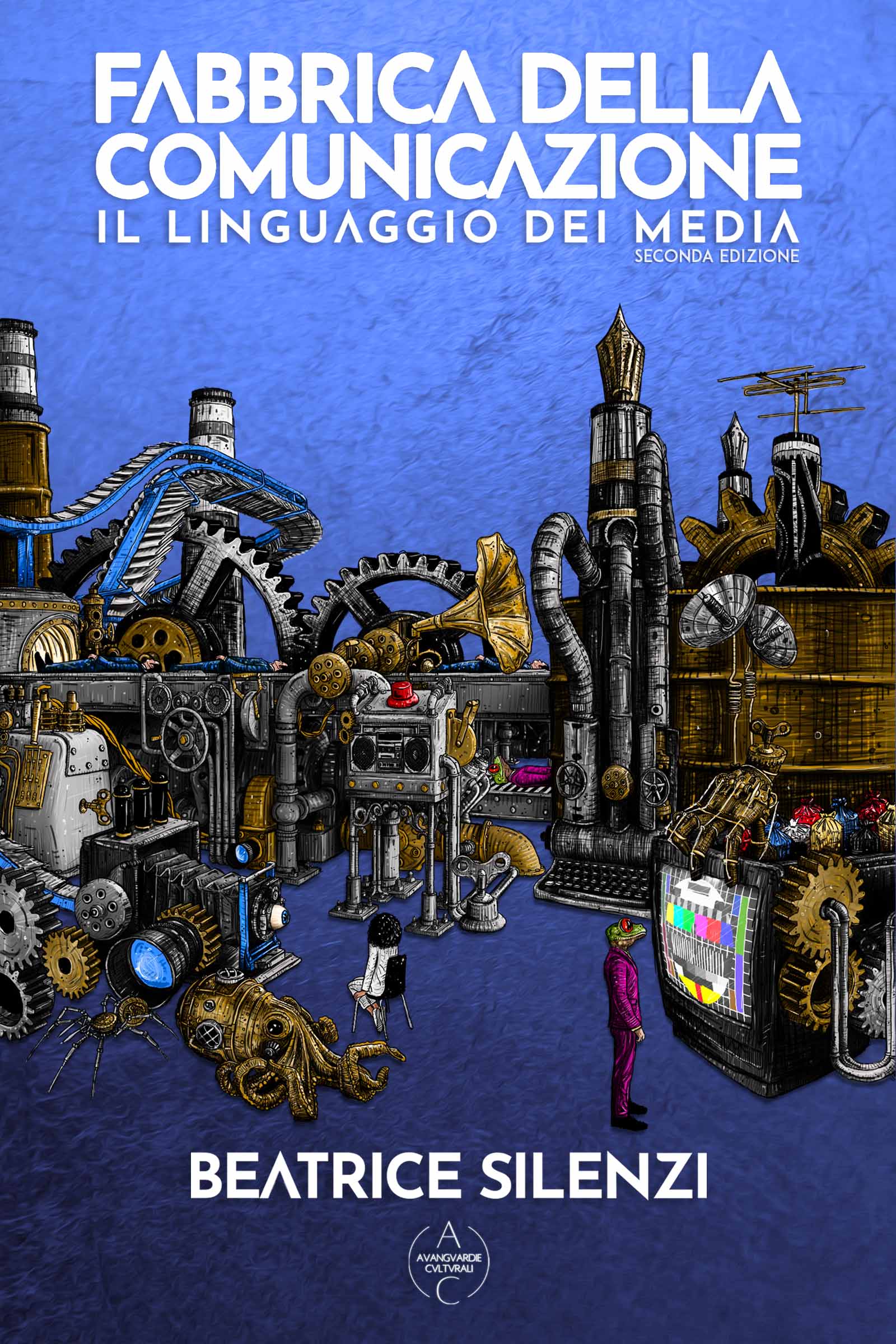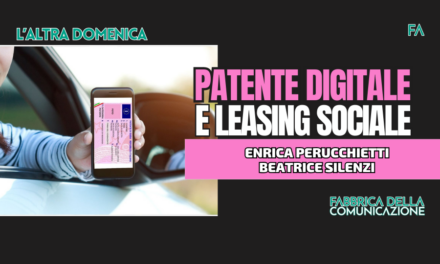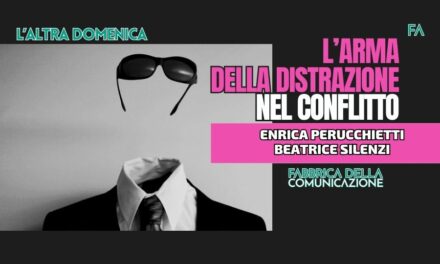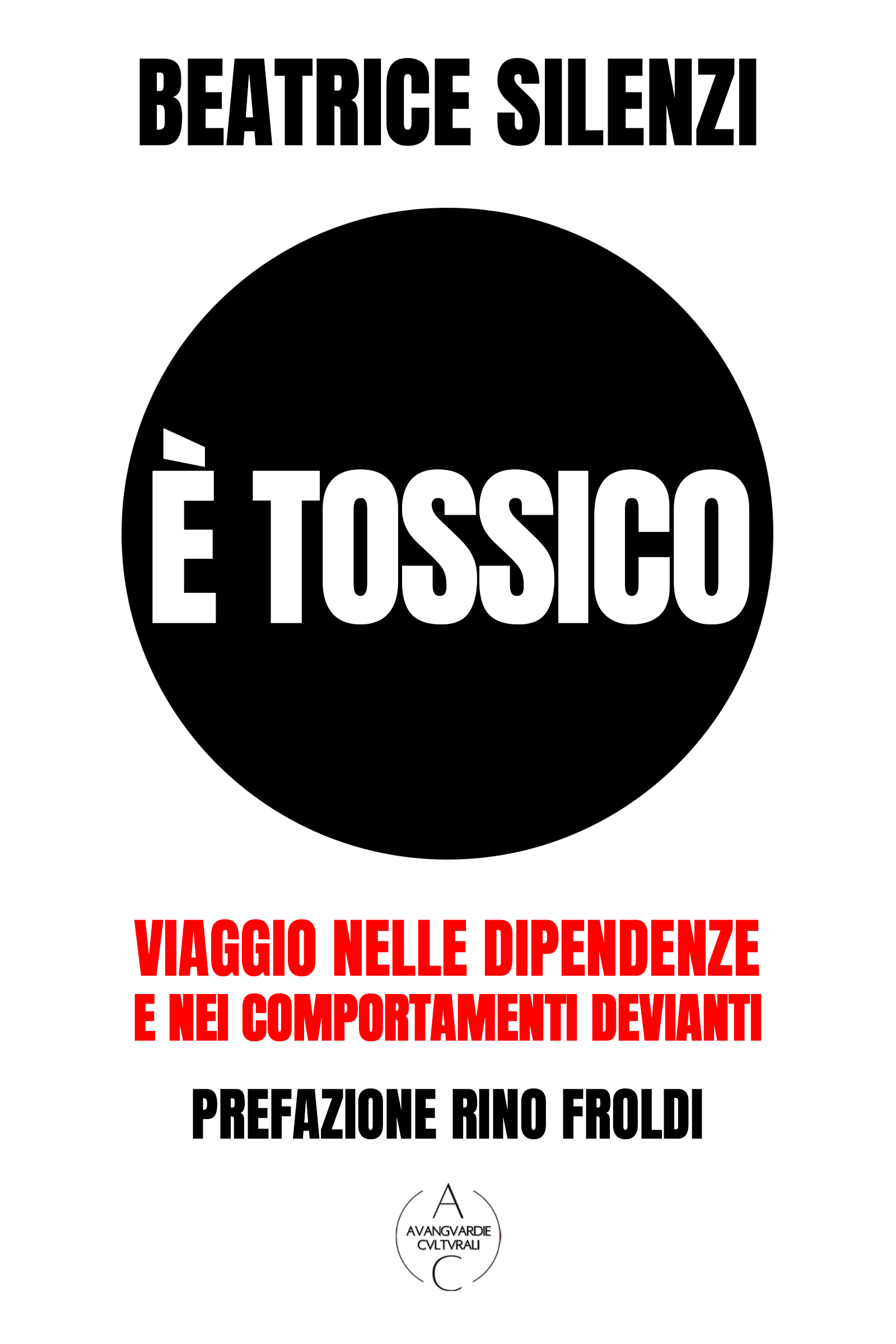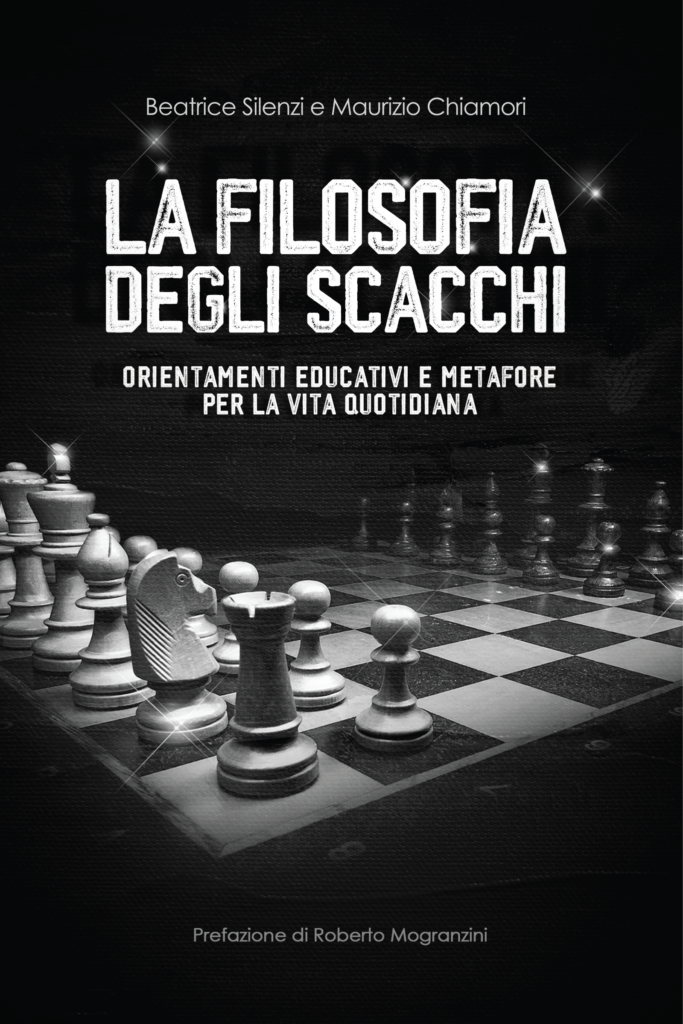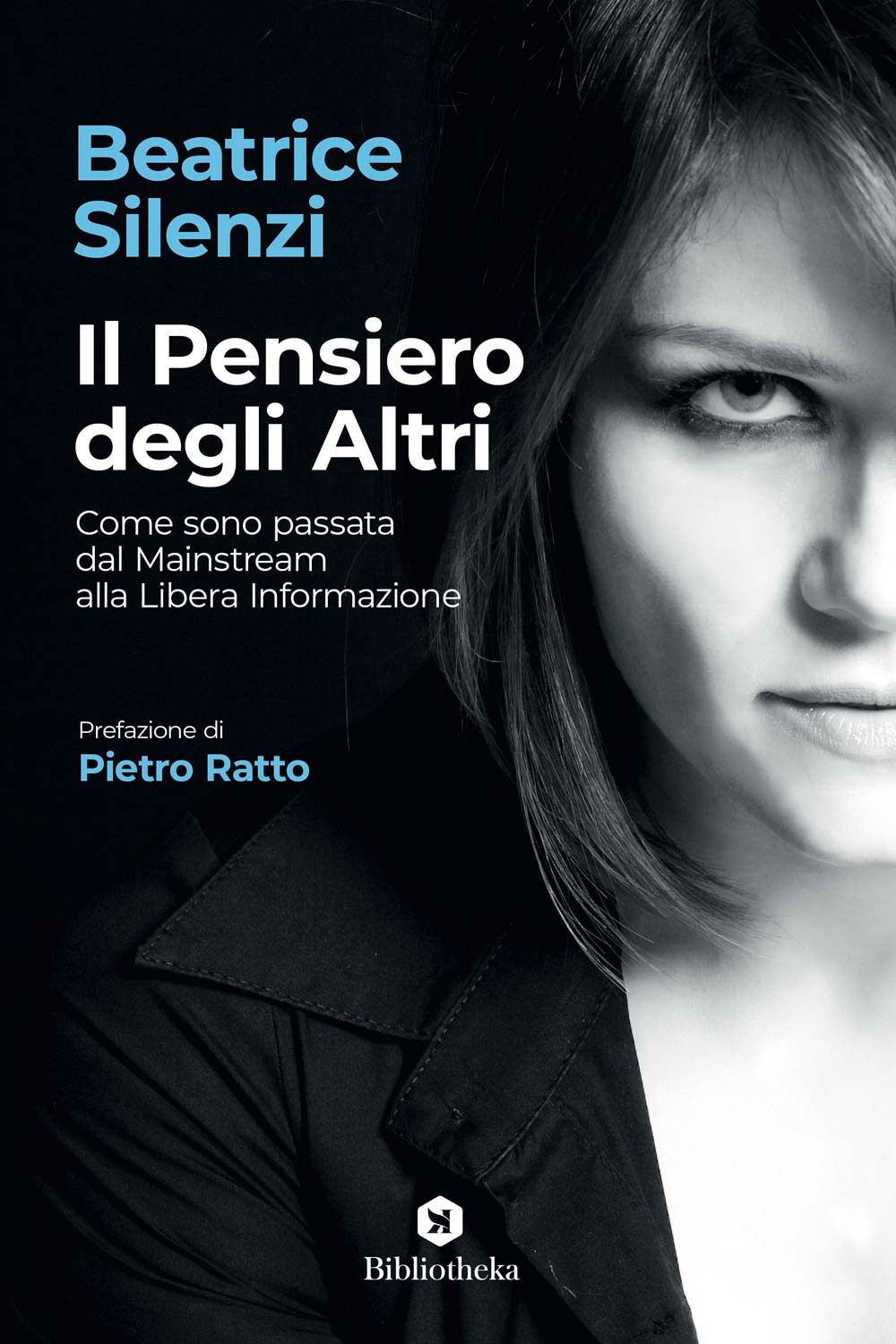Clicca per guardare il video
La rubrica L’Altra Domenica è a cura dello scrittrice e giornalista Enrica Perucchietti e Beatrice Silenzi, direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
15 ottobre 2021, giorno dell’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Un giorno che Perucchietti definisce senza esitazioni “il giorno dell’infamia”, simbolo di una frattura sociale, politica e morale che ha diviso il Paese come raramente era accaduto nel dopoguerra.
Un “apartheid” sociale e un esperimento di disciplinamento
“Non lo considero un giorno qualunque – spiega Perucchietti – ma una pagina drammatica della nostra storia recente, in cui lo Stato democratico ha imposto un sistema discriminatorio, separando chi aveva diritto di lavorare e di partecipare alla vita sociale da chi ne era escluso.”
Il Green Pass ha rappresentato un esperimento sociale su larga scala, una forma di condizionamento e di controllo collettivo mascherato da misura sanitaria. “È stato uno strumento di ricatto – aggiunge – con cui si è chiesto alle persone di scegliere tra la libertà e la sopravvivenza economica. Chi non accettava il lasciapassare veniva privato non solo del lavoro, ma della propria dignità.”
Un “apartheid liberticida”, lo definisce, che ha eroso la fiducia nelle istituzioni e creato un precedente pericoloso, destinato a influenzare le future politiche di sorveglianza.
“Il Green Pass – continua – ha aperto la strada a una serie di tentativi di limitare le libertà individuali, come il progetto di chat control o altre forme di monitoraggio digitale che, pur se temporaneamente bloccate, rischiano di riaffacciarsi sotto altre vesti.”
Il silenzio sulle vittime e le prime sentenze
Un altro tema affrontato è quello degli effetti avversi post-vaccinali, spesso – sostiene Perucchietti – “negati, minimizzati o derisi”. La giornalista ricorda che negli ultimi mesi alcune sentenze hanno riconosciuto un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e gravi conseguenze sanitarie.
Tra queste, la decisione del Tribunale di Asti del 26 settembre, che ha riconosciuto un indennizzo (non un risarcimento) a una donna rimasta invalida dopo due dosi. “È una piccola vittoria – osserva – ma non basta.
Troppe persone sono state lasciate sole, abbandonate, e spesso ridicolizzate perfino da rappresentanti istituzionali. Hanno dovuto affrontare una battaglia legale e morale estenuante per vedersi riconosciuto un minimo di giustizia.”
Perucchietti sottolinea come attorno a questi casi si sia creato “un muro di gomma” che impedisce di discutere apertamente delle conseguenze delle scelte politiche e sanitarie adottate durante la pandemia.
“Non è negazionismo, è semplice ricerca della verità e richiesta di responsabilità – afferma –. È assurdo che chi pone domande venga ancora oggi etichettato come complottista.”
Il dialogo si sposta poi sul piano economico. L’analisi è dura: “Dal 2020 in poi – afferma la giornalista – si è consumato un attacco sistematico e graduale alla classe media, che era la spina dorsale della società.
Prima la pandemia, poi la guerra e le sanzioni alla Russia hanno fatto impennare i costi dell’energia, erodendo il potere d’acquisto delle famiglie e portando milioni di italiani in difficoltà.”
I numeri, ricorda, parlano chiaro: secondo gli ultimi dati Istat, il 10% della popolazione – circa 5,6 milioni di persone – vive in condizioni di povertà assoluta. “Una cifra spaventosa – commenta – che fotografa la dissoluzione della piccola e media borghesia.
È un livellamento verso il basso, un impoverimento progressivo che non è frutto del caso ma di precise scelte politiche ed economiche.”
Il costo della vita cresce, le bollette aumentano, e persino i beni più comuni diventano inaccessibili: “Con uno stipendio medio, anche acquistare una maglietta o un paio di pantaloni a ottanta euro pesa sul bilancio familiare. È un segnale evidente di quanto la crisi abbia colpito la quotidianità delle persone.”
A questo si aggiunge, secondo Perucchietti, un paradosso politico: mentre si tagliano fondi a welfare, sanità e pensioni, “si trovano risorse ingenti per il riarmo”. “È come se la guerra fosse diventata l’unica economia possibile, mentre i cittadini devono accettare nuovi sacrifici in silenzio.”
Perucchietti porta poi un esempio emblematico: la Francia. “Macron – spiega – pur di mantenere il potere, è stato costretto a congelare la riforma delle pensioni che lui stesso aveva imposto nel 2023, provocando proteste imponenti. In Francia la gente scende in piazza, in Italia invece tutto scivola via nell’indifferenza.”
La mancanza di reazione sia diventata un tratto distintivo del nostro Paese: “Non abbiamo reagito né contro il Green Pass, né contro le riforme che hanno eroso i diritti sociali, né di fronte ai rincari.
Le piazze, che inizialmente si erano riempite, si sono progressivamente svuotate. Sembra che ci sia una stanchezza collettiva, un senso di impotenza che fa comodo a chi governa.”
La Francia, nonostante le sue difficoltà, “rimane il Paese europeo con l’età pensionabile più bassa”. L’Italia, invece, “continua a subire in silenzio riforme penalizzanti e tagli sistematici senza una reale opposizione sociale”.
Durante il periodo delle restrizioni, le manifestazioni contro il Green Pass non furono accolte con la stessa benevolenza riservata ad altre proteste. “Chi scendeva in piazza veniva criminalizzato, definito irresponsabile o complottista”, sottolinea la conduttrice.
Perucchietti concorda: “Oggi si legittimano alcune manifestazioni e se ne condannano altre, a seconda della convenienza politica o mediatica. È un segno di ipocrisia profonda. Ci sono battaglie che vanno di moda e altre che si preferisce cancellare dalla memoria collettiva.”
La giornalista lancia un appello alla responsabilità e alla coerenza: “Bisogna smettere di guardare solo al proprio orticello.
Serve più solidarietà, più consapevolezza del destino comune. I diritti e le libertà non si difendono da soli: se non li proteggiamo, ce li toglieranno ancora, un po’ alla volta.”
“Un incubo che abbiamo già sotto gli occhi”
Il bilancio di questi ultimi cinque anni, conclude Perucchietti, “è devastante”. “Abbiamo vissuto una pandemia, una guerra, una crisi economica, un impoverimento culturale e morale. Chi guarda indietro con lucidità si accorge che molti dei meccanismi introdotti allora – dal controllo digitale al condizionamento psicologico – non sono mai stati davvero smantellati.”
E il rischio, oggi, è l’assuefazione: “Ci siamo abituati alla perdita delle libertà. L’incubo non è più qualcosa che ci attende, ma qualcosa che abbiamo già sotto gli occhi.”
Ricordare il 15 ottobre è un monito. Un punto di non ritorno che impone di interrogarsi sul significato stesso di democrazia, libertà e responsabilità civile.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.