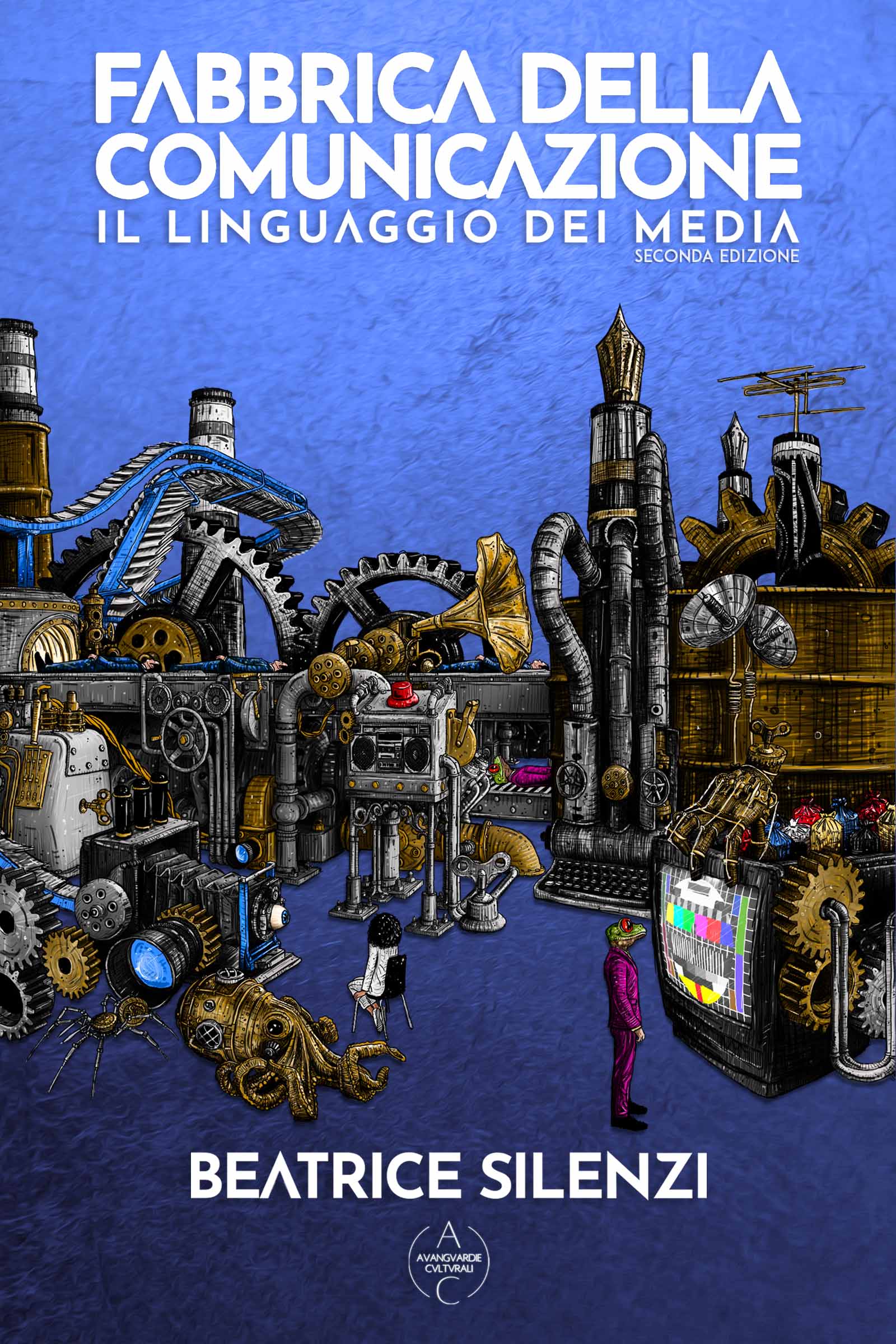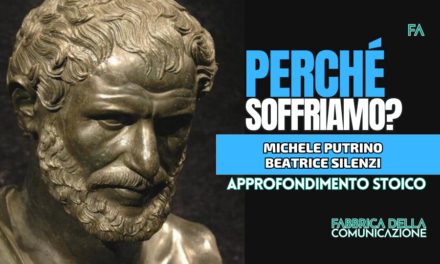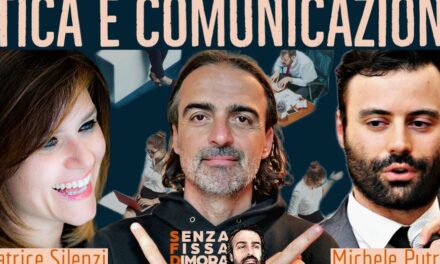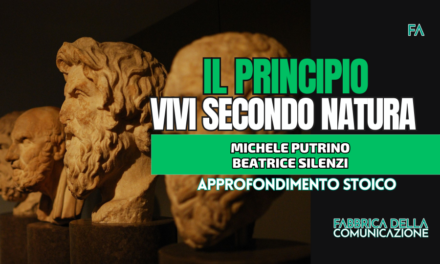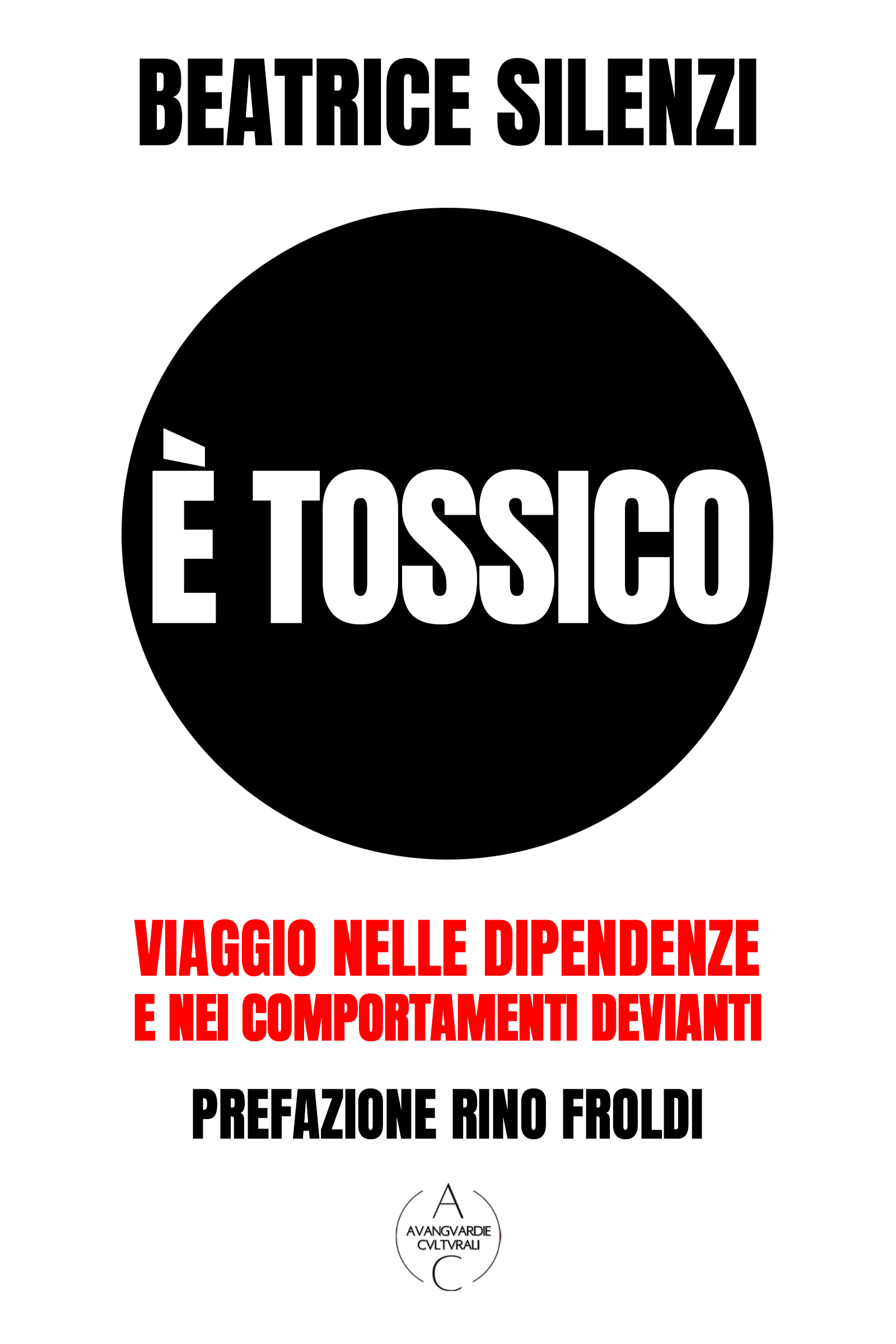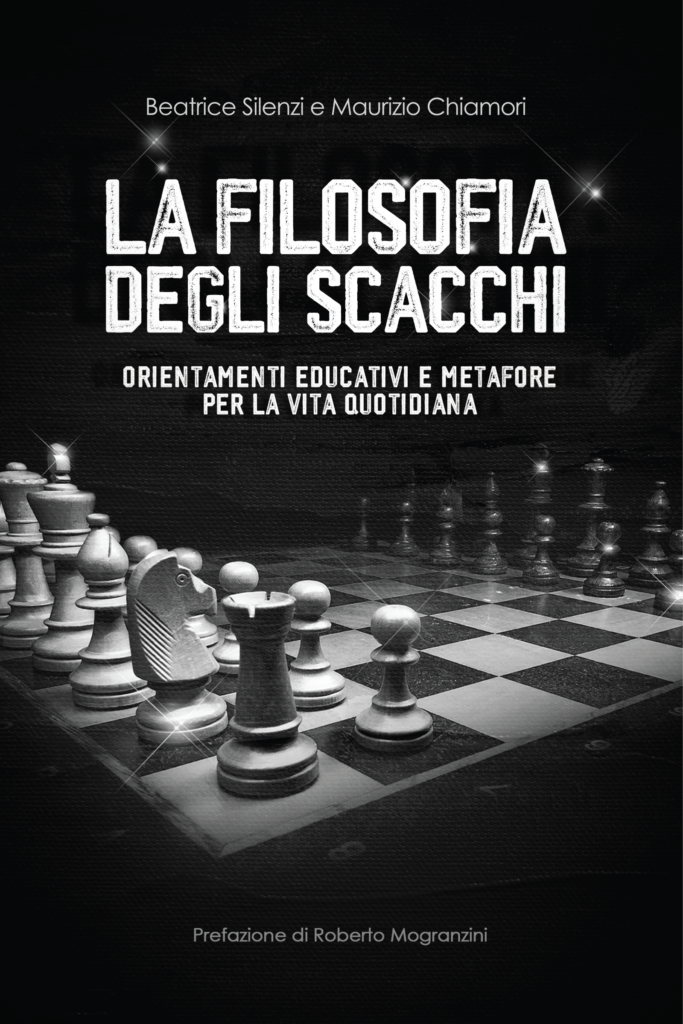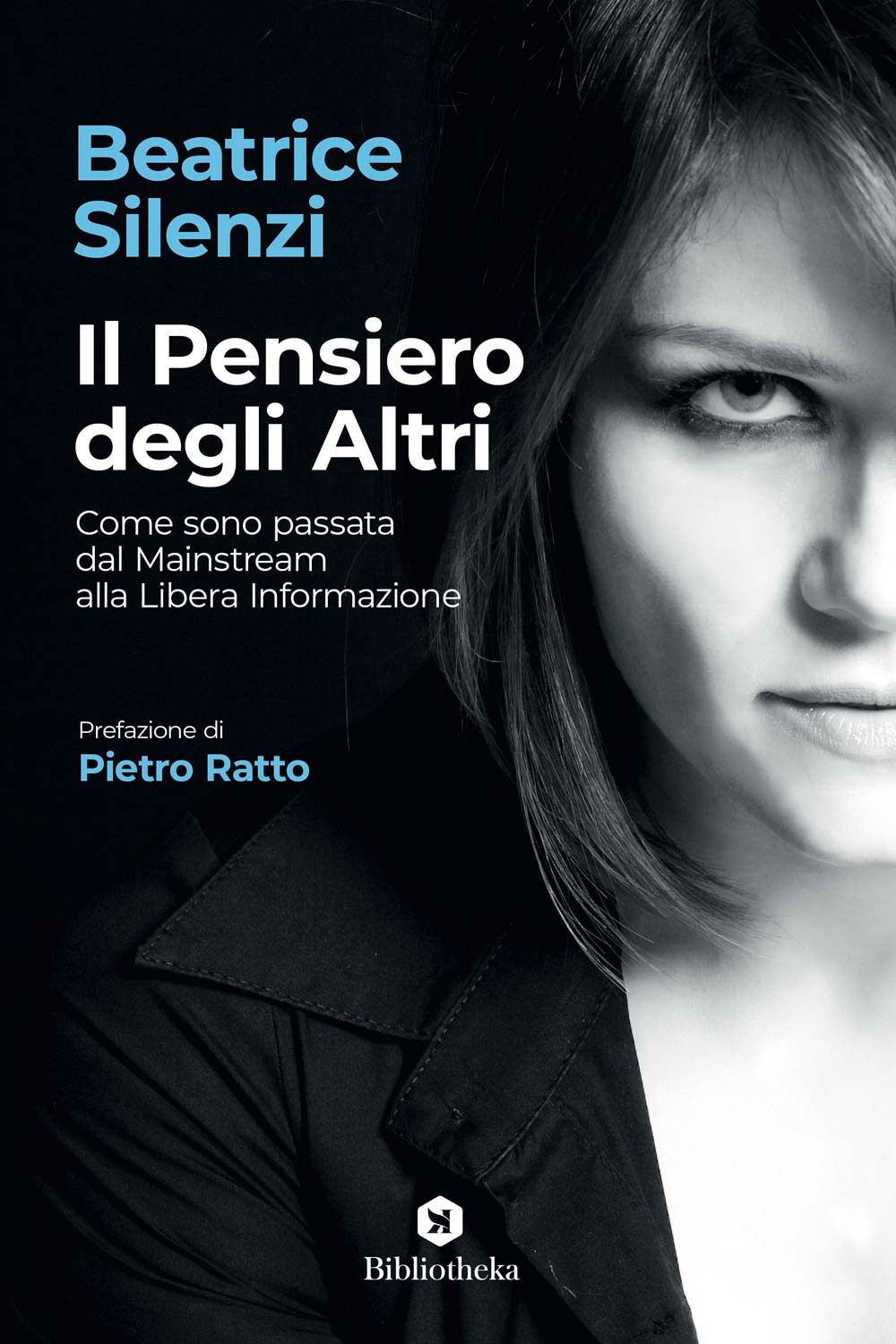Clicca per guardare il video
Su Fabbrica della Comunicazione, la rubrica Approfondimento Stoico è a cura dello scrittore ed antifilosofo Michele Putrino e Beatrice Silenzi, direttore responsabile.
Coraggio e dovere morale. Ogni 19 luglio, l’Italia si ferma, o dovrebbe fermarsi, a ricordare. È la data che segna uno squarcio indelebile nella coscienza della nazione: la strage di via D’Amelio. In quel pomeriggio del 1992, una bomba non uccise soltanto il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta — Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina — ma tentò di annientare un simbolo di integrità e coraggio.
A quasi due mesi di distanza dalla strage di Capaci, che aveva portato via l’amico e collega Giovanni Falcone, la sua famiglia e la scorta, la mafia completava la sua sanguinosa sentenza.
Eppure, anno dopo anno, la percezione di queste commemorazioni sembra cambiare. Quella che un tempo era una ferita viva, un monito potente che mobilitava piazze e coscienze, rischia oggi di trasformarsi in un rito stanco, un appuntamento istituzionale svuotato della sua carica più profonda.
La loro conversazione va ben oltre il semplice ricordo, per trasformarsi in un’analisi acuta e a tratti spietata della nostra società, del nostro rapporto con la memoria, il coraggio e, in definitiva, con il significato stesso di essere “Uomini”.
La domanda iniziale è semplice ma disarmante: perché si parla di queste ricorrenze con sempre meno enfasi?
Viviamo nell’era dell’anestesia digitale. Un tempo, la noia e i momenti vuoti potevano essere un fertile terreno per la riflessione e il pensiero.
Oggi, ogni istante di inattività viene immediatamente riempito dallo scorrere infinito dei social media. “La gente,” afferma Putrino con schiettezza, “è strarincoglionita dietro agli smartphone.”
Questa distrazione perenne ha un effetto devastante sulla capacità di approfondimento. Le grandi manifestazioni del passato, che un tempo portavano il concetto di giustizia nelle scuole e tra i giovani, oggi sembrano echi lontani. La legalità è diventata uno slogan, piuttosto che un principio vissuto.
Il secondo, e più profondo, motivo di questo affievolimento risiede, secondo Putrino, in un errore di prospettiva da parte delle istituzioni stesse. Per decenni, Falcone e Borsellino sono stati presentati principalmente come eroi della lotta alla mafia, icone della legalità.
Sebbene questo sia indiscutibilmente vero, questa narrazione ha finito per oscurare la loro qualità più essenziale e universale: la loro straordinaria tempra umana.
Falcone e Borsellino non erano grandi solo per il lavoro che facevano, ma per come lo facevano e, soprattutto, per chi erano. La loro vera lezione non è solo giuridica o sociale, ma esistenziale. Erano esempi di carattere, di integrità morale, di una coerenza incrollabile che li ha portati ad affrontare il loro destino con una lucidità quasi sovrumana.
Focalizzarsi unicamente sulla “legalità” ha permesso alla società di delegare il loro esempio, confinandolo all’ambito della magistratura e della lotta alla criminalità.
Ma la loro vera eredità, sostiene Putrino, è un invito a tutti, in ogni campo, a coltivare le stesse virtù: il coraggio, il senso del dovere, la capacità di tenere fede ai propri principi anche di fronte al rischio estremo. Ridurli a icone anti-mafia significa, paradossalmente, renderli meno rilevanti per la vita di tutti i giorni.
È nel loro rapporto con la morte che la statura di questi “Uomini” emerge in tutta la sua potenza. La conversazione analizza due frasi celebri che, spogliate da ogni retorica, rivelano una profonda saggezza di stampo stoico.
La prima è di Paolo Borsellino che, dopo la morte di Falcone, consapevole di essere il prossimo sulla lista, affermò: “Ricordiamo a noi stessi che siamo cadaveri che camminano.” È il memento mori degli antichi, la piena accettazione del proprio destino come conseguenza diretta delle proprie scelte. Borsellino sapeva che la sua coerenza gli sarebbe costata la vita, ma ha scelto di non arretrare, di vivere fino in fondo il suo dovere morale. La sua non era rassegnazione, ma una scelta attiva e razionale, la più alta forma di libertà e coraggio.
La seconda frase è di Giovanni Falcone: “Il vigliacco muore ogni giorno, il coraggioso muore una volta sola.” La paura è una morte continua. Chi vive nel terrore, chi scende a compromessi per codardia, uccide la propria anima e la propria dignità ogni giorno. Il coraggioso, invece, pur consapevole del rischio, vive pienamente la propria esistenza. La sua morte fisica è un evento unico e finale, ma non intacca la vita che ha vissuto con pienezza e integrità.
La modernità, secondo questa analisi, tende a “sdolcinare” queste figure, a manipolarne il ricordo per renderlo più appetibile e meno scomodo. Si prendono le loro frasi virili e taglienti e le si trasforma in aforismi da social network, accompagnati da gattini e cuoricini. Questo processo di edulcorazione è un tradimento del loro spirito.
Cosa resta, dunque, della memoria di Paolo Borsellino?
Il loro lascito non è un invito a diventare tutti magistrati, ma a diventare tutti “Uomini” e “Donne” con la maiuscola.
È un appello a riscoprire il valore della coerenza, della responsabilità e del coraggio nella nostra vita quotidiana.
È capire che il vero coraggio non è l’assenza di paura, ma la capacità di agire secondo i propri valori nonostante la paura.
In un’epoca di distrazioni effimere e principi liquidi, il ricordo di Paolo Borsellino dovrebbe essere un faro.
Non per celebrare una morte, ma per imparare a vivere. Per capire che, come disse Falcone, c’è un solo modo per non morire ogni giorno: scegliere il coraggio. E questa scelta, oggi come allora, spetta a ciascuno di noi.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.