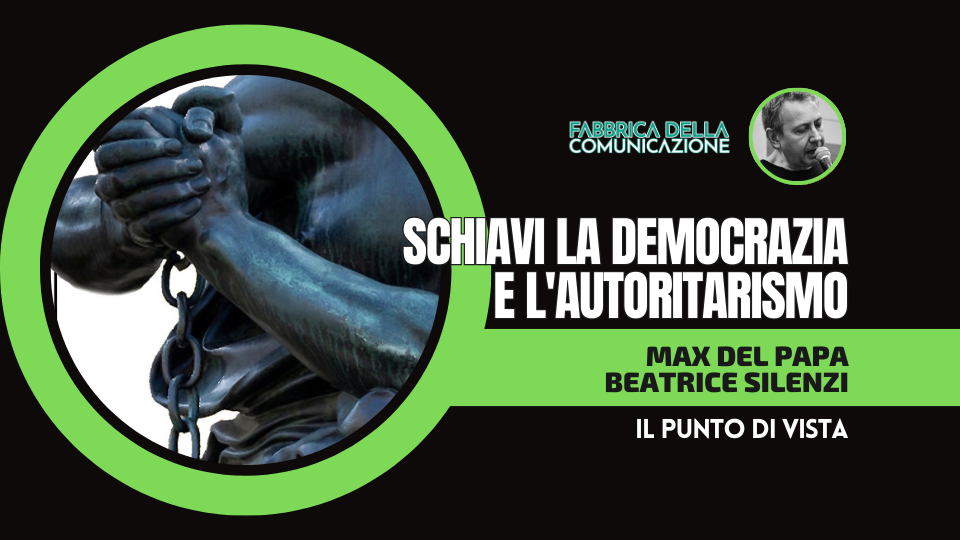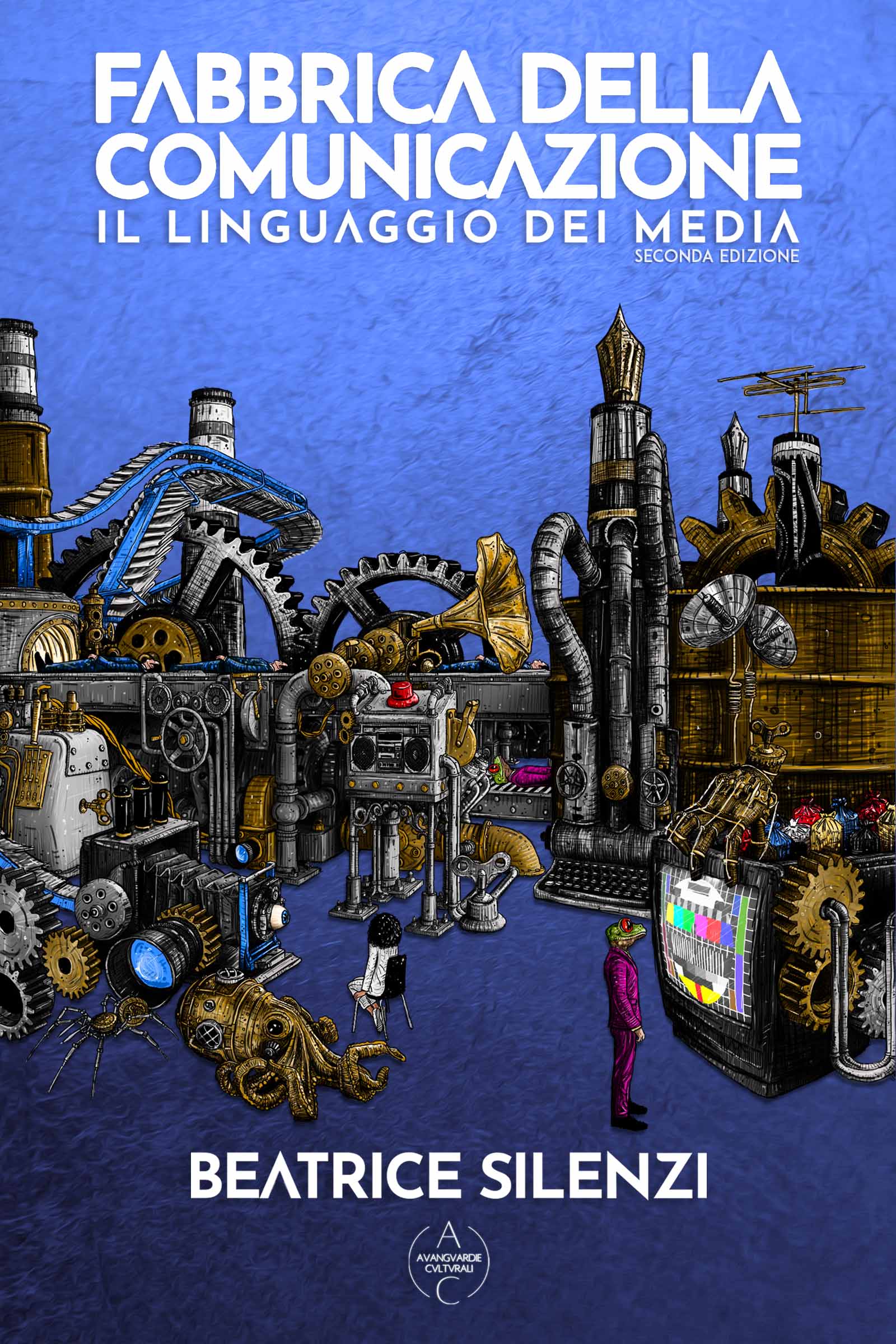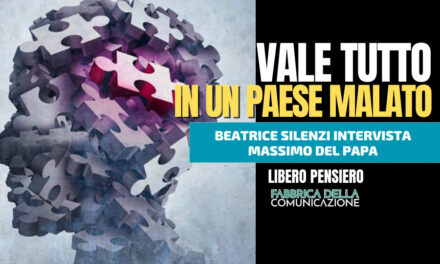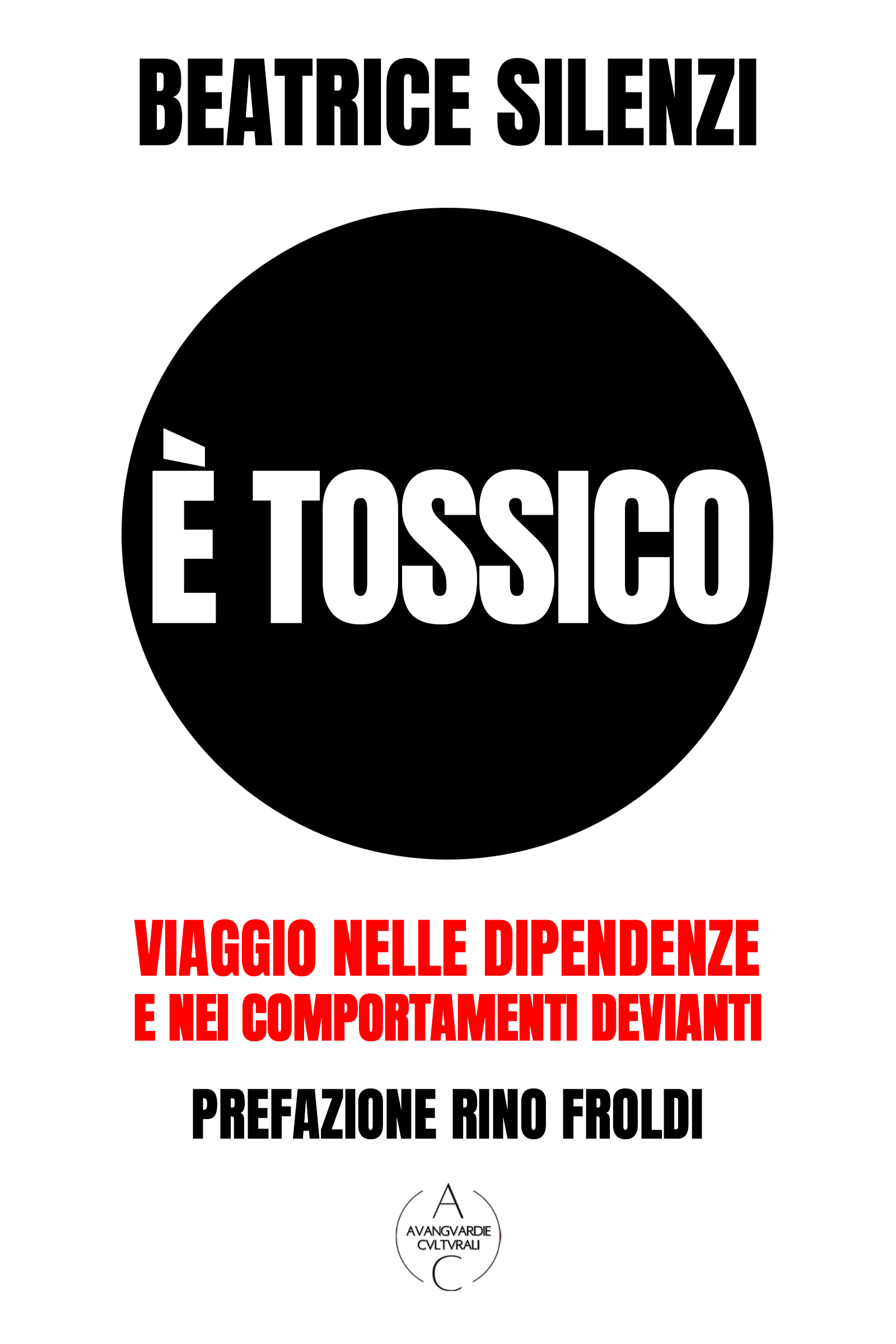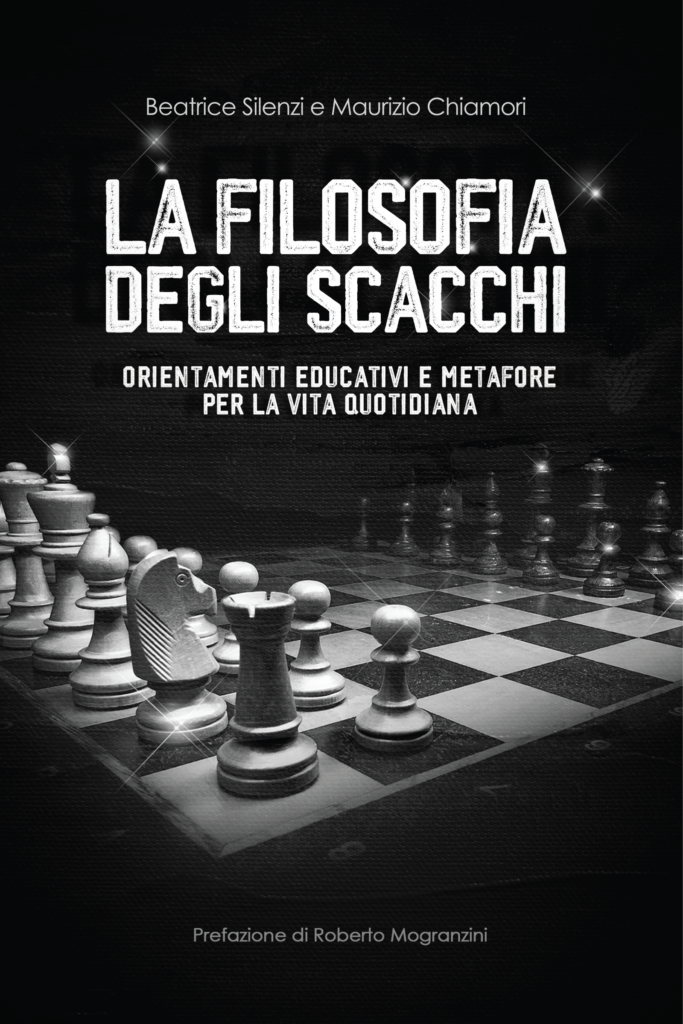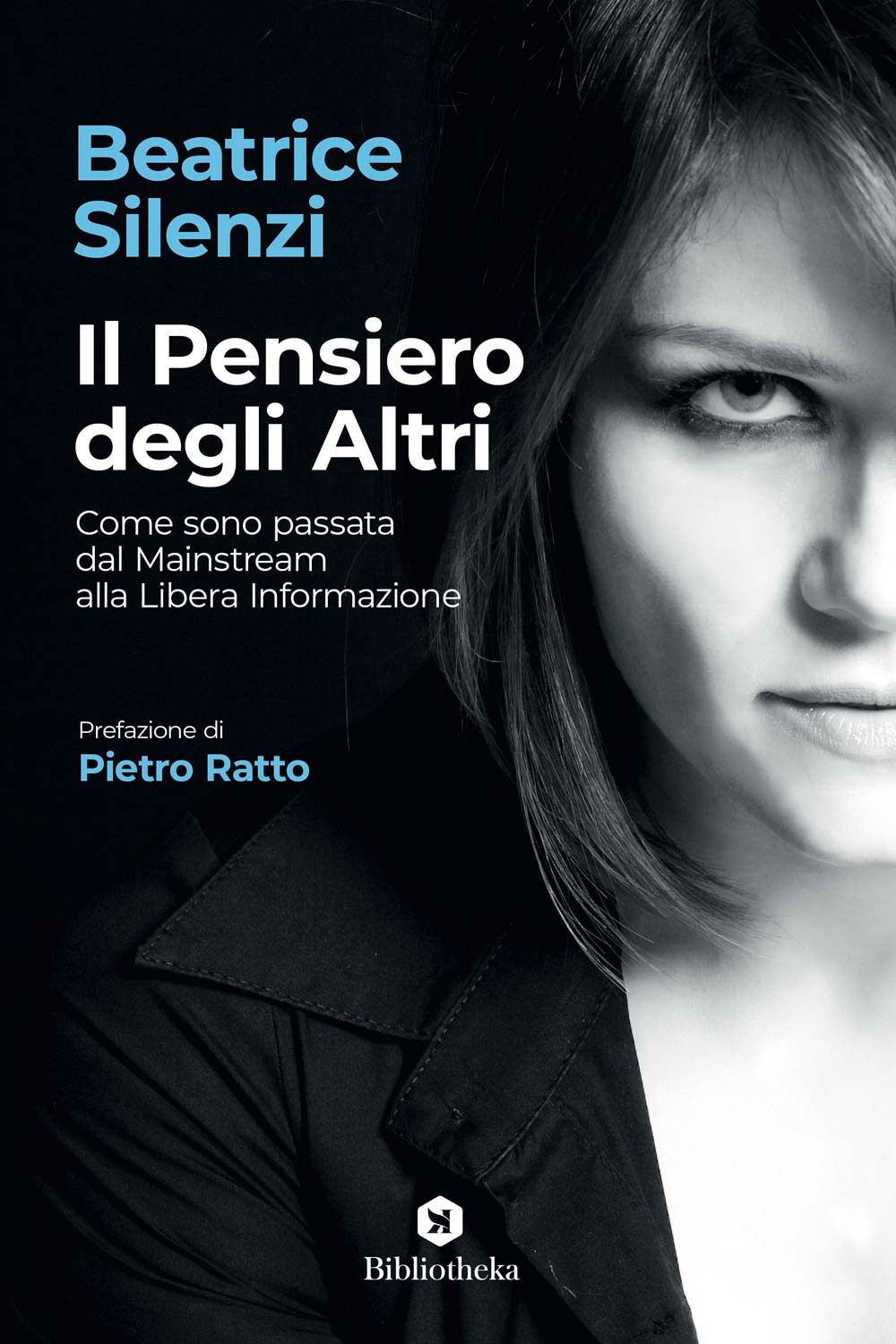Clicca per guardare il video
La rubrica Il Punto di Vista è a cura dello scrittore e giornalista Max del Papa e Beatrice Silenzi, direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
È una diagnosi senza sconti del nostro tempo il nuovo libro di Del Papa: le democrazie garantiste sono implose, sostituite da un potere verticale che pretende obbedienza “per il tuo bene”. Un atto d’accusa che attraversa politica, media, cultura, tecnologia e costume, e che nasce anche dall’esperienza personale dell’autore.
Schiavi: Dalla democrazia liberale al “paternalismo autoritario”
Al centro del libro c’è l’idea che la democrazia rappresentativa, fondata sullo Stato di diritto, sulla separazione dei poteri e su un’informazione “cerniera” tra istituzioni e cittadini, sia ormai finita. Al suo posto si afferma ciò che Del Papa chiama “autoritarismo paternalistico”: poteri “calati dall’alto” che definiscono standard di comportamento e li impongono in nome della sicurezza, della salute, dell’ambiente, dell’energia, della convivenza civile. Non più cittadini titolari di diritti e scelte, ma sudditi premiati o puniti in base alla conformità.
La parabola è raccontata senza veli e con immagini volutamente forti.
La tecnologia ha accelerato in pochi anni un processo che per un secolo non era riuscito: ha “spalmato” il conformismo, rendendolo comodo e interiorizzato.
La “tecnologia del divertimento” coincide con quella “del controllo”: piattaforme, sorveglianza, scoring, accessi condizionati. L’intelligenza artificiale diventa la faccia nuova di un’antica nevrosi: la perfezione obbligatoria.
Europa, riarmo, dissesto sociale: il quadro macro è un delirio
Del Papa descrive un continente che, tra pressioni di bilancio e fratture sociali, vive di continue emergenze. La sua è una lettura radicale e polemica, che invita però a non fermarsi ai titoli: l’autore chiede di saldare l’analisi economico-istituzionale con l’etnografia del quotidiano, dove le scelte macro producono costumi, paure, rinunce.
Fra i capitoli più netti ci sono quelli sulla cultura e sull’informazione. La cultura ha smesso di essere “vettore di libertà” — luogo dell’eresia, del rischio estetico — per diventare un mercato governato da algoritmi, brand e ritorni garantiti. Lo stesso accade ai media: l’“antica cinghia di trasmissione” tra potere e cittadini si trasforma in un “club chiuso”, dove contano appartenenze, salotti, trend, e la professionalità cede al cabaret travestito da talk. Il risultato è un’informazione che non disturba più il manovratore, ma intrattiene e allinea.
Del Papa ricorda l’epoca delle grandi inchieste economiche come momento fondativo della funzione critica del giornalismo; oggi — sostiene — l’omologazione è tale che la notizia è spesso “trascinata”, non cercata. La sua non è nostalgia sterile: è una contestazione del cortocircuito tra potere, intrattenimento e notorietà, che svuota la responsabilità pubblica del mestiere.
C’è poi una città-simbolo: Milano.
Non come capitale morale, ma come caso didascalico della deriva urbana secondo Del Papa. Tra spazi pubblici sorvegliati e una cultura “di cartapesta” che insegue il modello Dubai, l’autore vede una metropoli diventata “estrattiva”: capace di spremere multe e rendite più che di includere energie sociali. Anche qui la tesi è netta e inconciliante, e vuole colpire nel vivo un immaginario che spesso confonde glamour e qualità della vita.
In “Morte di un amore”, la lunga malattia agisce da rivelatore: le priorità cambiano, certe logiche di redazione e di palinsesto diventano inerti, la vocazione si incrina. È il momento in cui la biografia si intreccia alla diagnosi pubblica: se la democrazia è relazione adulta tra soggetti, allora la malattia — e la violenza verbale che dice di aver subito — mostrano quanto quella relazione si sia consumata.
Non è un vittimismo: è il punto di approdo di una disillusione. Del Papa rivendica la scelta di esporsi — anche quando esporsi costa — e registra il dissolversi del patto minimo di rispetto tra chi informa e chi legge. Qui il libro si fa testimonianza e, insieme, invito a misurare le parole: il linguaggio non è neutro, crea realtà.
A chi domanda “ci salveremo?”, l’autore risponde senza giri di parole: “no”. Non promette riscatti, non offre consolazioni. La sua “fine dei giochi” è il contrario del lieto fine: è una presa d’atto, forse una provocazione estrema per riaprire una discussione vera.
Perché, paradossalmente, proprio la sua conclusione pessimista riconsegna al lettore la parte che gli spetta: se l’autoritarismo paternalistico è efficace quanto indistinto, la sola resistenza possibile — suggerisce tra le righe — è ricostruire responsabilità, conflitto di idee, gusto del rischio culturale.
In questo senso Schiavi è un libro “impegnativo”, come Del Papa stesso lo definisce, e pretende lettori adulti: non chiede adesione incondizionata, ma impone di prendere posizione. Anche contro il libro, se necessario. Quel che rifiuta è l’indifferenza.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.