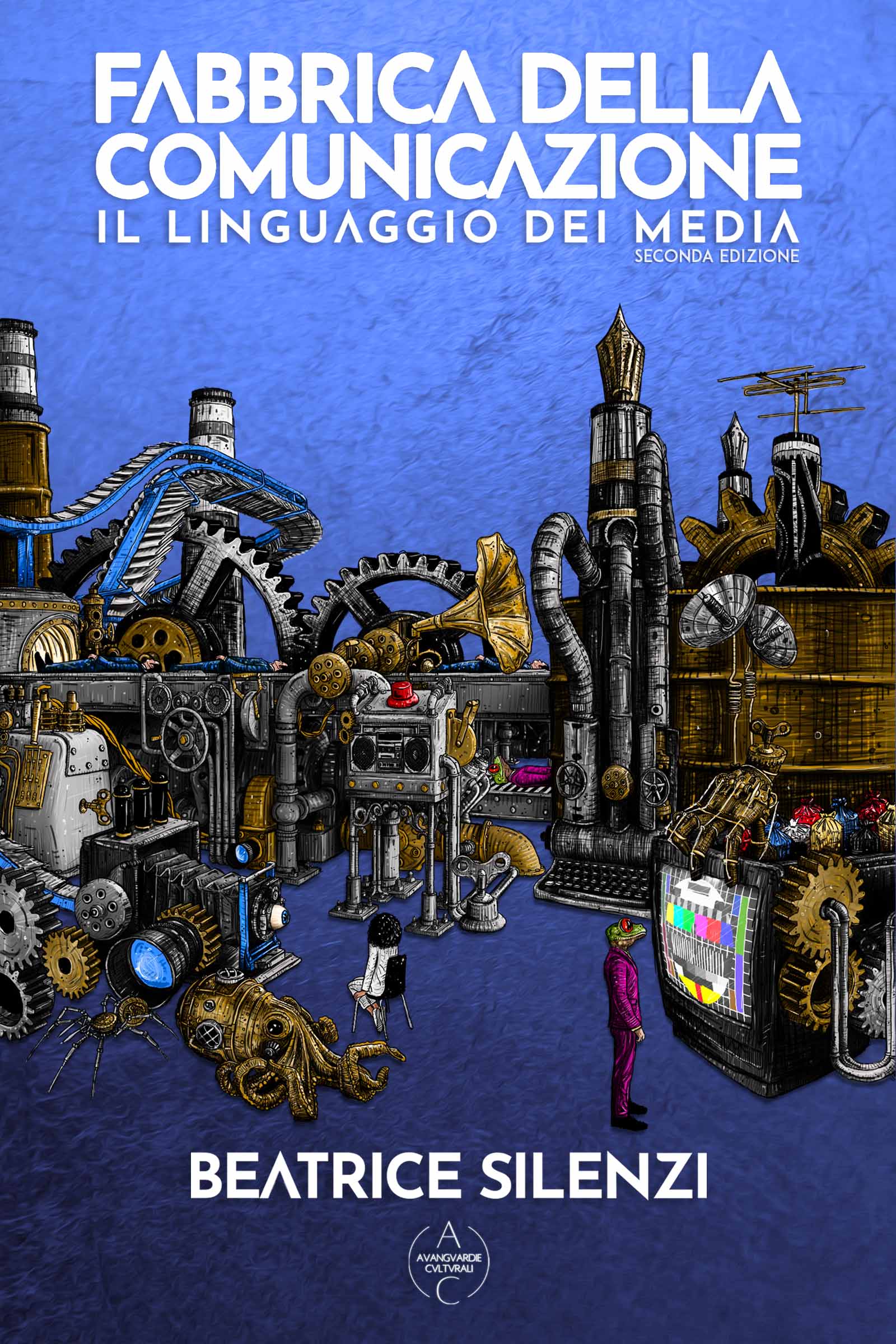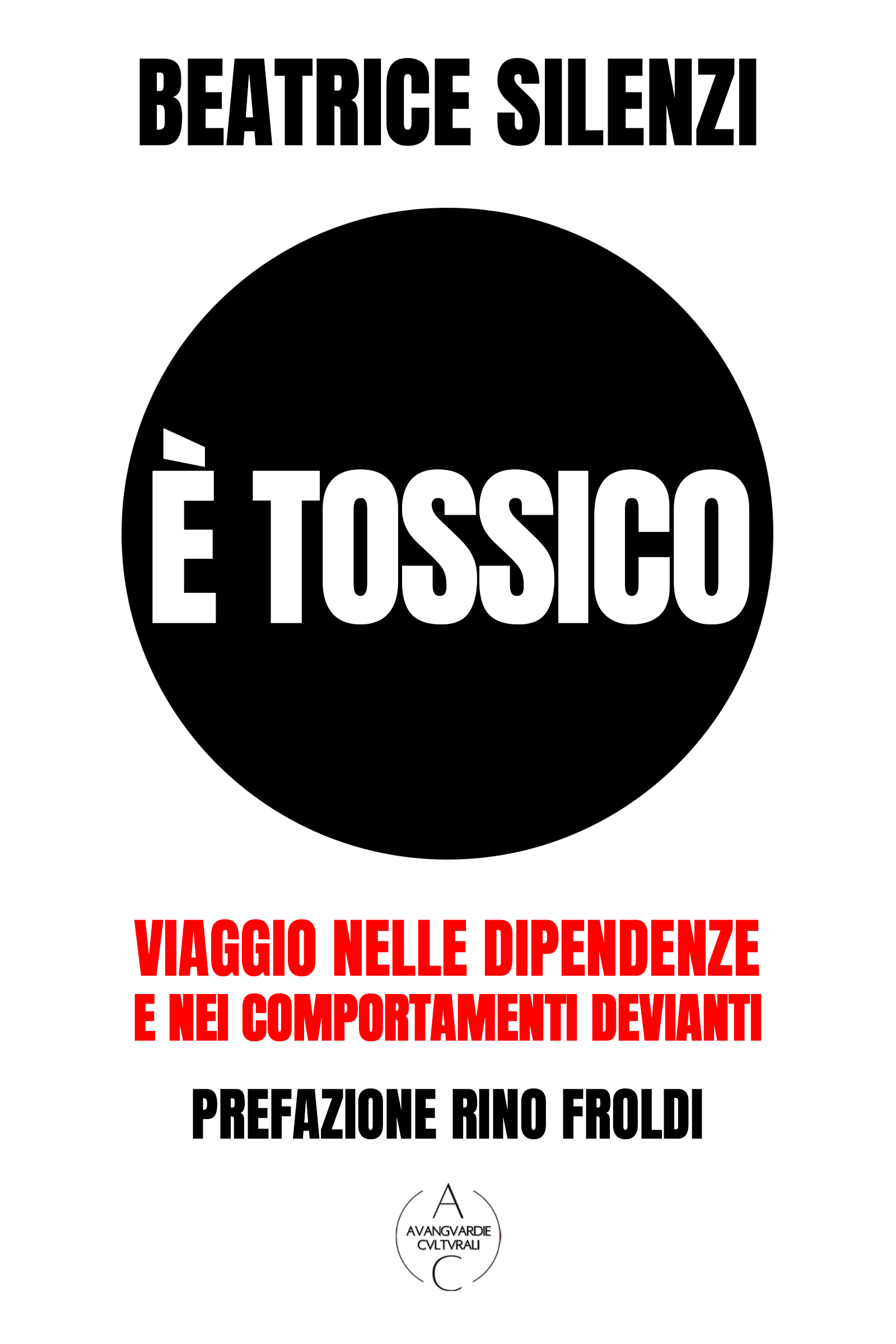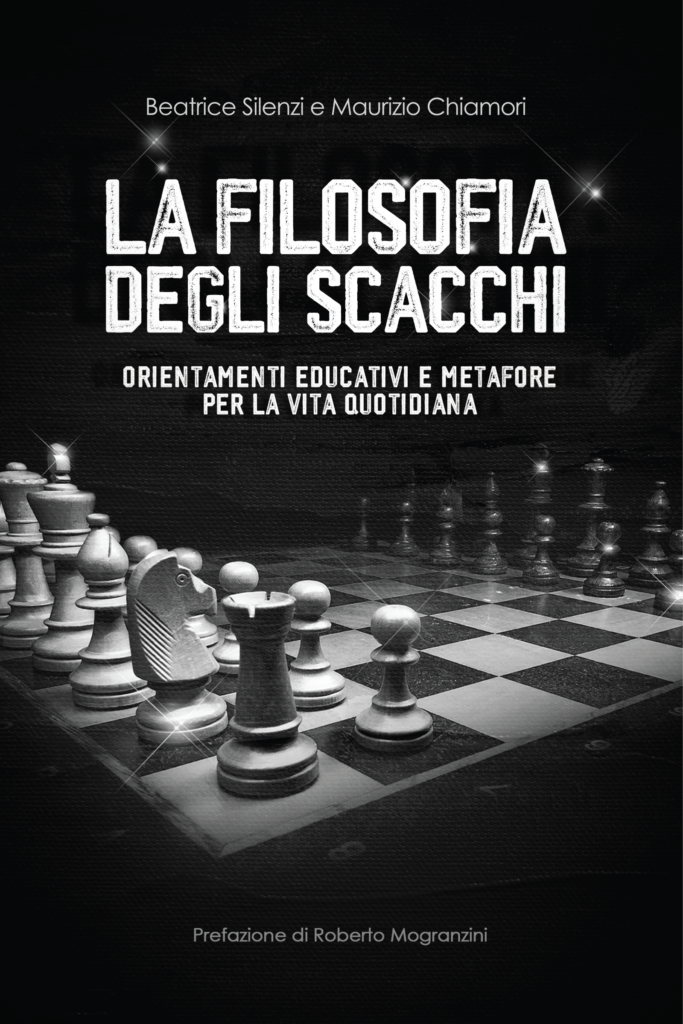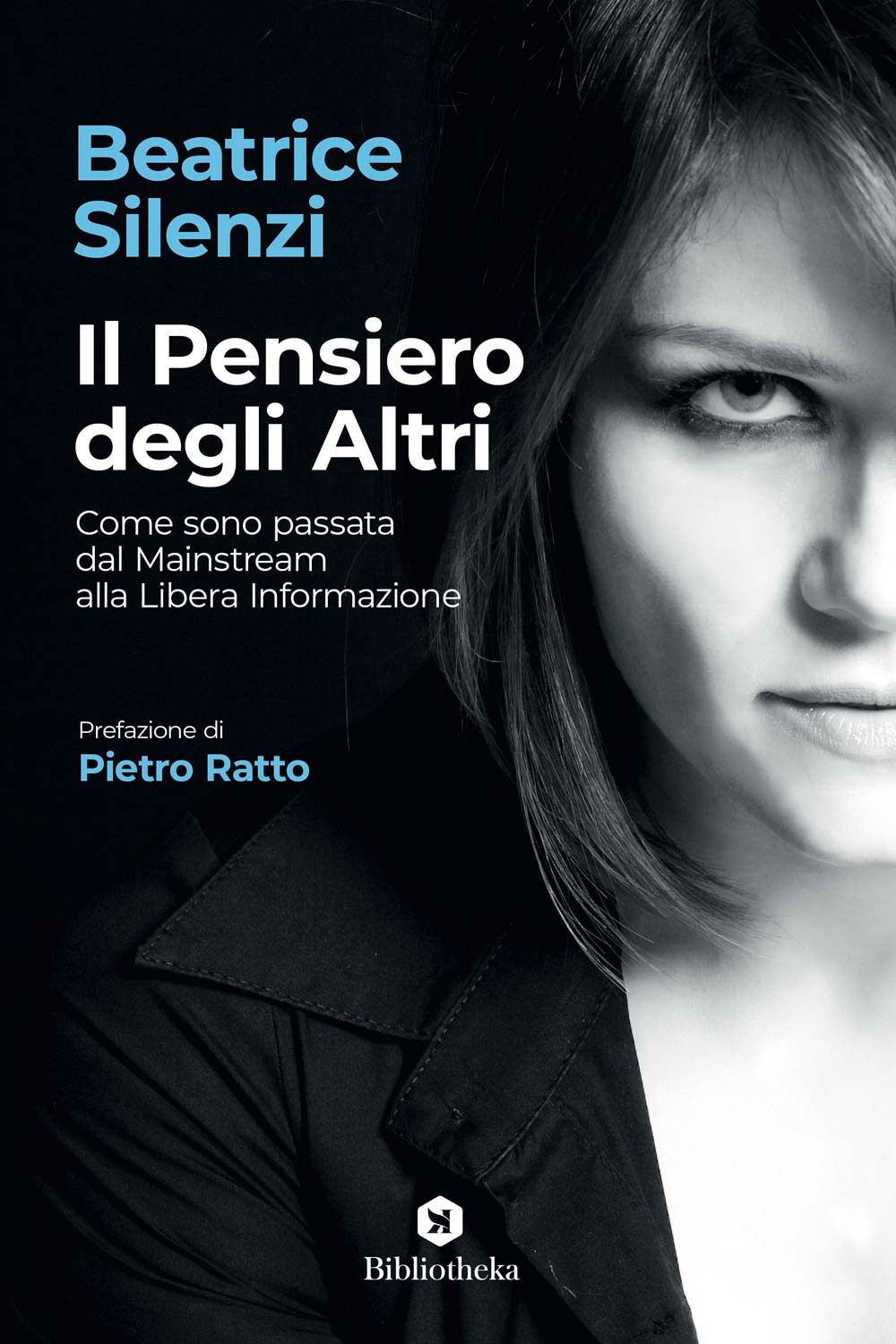Clicca per guardare il video
Su Fabbrica della Comunicazione la rubrica Libero Pensiero è cura di Beatrice Silenzi – giornalista e direttore responsabile, qui con Riccardo Magnani.
“Turismo e arte nell’era dei selfie” non è solo un titolo provocatorio, ma il punto di partenza per analizzare il rapporto conflittuale tra il turismo di massa e il patrimonio artistico, alla luce delle ricerche di Riccardo Magnani e delle nuove strategie museali come quella proposta dal Presidente Macron per la Gioconda.
Il nostro rapporto con l’arte è in crisi. Assediata da frotte di turisti armati di smartphone, l’esperienza estetica si è spesso ridotta a una caccia al selfie, a una fruizione superficiale che svuota le opere del loro significato più profondo.
Emblema di questa deriva è la Gioconda di Leonardo da Vinci, icona globale che attira milioni di visitatori al Louvre, ma che in pochi riescono a “vedere” veramente.
È in questo scenario che si inserisce la riflessione critica di Riccardo Magnani, studioso di Leonardo e voce fuori dal coro, che con le sue analisi invita a riconsiderare non solo la nostra conoscenza della storia dell’arte, ma anche il modo in cui ci approcciamo al nostro immenso patrimonio culturale.
Il grido d’allarme di Magnani sulla superficialità della fruizione artistica trova un’eco potente nella realtà quotidiana delle grandi città d’arte, soffocate da un turismo di massa che rischia di snaturarle.
File interminabili, folle oceaniche e una corsa spasmodica a “timbrare il cartellino” davanti ai monumenti più famosi trasformano la visita in un’esperienza frustrante e alienante.
Il Louvre, con i suoi quasi nove milioni di visitatori annui, è l’epicentro di questo fenomeno. In questo contesto, l’annuncio del Presidente francese Emmanuel Macron di voler spostare la Gioconda in una sala apposita, accessibile con un biglietto separato, assume un significato che va oltre la semplice riorganizzazione museale.
Tuttavia, questa soluzione solleva anche interrogativi. La creazione di un’esperienza diversificata per la Gioconda non rischia di accentuare ulteriormente la sua trasformazione in un’attrazione da parco a tema, isolandola dal contesto artistico in cui è nata e vissuta?
E l’aumento del costo del biglietto per i turisti extra-europei non introduce un ulteriore elemento di discriminazione nell’accesso alla cultura?
Il comportamento del turista moderno, ossessivamente impegnato a documentare la propria presenza piuttosto che a vivere l’esperienza, è un fenomeno che merita un’analisi più approfondita.
Il selfie davanti all’opera d’arte è diventato un rito quasi obbligatorio, un gesto che, come sottolinea Magnani, trasforma l’opera in un semplice sfondo, in un trofeo da esibire sui social network.
Si guarda l’opera attraverso lo schermo del telefono, la si vede al rovescio, ma non la si osserva.
È proprio questa trasformazione che giustifica il titolo “turismo e arte nell’era dei selfie”, un’espressione che racchiude in sé il paradosso della fruizione moderna.
Questo atteggiamento ci riporta inevitabilmente alle riflessioni di Walter Benjamin e al suo celebre saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”. La proliferazione infinita di immagini sui social media ha ulteriormente eroso l’aura dell’opera d’arte.
La Gioconda, riprodotta su ogni tipo di gadget e condivisa in milioni di selfie, è diventata un’icona pop, un’immagine familiare che quasi si fatica a riconoscere come un’opera unica e irripetibile quando ci si trova di fronte all’originale.
La “voracità delle masse”, di cui parlava Benjamin, si manifesta oggi in questa bulimia di immagini, in questo bisogno compulsivo di certificare la propria presenza, di dire “io c’ero”.
L’esistenza, come osserva amaramente Magnani, sembra essere sempre più legata all’apparire: “esisto perché sono stato lì”.
Come uscire da questa impasse?
Come recuperare un rapporto più autentico e profondo con il nostro patrimonio culturale?
La risposta, per Riccardo Magnani, risiede nell’intelligenza e nella conoscenza. Non si tratta di essere degli esperti o degli storici dell’arte, ma di coltivare un atteggiamento curioso e critico, di non fermarsi alla superficie delle cose.
È un invito a superare la pigrizia intellettuale, a cercare attivamente le chiavi di lettura che ci permettano di comprendere la complessità di un’opera d’arte, i suoi molteplici strati di significato, i suoi legami con la storia, la filosofia e la scienza.
Un’opera d’arte, ci ricorda Magnani, non è mai un oggetto isolato, ma il frutto di una cultura, di una visione del mondo.
Questo approccio richiede tempo, pazienza e umiltà.
Richiede di spegnere per un attimo lo smartphone e di accendere lo sguardo, di lasciarsi interrogare dall’opera, di entrare in un dialogo silenzioso con essa.
Significa, in fondo, riscoprire il piacere della contemplazione, un’attitudine che la nostra società frenetica e iper-connessa sembra aver dimenticato.
Il dibattito sul futuro dei nostri musei e delle nostre città d’arte è appena iniziato.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.