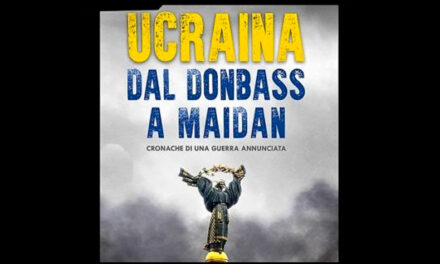Clicca per guardare il video
La rubrica Viaggio nella Storia Contemporanea è a cura dello scrittore e giornalista d’inchiesta Franco Fracassi e Beatrice Silenzi, direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.
MANDELA: VERITÀ SENZA VENDETTA
Quando pensiamo all’Apartheid, la mente corre quasi automaticamente alle immagini in bianco e nero degli anni ’60, alle rivolte di Soweto o al pugno alzato di Nelson Mandela nel 1990.
Per comprendere realmente la ferita sudafricana, bisogna riavvolgere il nastro della storia ben oltre il 1948, anno dell’istituzionalizzazione formale della segregazione.
Come spiega il giornalista d’inchiesta e scrittore Franco Fracassi, autore dell’enciclopedia Storia nei secoli brevi, le radici dell’odio razziale in Sudafrica affondano in un terreno bagnato dal sangue di una guerra dimenticata e brutale: il conflitto anglo-boero.
Tutto inizia all’alba del Novecento. In quella che Fracassi definisce una guerra che “ha cambiato il modo di fare la guerra”, l’Impero Britannico, guidato dalla brama di risorse di figure come Cecil Rhodes – un vero “Dottor Stranamore” dell’epoca – si scaglia contro i Boeri.
Questi ultimi non erano colonizzatori recenti, ma discendenti di olandesi, francesi e tedeschi insediati lì da tre secoli; contadini calvinisti che si consideravano, a tutti gli effetti, “Afrikaner”.
La brutalità britannica fu inedita.
Per piegare la resistenza boera, gli inglesi non combatterono solo gli eserciti, ma la popolazione. Inventarono i “Lager” (parola boera, non tedesca), campi di concentramento dove donne, anziani e bambini morirono a migliaia, e costrinsero i civili a marce della morte nel deserto.
Alla fine, i Boeri furono sconfitti, ma l’Impero si trovò di fronte a un dilemma: come governare una massa di bianchi umiliati e sottomessi?
La soluzione fu un patto scellerato, il vero atto di nascita dell’Apartheid.
Per placare i vinti, i vincitori concessero loro il diritto di sfruttare la maggioranza nera, fino ad allora spettatrice inascoltata del conflitto.
La segregazione nacque quindi come merce di scambio tra bianchi, sulla pelle dei neri.
In questo scenario si inserisce la figura gigantesca di Nelson Mandela. Spesso ridotto dalla cultura pop occidentale a un’icona bidimensionale, celebrato da canzoni e concerti, Mandela era in realtà molto di più.
Era, per usare le parole di Fracassi, un “partigiano per la libertà”. Prima di diventare il simbolo della pace, Mandela fu un combattente che non esitò a usare la forza e il sabotaggio contro un regime che non lasciava spazio al dialogo.
Il vero punto di svolta della sua vita, e della storia del Sudafrica, avviene però a Robben Island. Lì, in un’isola-prigione al largo di Città del Capo, Mandela trascorre 24 anni. È qui che avviene l’incontro con James Gregory, il suo carceriere boero.
Gregory è cresciuto nel mito della superiorità bianca, teme Mandela come un mostro assetato di sangue. Ma al loro primo incontro, il leader dell’ANC lo guarda negli occhi e pronuncia una frase in lingua Xhosa: “Io ti vedo”.
Non è una minaccia, è un riconoscimento. Mandela sta dicendo: “Vedo l’essere umano che sei, oltre la divisa, oltre l’odio”. Questa disarmante umanità sgretola le certezze del carceriere.
Gregory, che da bambino aveva giocato con i coetanei neri nelle fattorie, riconosce in quello sguardo una verità che aveva represso. Nel corso di due decenni, carceriere e prigioniero diventano amici, quasi una “coppia di fatto” della storia, tanto che quando iniziano le trattative segrete per la liberazione, Gregory segue Mandela nei vari trasferimenti, fino alla libertà.
Una volta presidente, Mandela pagherà gli studi ai figli del suo ex aguzzino.
La grandezza politica di Mandela si manifesta nel “dopo”. Con il 70% dei voti e un popolo che lo venerava, avrebbe potuto prendersi tutto. Avrebbe potuto, come accade in molti cambi di regime, scatenare la vendetta. Invece, sceglie la strada più difficile: la verità.
Istituisce la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, affidandola all’arcivescovo Desmond Tutu.
Il meccanismo è rivoluzionario: i carnefici – poliziotti, militari, torturatori – possono ottenere l’amnistia, ma a una condizione. Devono presentarsi davanti alle vittime e confessare tutto, pubblicamente, senza omissioni.
Per anni, questo tribunale itinerante attraversa il Sudafrica, costringendo il paese a guardare in faccia i propri demoni. Se la confessione è completa, si è liberi; se si mente, si va in galera.
Questo processo, doloroso ma catartico, ha permesso al Sudafrica di evitare il bagno di sangue che molti prevedevano, realizzando una transizione che nemmeno Gandhi in India era riuscito a garantire senza violenza.
Mandela ha capito che per costruire il futuro non si poteva cancellare il passato, ma bisognava attraversarlo insieme.
Oggi, il Sudafrica e le sue complessità sembrano spariti dai radar dei media occidentali. Fracassi conclude con un’amara riflessione sul giornalismo contemporaneo: un sistema “a singhiozzo”, che accende i riflettori solo quando serve a una narrazione geopolitica funzionale al potere, per poi spegnerli.
Si parla di guerre e crisi solo se ci toccano da vicino o se ci sono interessi in gioco, ignorando tragedie immani come quelle in Sudan o in Congo.
La lezione di Mandela, invece, ci insegna l’opposto: l’importanza di “vedere” l’altro, di non distogliere lo sguardo, e di cercare soluzioni durature, non titoli effimeri.
Una lezione di leadership e umanità che, in un mondo dominato dalla velocità e dalla superficialità, appare oggi più necessaria e rivoluzionaria che mai.
Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.
E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.